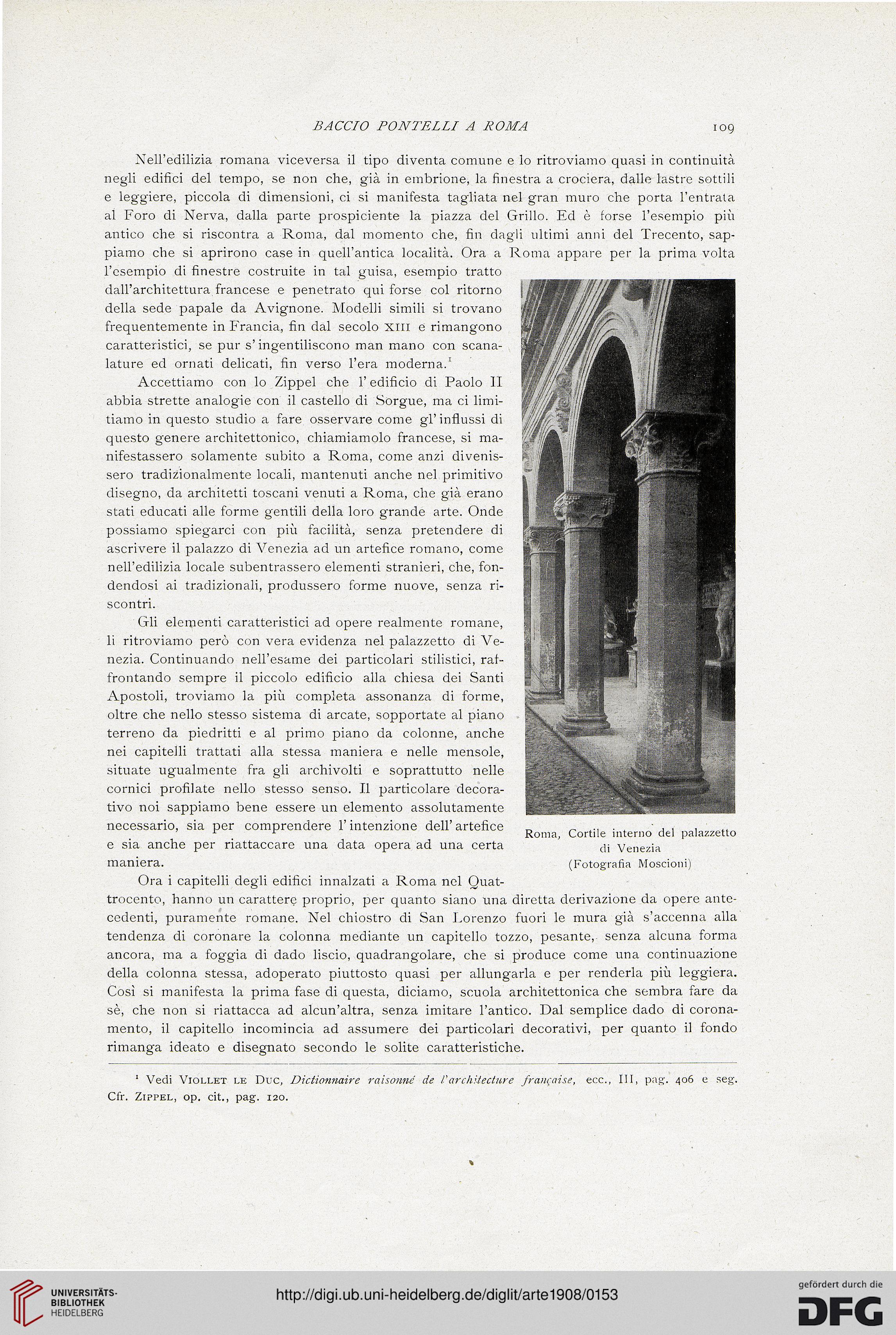BACCIO PONTELLI A ROMA
109
Nell’edilizia romana viceversa il tipo diventa comune e lo ritroviamo quasi in continuità
negli edifici del tempo, se non che, già in embrione, la finestra a crociera, dalle lastre sottili
e leggiere, piccola di dimensioni, ci si manifesta tagliata nel gran muro che porta l’entrata
al Foro di Nerva, dalla parte prospiciente la piazza del Grillo. Ed è forse l’esempio più
antico che si riscontra a Roma, dal momento che, fin dagli ultimi anni del Trecento, sap-
piamo che si aprirono case in quell’antica località. Ora a Roma appare per la prima volta
l’esempio di finestre costruite in tal guisa, esempio tratto
dall’architettura francese e penetrato qui forse col ritorno
della sede papale da Avignone. Modelli simili si trovano
frequentemente in Francia, fin dal secolo xm e rimangono
caratteristici, se pur s’ingentiliscono man mano con scana-
lature ed ornati delicati, fin verso l’era moderna.1
Accettiamo con lo Zippel che l’edificio di Paolo II
abbia strette analogie con il castello di Sorgue, ma ci limi-
tiamo in questo studio a fare osservare come gl’ influssi di
questo genere architettonico, chiamiamolo francese, si ma-
nifestassero solamente subito a Roma, come anzi divenis-
sero tradizionalmente locali, mantenuti anche nel primitivo
disegno, da architetti toscani venuti a Roma, che già erano
stati educati alle forme gentili della loro grande arte. Onde
possiamo spiegarci con più facilità, senza pretendere di
ascrivere il palazzo di Venezia ad un artefice romano, come
nell’edilizia locale subentrassero elementi stranieri, che, fon-
dendosi ai tradizionali, produssero forme nuove, senza ri-
scontri.
Gli elementi caratteristici ad opere realmente romane,
li ritroviamo però con vera evidenza nel palazzetto di Ve-
nezia. Continuando nell’esame dei particolari stilistici, raf-
frontando sempre il piccolo edificio alla chiesa dei Santi
Apostoli, troviamo la più completa assonanza di forme,
oltre che nello stesso sistema di arcate, sopportate al piano
terreno da piedritti e al primo piano da colonne, anche
nei capitelli trattati alla stessa maniera e nelle mensole,
situate ugualmente fra gli archivolti e soprattutto nelle
cornici profilate nello stesso senso. Il particolare decora-
tivo noi sappiamo bene essere un elemento assolutamente
necessario, sia per comprendere l’intenzione dell’ artefice
e sia anche per riattaccare una data opera ad una certa
maniera.
Ora i capitelli degli edifici innalzati a Roma nel Quat-
trocento, hanno un carattere proprio, per quanto siano una diretta derivazione da opere ante-
cedenti, puramente romane. Nel chiostro di San Lorenzo fuori le mura già s’accenna alla
tendenza di coronare la colonna mediante un capitello tozzo, pesante, senza alcuna forma
ancora, ma a foggia di dado liscio, quadrangolare, che si produce come una continuazione
della colonna stessa, adoperato piuttosto quasi per allungarla e per renderla più leggiera.
Così si manifesta la prima fase di questa, diciamo, scuola architettonica che sembra fare da
sè, che non si riattacca ad alcun’altra, senza imitare l’antico. Dal semplice dado di corona-
mento, il capitello incomincia ad assumere dei particolari decorativi, per quanto il fondo
rimanga ideato e disegnato secondo le solite caratteristiche.
Roma, Cortile interno del palazzetto
di Venezia
(Fotografia Moscioni)
1 Vedi Viollet le Due, Dictionnaire raìsonné de Varchitecture franfaise, ecc., Ili, pag. 406 e seg.
Cfr. Zippel, op. cit., pag. 120.
109
Nell’edilizia romana viceversa il tipo diventa comune e lo ritroviamo quasi in continuità
negli edifici del tempo, se non che, già in embrione, la finestra a crociera, dalle lastre sottili
e leggiere, piccola di dimensioni, ci si manifesta tagliata nel gran muro che porta l’entrata
al Foro di Nerva, dalla parte prospiciente la piazza del Grillo. Ed è forse l’esempio più
antico che si riscontra a Roma, dal momento che, fin dagli ultimi anni del Trecento, sap-
piamo che si aprirono case in quell’antica località. Ora a Roma appare per la prima volta
l’esempio di finestre costruite in tal guisa, esempio tratto
dall’architettura francese e penetrato qui forse col ritorno
della sede papale da Avignone. Modelli simili si trovano
frequentemente in Francia, fin dal secolo xm e rimangono
caratteristici, se pur s’ingentiliscono man mano con scana-
lature ed ornati delicati, fin verso l’era moderna.1
Accettiamo con lo Zippel che l’edificio di Paolo II
abbia strette analogie con il castello di Sorgue, ma ci limi-
tiamo in questo studio a fare osservare come gl’ influssi di
questo genere architettonico, chiamiamolo francese, si ma-
nifestassero solamente subito a Roma, come anzi divenis-
sero tradizionalmente locali, mantenuti anche nel primitivo
disegno, da architetti toscani venuti a Roma, che già erano
stati educati alle forme gentili della loro grande arte. Onde
possiamo spiegarci con più facilità, senza pretendere di
ascrivere il palazzo di Venezia ad un artefice romano, come
nell’edilizia locale subentrassero elementi stranieri, che, fon-
dendosi ai tradizionali, produssero forme nuove, senza ri-
scontri.
Gli elementi caratteristici ad opere realmente romane,
li ritroviamo però con vera evidenza nel palazzetto di Ve-
nezia. Continuando nell’esame dei particolari stilistici, raf-
frontando sempre il piccolo edificio alla chiesa dei Santi
Apostoli, troviamo la più completa assonanza di forme,
oltre che nello stesso sistema di arcate, sopportate al piano
terreno da piedritti e al primo piano da colonne, anche
nei capitelli trattati alla stessa maniera e nelle mensole,
situate ugualmente fra gli archivolti e soprattutto nelle
cornici profilate nello stesso senso. Il particolare decora-
tivo noi sappiamo bene essere un elemento assolutamente
necessario, sia per comprendere l’intenzione dell’ artefice
e sia anche per riattaccare una data opera ad una certa
maniera.
Ora i capitelli degli edifici innalzati a Roma nel Quat-
trocento, hanno un carattere proprio, per quanto siano una diretta derivazione da opere ante-
cedenti, puramente romane. Nel chiostro di San Lorenzo fuori le mura già s’accenna alla
tendenza di coronare la colonna mediante un capitello tozzo, pesante, senza alcuna forma
ancora, ma a foggia di dado liscio, quadrangolare, che si produce come una continuazione
della colonna stessa, adoperato piuttosto quasi per allungarla e per renderla più leggiera.
Così si manifesta la prima fase di questa, diciamo, scuola architettonica che sembra fare da
sè, che non si riattacca ad alcun’altra, senza imitare l’antico. Dal semplice dado di corona-
mento, il capitello incomincia ad assumere dei particolari decorativi, per quanto il fondo
rimanga ideato e disegnato secondo le solite caratteristiche.
Roma, Cortile interno del palazzetto
di Venezia
(Fotografia Moscioni)
1 Vedi Viollet le Due, Dictionnaire raìsonné de Varchitecture franfaise, ecc., Ili, pag. 406 e seg.
Cfr. Zippel, op. cit., pag. 120.