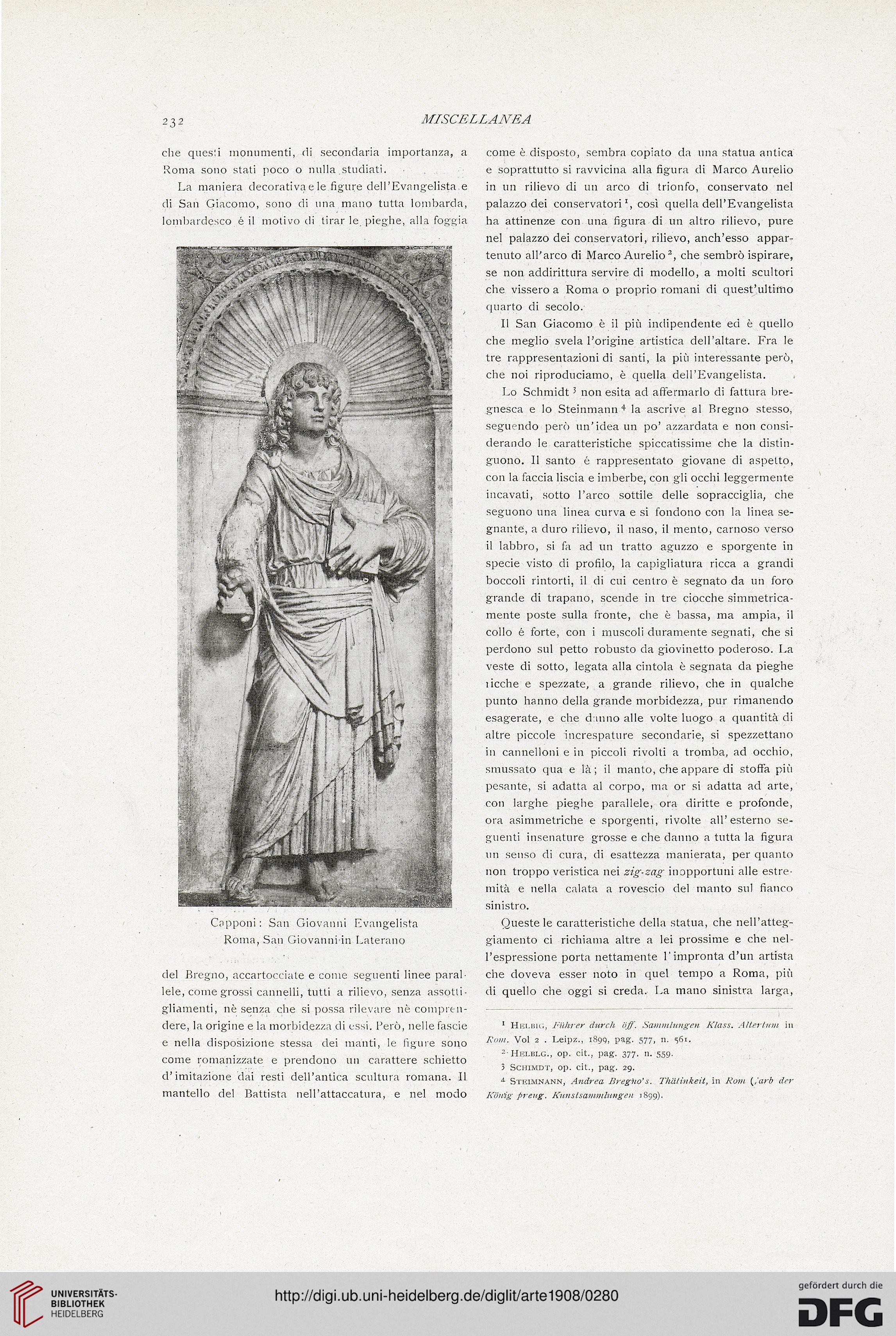MISCELLANEA
232
che questi monumenti, di secondaria importanza, a
Roma sono stati poco o nulla .studiati.
La maniera decorativa e le figure dell’Evangelista.e
rii San Giacomo, sono di una mano tutta lombarda,
lombardesco é il motivo rii tirar le pieghe, alla foggia
Capponi: San Giovanni Evangelista
Roma, San Giovanniin Laterano
del Bregno, accartocciate e come seguenti linee parai
lele, come grossi cannelli, tutti a rilievo, senza assotti-
gliamenti, nè senza che si possa rilevare nè compren-
dere, la origine e la morbidezza di essi. Però, nelle fascie
e nella disposizione stessa dei manti, le figure sono
come romanizzate e prendono un carattere schietto
d’imitazione dai resti dell’antica scultura romana. Il
mantello del Battista nell’attaccatura, e nel modo
come è disposto, sembra copiato da una statua antica
e soprattutto si ravvicina alla figura di Marco Aurelio
in un rilievo di un arco di trionfo, conservato nel
palazzo dei conservatori1, così quella dell’Evangelista
ha attinenze con una figura di un altro rilievo, pure
nel palazzo dei conservatori, rilievo, anch’esso appar-
tenuto all'arco di Marco Aurelio 2, che sembrò ispirare,
se non addirittura servire di modello, a molti scultori
che vissero a Roma o proprio romani di quest’ultimo
quarto di secolo.
Il San Giacomo è il più indipendente ed è quello
che meglio svela l’origine artistica dell’altare. Fra le
tre rappresentazioni di santi, la più interessante però,
che noi riproduciamo, è quella dell’Evangelista.
Lo Schmidt 3 non esita ad affermarlo di fattura bre-
gnesca e lo Steinmann 4 la ascrive al Bregno stesso,
seguendo però un’idea un po’ azzardata e non consi-
derando le caratteristiche spiccatissime che la distin-
guono. Il santo é rappresentato giovane di aspetto,
con la faccia liscia e imberbe, con gli occhi leggermente
incavati, sotto l’arco sottile delle sopracciglia, che
seguono una linea curva e si fondono con la linea se-
gnante, a duro rilievo, il naso, il mento, carnoso verso
il labbro, si fa ad un tratto aguzzo e sporgente in
specie visto di profilo, la capigliatura ricca a grandi
boccoli rintorti, il di cui centro è segnato da un foro
grande di trapano, scende in tre ciocche simmetrica-
mente poste sulla fronte, che è bassa, ma ampia, il
collo é forte, con i muscoli duramente segnati, che si
perdono sul petto robusto da giovinetto poderoso. La
veste di sotto, legata alla cintola è segnata da pieghe
ricche e spezzate, a grande rilievo, che in qualche
punto hanno della grande morbidezza, pur rimanendo
esagerate, e che d anno alle volte luogo a quantità di
altre piccole increspature secondarie, si spezzettano
in cannelloni e in piccoli rivolti a tromba, ad occhio,
smussato qua e là ; il manto, che appare di stoffa più
pesante, si adatta al corpo, ma or si adatta ad arte,
con larghe pieghe parallele, ora diritte e profonde,
ora asimmetriche e sporgenti, rivolte all’esterno se-
guenti insenature grosse e che danno a tutta la figura
un senso di cura, di esattezza manierata, per quanto
non troppo veristica nei zig-zag inopportuni alle estre-
mità e nella calata a rovescio del manto sul fianco
sinistro.
Queste le caratteristiche della statua, che nell’atteg-
giamento ci richiama altre a lei prossime e che nel-
l’espressione porta nettamente l’impronta d’un artista
che doveva esser noto in quel tempo a Roma, più
di quello che oggi si creda. La mano sinistra larga,
1 Helbig, Fuhrer durch off. Sammlungen Klass. Allertimi in
Rovi. Voi 2 . Leipz., 1899, pag. 577, n. 561.
2 Helblg., op. cit., pag. 377. n. 559.
3 Schimdt, op. cit., pag. 29.
A Steimnann, Andrea Bregho’s. Thatinkeit, in Rovi (/arb der
Kdnig preug. Kunstsammlungen 1899).
232
che questi monumenti, di secondaria importanza, a
Roma sono stati poco o nulla .studiati.
La maniera decorativa e le figure dell’Evangelista.e
rii San Giacomo, sono di una mano tutta lombarda,
lombardesco é il motivo rii tirar le pieghe, alla foggia
Capponi: San Giovanni Evangelista
Roma, San Giovanniin Laterano
del Bregno, accartocciate e come seguenti linee parai
lele, come grossi cannelli, tutti a rilievo, senza assotti-
gliamenti, nè senza che si possa rilevare nè compren-
dere, la origine e la morbidezza di essi. Però, nelle fascie
e nella disposizione stessa dei manti, le figure sono
come romanizzate e prendono un carattere schietto
d’imitazione dai resti dell’antica scultura romana. Il
mantello del Battista nell’attaccatura, e nel modo
come è disposto, sembra copiato da una statua antica
e soprattutto si ravvicina alla figura di Marco Aurelio
in un rilievo di un arco di trionfo, conservato nel
palazzo dei conservatori1, così quella dell’Evangelista
ha attinenze con una figura di un altro rilievo, pure
nel palazzo dei conservatori, rilievo, anch’esso appar-
tenuto all'arco di Marco Aurelio 2, che sembrò ispirare,
se non addirittura servire di modello, a molti scultori
che vissero a Roma o proprio romani di quest’ultimo
quarto di secolo.
Il San Giacomo è il più indipendente ed è quello
che meglio svela l’origine artistica dell’altare. Fra le
tre rappresentazioni di santi, la più interessante però,
che noi riproduciamo, è quella dell’Evangelista.
Lo Schmidt 3 non esita ad affermarlo di fattura bre-
gnesca e lo Steinmann 4 la ascrive al Bregno stesso,
seguendo però un’idea un po’ azzardata e non consi-
derando le caratteristiche spiccatissime che la distin-
guono. Il santo é rappresentato giovane di aspetto,
con la faccia liscia e imberbe, con gli occhi leggermente
incavati, sotto l’arco sottile delle sopracciglia, che
seguono una linea curva e si fondono con la linea se-
gnante, a duro rilievo, il naso, il mento, carnoso verso
il labbro, si fa ad un tratto aguzzo e sporgente in
specie visto di profilo, la capigliatura ricca a grandi
boccoli rintorti, il di cui centro è segnato da un foro
grande di trapano, scende in tre ciocche simmetrica-
mente poste sulla fronte, che è bassa, ma ampia, il
collo é forte, con i muscoli duramente segnati, che si
perdono sul petto robusto da giovinetto poderoso. La
veste di sotto, legata alla cintola è segnata da pieghe
ricche e spezzate, a grande rilievo, che in qualche
punto hanno della grande morbidezza, pur rimanendo
esagerate, e che d anno alle volte luogo a quantità di
altre piccole increspature secondarie, si spezzettano
in cannelloni e in piccoli rivolti a tromba, ad occhio,
smussato qua e là ; il manto, che appare di stoffa più
pesante, si adatta al corpo, ma or si adatta ad arte,
con larghe pieghe parallele, ora diritte e profonde,
ora asimmetriche e sporgenti, rivolte all’esterno se-
guenti insenature grosse e che danno a tutta la figura
un senso di cura, di esattezza manierata, per quanto
non troppo veristica nei zig-zag inopportuni alle estre-
mità e nella calata a rovescio del manto sul fianco
sinistro.
Queste le caratteristiche della statua, che nell’atteg-
giamento ci richiama altre a lei prossime e che nel-
l’espressione porta nettamente l’impronta d’un artista
che doveva esser noto in quel tempo a Roma, più
di quello che oggi si creda. La mano sinistra larga,
1 Helbig, Fuhrer durch off. Sammlungen Klass. Allertimi in
Rovi. Voi 2 . Leipz., 1899, pag. 577, n. 561.
2 Helblg., op. cit., pag. 377. n. 559.
3 Schimdt, op. cit., pag. 29.
A Steimnann, Andrea Bregho’s. Thatinkeit, in Rovi (/arb der
Kdnig preug. Kunstsammlungen 1899).