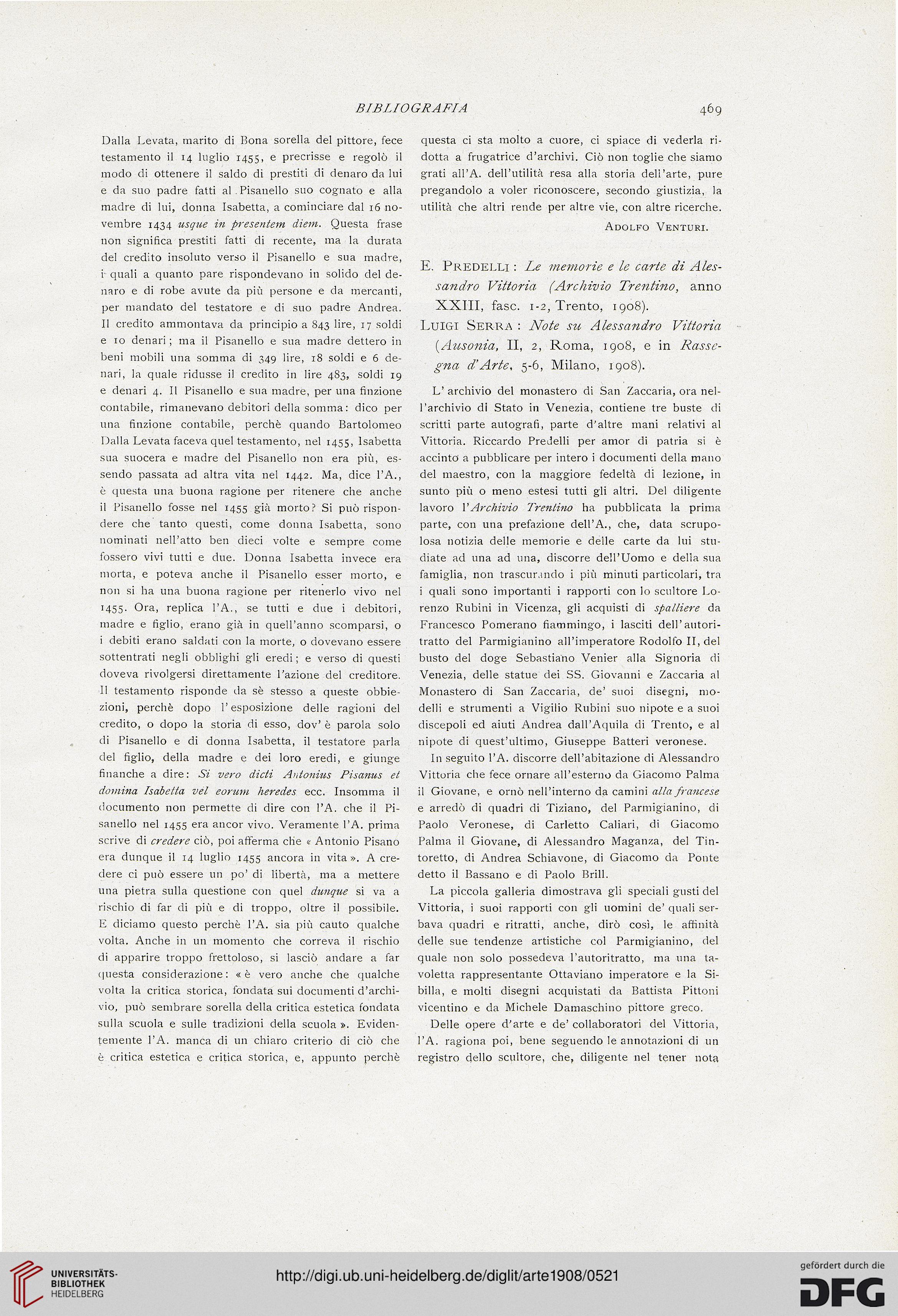BIBLIOGRAFIA
469
Dalla Levata, marito di Bona sorella del pittore, fece
testamento il 14 luglio 1455, e precrisse e regolò il
modo di ottenere il saldo di prestiti di denaro da lui
e da suo padre fatti al . Pisanello suo cognato e alla
madre di lui, donna Isabetta, a cominciare dal 16 no-
vembre 1434 usque in presentem diem. Questa frase
non significa prestiti fatti di recente, ma la durata
del credito insoluto verso il Pisanello e sua madre,
i quali a quanto pare rispondevano in solido del de-
naro e di robe avute da più persone e da mercanti,
per mandato del testatore e di suo padre Andrea.
Il credito ammontava da principio a 843 lire, 17 soldi
e io denari ; ma il Pisanello e sua madre dettero in
beni mobili una somma di 349 lire, 18 soldi e 6 de-
nari, la quale ridusse il credito in lire 483, soldi 19
e denari 4. Il Pisanello e sua madre, per una finzione
contabile, rimanevano debitori della somma : dico per
una finzione contabile, perchè quando Bartolomeo
Dalla Levata faceva quel testamento, nel 1455, Isabetta
sua suocera e madre del Pisanello non era più, es-
sendo passata ad altra vita nel 1442. Ma, dice l’A.,
è questa una buona ragione per ritenere che anche
il Pisanello fosse nel 1455 già morto? Si può rispon-
dere che tanto questi, come donna Isabetta, sono
nominati nell’atto ben dieci volte e sempre come
fossero vivi tutti e due. Donna Isabetta invece era
morta, e poteva anche il Pisanello esser morto, e
non si ha una buona ragione per ritenerlo vivo nel
1455. Ora, replica l’A., se tutti e due i debitori,
madre e figlio, erano già in quell’anno scomparsi, o
i debiti erano saldati con la morte, o dovevano essere
sottentrati negli obblighi gli eredi ; e verso di questi
doveva rivolgersi direttamente l'azione del creditore.
Il testamento risponde da sè stesso a queste obbie-
zioni, perchè dopo l’esposizione delle ragioni del
credito, o dopo la storia di esso, dov’ è parola solo
dì Pisanello e di donna Isabetta, il testatore parla
del figlio, della madre e dei loro eredi, e giunge
finanche a dire : Si vero dicti Antonius Pisanus et
domina Isabetta vel eorum heredes ecc. Insomma il
documento non permette di dire con l’A. che il Pi-
sanello nel 1455 era ancor vivo. Veramente l’A. prima
scrive di credere ciò, poi afferma che « Antonio Pisano
era dunque il 14 luglio 1455 ancora in vita». A cre-
dere ci può essere un po’ di libertà, ma a mettere
una pietra sulla questione con quel dunque si va a
rischio di far di più e di troppo, oltre il possibile.
E diciamo questo perchè l’A. sia più cauto qualche
volta. Anche in un momento che correva il rischio
di apparire troppo frettoloso, si lasciò andare a far
questa considerazione: «è vero anche che qualche
volta la critica storica, fondata sui documenti d’archi-
vio, può sembrare sorella della critica estetica fondata
sulla scuola e sulle tradizioni della scuola ». Eviden-
temente l’A. manca di un chiaro criterio di ciò che
è critica estetica e critica storica, e, appunto perchè
questa ci sta molto a cuore, ci spiace di vederla ri-
dotta a frugatrice d’archivi. Ciò non toglie che siamo
grati all’A. dell’utilità resa alla storia dell’arte, pure
pregandolo a voler riconoscere, secondo giustizia, la
utilità che altri rende per altre vie, con altre ricerche.
Adolfo Venturi.
E. Predelli : Le memorie e le carte di Ales-
sandro Vittoria (Archivio Trentino, anno
XXIII, fase. 1-2, Trento, 1908).
Luigi Serra : Note su Alessandro Vittoria
(Ausonia, II, 2, Roma, 1908, e in Rasse-
gna d’Arte, 5-6, Milano, 1908).
L’ archivio del monastero di San Zaccaria, ora nel-
l’archivio di Stato in Venezia, contiene tre buste di
scritti parte autografi, parte d’altre mani relativi al
Vittoria. Riccardo Predelli per amor di patria si è
accinto a pubblicare per intero i documenti della mano
del maestro, con la maggiore fedeltà di lezione, in
sunto più o meno estesi tutti gli altri. Del diligente
lavoro l'Archivio Trentino ha pubblicata la prima
parte, con una prefazione dell’A., che, data scrupo-
losa notizia delle memorie e delle carte da lui stu-
diate ad una ad una, discorre dell’Uomo e della sua
famiglia, non trascurando i più minuti particolari, tra
i quali sono importanti i rapporti con lo scultore Lo-
renzo Rubini in Vicenza, gli acquisti di spalliere da
Francesco Pomerano fiammingo, i lasciti dell’autori-
tratto del Parmigianino all’imperatore Rodolfo II, del
busto del doge Sebastiano Venier alla Signoria di
Venezia, delle statue dei SS. Giovanni e Zaccaria al
Monastero di San Zaccaria, de’ suoi disegni, mo-
delli e strumenti a Vigilio Rubini suo nipote e a suoi
discepoli ed aiuti Andrea dall’Aquila di Trento, e al
nipote di quest’ultimo, Giuseppe Batteri veronese.
In seguito l’A. discorre dell’abitazione di Alessandro
Vittoria che fece ornare all’esterno da Giacomo Palma
il Giovane, e ornò nell’interno da camini alla francese
e arredò di quadri di Tiziano, del Parmigianino, di
Paolo Veronese, di Cadetto Caliari, di Giacomo
Palma il Giovane, di Alessandro Maganza, del Tin-
toretto, di Andrea Schiavone, di Giacomo da Ponte
detto il Bassano e di Paolo Brill.
La piccola galleria dimostrava gli speciali gusti del
Vittoria, i suoi rapporti con gli uomini de’ quali ser-
bava quadri e ritratti, anche, dirò così, le affinità
delle sue tendenze artistiche col Parmigianino, del
quale non solo possedeva l’autoritratto, ma una ta-
voletta rappresentante Ottaviano imperatore e la Si-
billa, e molti disegni acquistati da Battista Pittoni
vicentino e da Michele Damaschino pittore greco.
Delle opere d'arte e de’ collaboratori del Vittoria,
l’A. ragiona poi, bene seguendo le annotazioni di un
registro dello scultore, che, diligente nel tener nota
469
Dalla Levata, marito di Bona sorella del pittore, fece
testamento il 14 luglio 1455, e precrisse e regolò il
modo di ottenere il saldo di prestiti di denaro da lui
e da suo padre fatti al . Pisanello suo cognato e alla
madre di lui, donna Isabetta, a cominciare dal 16 no-
vembre 1434 usque in presentem diem. Questa frase
non significa prestiti fatti di recente, ma la durata
del credito insoluto verso il Pisanello e sua madre,
i quali a quanto pare rispondevano in solido del de-
naro e di robe avute da più persone e da mercanti,
per mandato del testatore e di suo padre Andrea.
Il credito ammontava da principio a 843 lire, 17 soldi
e io denari ; ma il Pisanello e sua madre dettero in
beni mobili una somma di 349 lire, 18 soldi e 6 de-
nari, la quale ridusse il credito in lire 483, soldi 19
e denari 4. Il Pisanello e sua madre, per una finzione
contabile, rimanevano debitori della somma : dico per
una finzione contabile, perchè quando Bartolomeo
Dalla Levata faceva quel testamento, nel 1455, Isabetta
sua suocera e madre del Pisanello non era più, es-
sendo passata ad altra vita nel 1442. Ma, dice l’A.,
è questa una buona ragione per ritenere che anche
il Pisanello fosse nel 1455 già morto? Si può rispon-
dere che tanto questi, come donna Isabetta, sono
nominati nell’atto ben dieci volte e sempre come
fossero vivi tutti e due. Donna Isabetta invece era
morta, e poteva anche il Pisanello esser morto, e
non si ha una buona ragione per ritenerlo vivo nel
1455. Ora, replica l’A., se tutti e due i debitori,
madre e figlio, erano già in quell’anno scomparsi, o
i debiti erano saldati con la morte, o dovevano essere
sottentrati negli obblighi gli eredi ; e verso di questi
doveva rivolgersi direttamente l'azione del creditore.
Il testamento risponde da sè stesso a queste obbie-
zioni, perchè dopo l’esposizione delle ragioni del
credito, o dopo la storia di esso, dov’ è parola solo
dì Pisanello e di donna Isabetta, il testatore parla
del figlio, della madre e dei loro eredi, e giunge
finanche a dire : Si vero dicti Antonius Pisanus et
domina Isabetta vel eorum heredes ecc. Insomma il
documento non permette di dire con l’A. che il Pi-
sanello nel 1455 era ancor vivo. Veramente l’A. prima
scrive di credere ciò, poi afferma che « Antonio Pisano
era dunque il 14 luglio 1455 ancora in vita». A cre-
dere ci può essere un po’ di libertà, ma a mettere
una pietra sulla questione con quel dunque si va a
rischio di far di più e di troppo, oltre il possibile.
E diciamo questo perchè l’A. sia più cauto qualche
volta. Anche in un momento che correva il rischio
di apparire troppo frettoloso, si lasciò andare a far
questa considerazione: «è vero anche che qualche
volta la critica storica, fondata sui documenti d’archi-
vio, può sembrare sorella della critica estetica fondata
sulla scuola e sulle tradizioni della scuola ». Eviden-
temente l’A. manca di un chiaro criterio di ciò che
è critica estetica e critica storica, e, appunto perchè
questa ci sta molto a cuore, ci spiace di vederla ri-
dotta a frugatrice d’archivi. Ciò non toglie che siamo
grati all’A. dell’utilità resa alla storia dell’arte, pure
pregandolo a voler riconoscere, secondo giustizia, la
utilità che altri rende per altre vie, con altre ricerche.
Adolfo Venturi.
E. Predelli : Le memorie e le carte di Ales-
sandro Vittoria (Archivio Trentino, anno
XXIII, fase. 1-2, Trento, 1908).
Luigi Serra : Note su Alessandro Vittoria
(Ausonia, II, 2, Roma, 1908, e in Rasse-
gna d’Arte, 5-6, Milano, 1908).
L’ archivio del monastero di San Zaccaria, ora nel-
l’archivio di Stato in Venezia, contiene tre buste di
scritti parte autografi, parte d’altre mani relativi al
Vittoria. Riccardo Predelli per amor di patria si è
accinto a pubblicare per intero i documenti della mano
del maestro, con la maggiore fedeltà di lezione, in
sunto più o meno estesi tutti gli altri. Del diligente
lavoro l'Archivio Trentino ha pubblicata la prima
parte, con una prefazione dell’A., che, data scrupo-
losa notizia delle memorie e delle carte da lui stu-
diate ad una ad una, discorre dell’Uomo e della sua
famiglia, non trascurando i più minuti particolari, tra
i quali sono importanti i rapporti con lo scultore Lo-
renzo Rubini in Vicenza, gli acquisti di spalliere da
Francesco Pomerano fiammingo, i lasciti dell’autori-
tratto del Parmigianino all’imperatore Rodolfo II, del
busto del doge Sebastiano Venier alla Signoria di
Venezia, delle statue dei SS. Giovanni e Zaccaria al
Monastero di San Zaccaria, de’ suoi disegni, mo-
delli e strumenti a Vigilio Rubini suo nipote e a suoi
discepoli ed aiuti Andrea dall’Aquila di Trento, e al
nipote di quest’ultimo, Giuseppe Batteri veronese.
In seguito l’A. discorre dell’abitazione di Alessandro
Vittoria che fece ornare all’esterno da Giacomo Palma
il Giovane, e ornò nell’interno da camini alla francese
e arredò di quadri di Tiziano, del Parmigianino, di
Paolo Veronese, di Cadetto Caliari, di Giacomo
Palma il Giovane, di Alessandro Maganza, del Tin-
toretto, di Andrea Schiavone, di Giacomo da Ponte
detto il Bassano e di Paolo Brill.
La piccola galleria dimostrava gli speciali gusti del
Vittoria, i suoi rapporti con gli uomini de’ quali ser-
bava quadri e ritratti, anche, dirò così, le affinità
delle sue tendenze artistiche col Parmigianino, del
quale non solo possedeva l’autoritratto, ma una ta-
voletta rappresentante Ottaviano imperatore e la Si-
billa, e molti disegni acquistati da Battista Pittoni
vicentino e da Michele Damaschino pittore greco.
Delle opere d'arte e de’ collaboratori del Vittoria,
l’A. ragiona poi, bene seguendo le annotazioni di un
registro dello scultore, che, diligente nel tener nota