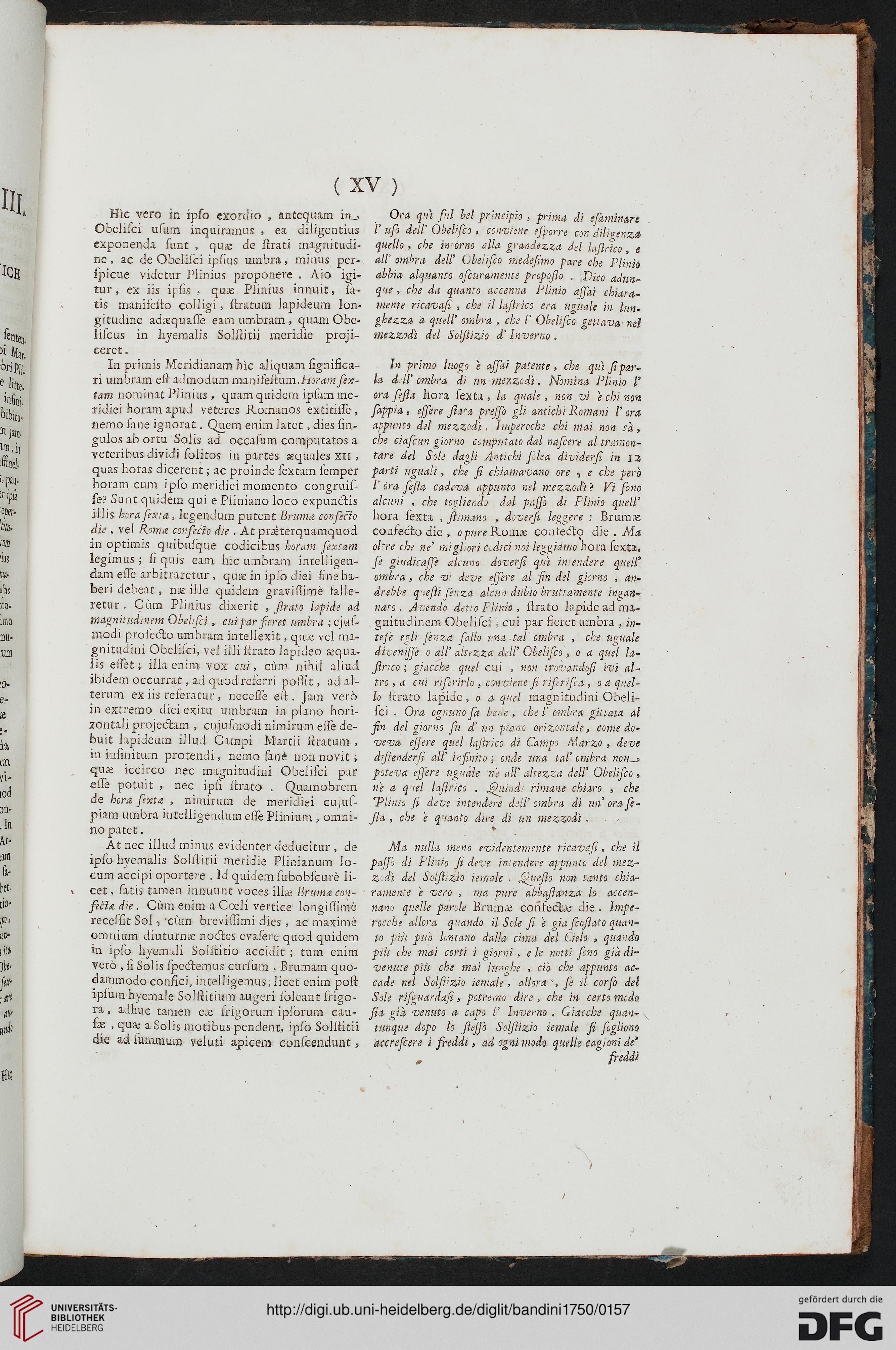( XV )
Hìc vero in ipso cxordio , antequam in_,
Obelisci usum inquiramus , ea diligentius
exponenda sunt , qu£ de strati magnitudi-
ne , ac de Obeliici ipsius umbra, minus per-
spicue videtur Plinius proponere . Aio igi-
tur , ex iis ij. sis , qua; Fiinius innuit, sa-
tis manifesto colJigi, stratum lapideum lon-
gitudine adaequasTe eam umbram , quam Obe-
liscus in hyemalis Solicini meridie proji-
ceret.
In primis Meridianam hìc aliquam lignifica-
ti umbram est admodum minifelhum.Horam sex-
tam nominat Plinius, quam quidem ipsam rae-
ridiei horam apud veteres Romanos extitisTe ,
nemo sané ignorat. Quem enim latet, dies sin-
gulos ab ortu Solis ad occasum computatos a
veteribus dividi solitos in partes aequales xn ,
quas horas dicerent ; ac proinde sextam iemper
horam cum ipso meridiei momento congruis-
se? Sunt quidem qui e Pliniano loco expuncìis
illis h:ra sexta , legendum putent Bruma consetto
die , vel Roma consetto die . At prajterquamquod
in optimis quibusque codicibus hor*m sextam
legimus ; si quis eam hìc umbram intelligen-
dam esse arbitraretur , qua; in iplo diei sine ha-
beri debeat, nx ille quidem graviffimè salie-
retur . Cùm Plinius dixerit , Jìrato lapide ad
magnhndmem Obebsci , crii par feret umbra ;ejaf-
modi proseclo umbram intellexit, quse vel ma-
gnitudini Obeliici, vel illi strato lapideo sequa-
lis eslèt ; illa enim vox cui, cùm nihil aliud
ibidem occurrat, ad quod reserri poflìt, ad al-
terum ex iis referatur, neceflè est. Jam vero
in extremo diei exitu umbram in plano hori-
zontali projectam , cujufmodi nimirum esse de-
buit lapideum ilJud Campi Martii ftratum ,
in infinitum protendi, nemo fané non novit ;
qua; iccirco nec magnitudini Obelifci par
elle potuit , nec ipfi ftrato . Quamobrem
de hora fexta , nimirum de meridiei ciijuf-
piam umbra intelligendum effe Plinium , omni-
no patet.
At nec iliud minus evidenter deducitur , de
ipfo hyemalis Solftitii meridie Plinianum Jo-
cum accipi oportere . Id quidem fubobfeurè li-
cet, fatis tamen innuunt voces illa; Bruma con-
fetta die . Cùm enim a Coeli vertice longiffimè
rccelfit Sol, xùm brevifllmi dies , ac maxime
omnium diuturna; nodìes evafere quod quidem
in ipfo hyemali Solftitio accidit ; tum enim
vero , fi Solis fpecìemus curfum , Brumam quo-
dammodo confici, intelligemus, licet enim polì
ipfum hyemale Solftitiu ri augeri foleant frigo-
la, adhuc tamen eae frigorum ipforum cau-
fae , qua: a Solis motibus pendent, ipfo Solftitii
die. ad iunimum yeluti apicem confeendunt,
Ora qui sui bel principio , prima di efamìnare
1' uso dell' Obelisco , conviene esporre con diligenza
quello, che in orno alla grandezza del lajìrico , e
all' ombra dell' Obelisco medefimo pare che Plinio
abbia alquanto ofeuramente sroposio . Dico adun-
que , che da quanto accenna Plinio assai chiara-
mente ricavasi , che il lafirico era uguale in lun-
ghezza a quell' ombra , che V Obelisco gettava nel
mezzodì del Solsiizio d'Inverno.
In primo luogo e assai patente , che qui si par-
la dAl' ombra di un mezzodì. Nomina Plinio l'
ora fesia hora sexta , la quale , non vi è chi non
sappia, ejsere siata prejso gli antichi Romani l'ora
appunto del mezzodì. huperoche chi mai non sa,
che ciaseun giorno computato dal naseere al tramon-
tare del Sole dagli Antichi silea dividersi in 12
parti uguali, che si chiamavano ore , e che però
l'óra Jefia cadeva appunto nel mezzodì ? Vi fono
alcuni , che togliendo dal passo di Plinio quell'
hora sexta , silmano , doverfi leggere : Bruma:
conseclo die , 0 pure Rom.t conrecro die. Ma
ol're che ne' mi glori c.dici noi leggiamo hora fexta,
se giudicale alcuno doversi qui invadere quell'
ombra , che v} deve ejsere al fin del giorno , an-
drebbe q'tesii senza alcun dubio bruttamente ingan-
nai . Avendo detto Plinio , ftrato lapide ad ma-
gnitudinem Obelifci -, cui par sieret umbra , in-
tere egli senza fallo ima tal ombra , che uguale
dì venisse 0 all' altezza dell' Obelisco, 0 a quel la-
sirico ; giacche quel cui , non trovandosi ivi al-
tro , a cui riserirlo , conviene fi ri sri fi a , 0 a quel-
lo ftrato lapide , 0 a quel magnitudini Obeli-
fci . Ora ognuno fa bene , che l' ombra gittata al
sin del giorno su d' un piano orizontale, come do-
veva esjere quel lajkico di Campo Marzo , deve
d'sienderfi all' infinito ; onde una tal' ombra non^>
poteva ejfere uguale ne all' altezza dell' Obelifco,
ne a quel lafirico . Quindi rimane chiaro , che
"Plinio fi deve intendere dell' ombra di un ora fe-
jìa , che e quanto dire di un mezzodì .
»
Ma nulla meno evidentemente ricavafi, che il
pajs') di Plinio fi deve imendere appunto del mez-
z d\ del Solfiizio iemale . Quefiò non tanto chia-
ramente e vero , ma pure abbafianza lo accen-
nano quelle panie Bruma; conicela; die . Impe-
rocché allora quando il Scie fi e già feofiato quan-
to più può lontano dalla cima del Cielo , quando
più che mai corti i giorni , e le notti fono già di-
venute più che mai lunghe , ciò che appunto ac-
cade nel Solfiizio iemale , allora s, fe il corfo del
Sole rìfguardafi, potremo dire , che in certo modo
fix già venuto a capo /' Inverno . Giacche quan-
tunque dopo lo siejfo Solsiizio iemale fi fogliano
accrefeere ì freddi, ad ogni modo quelle cagioni de'
freddi
Hìc vero in ipso cxordio , antequam in_,
Obelisci usum inquiramus , ea diligentius
exponenda sunt , qu£ de strati magnitudi-
ne , ac de Obeliici ipsius umbra, minus per-
spicue videtur Plinius proponere . Aio igi-
tur , ex iis ij. sis , qua; Fiinius innuit, sa-
tis manifesto colJigi, stratum lapideum lon-
gitudine adaequasTe eam umbram , quam Obe-
liscus in hyemalis Solicini meridie proji-
ceret.
In primis Meridianam hìc aliquam lignifica-
ti umbram est admodum minifelhum.Horam sex-
tam nominat Plinius, quam quidem ipsam rae-
ridiei horam apud veteres Romanos extitisTe ,
nemo sané ignorat. Quem enim latet, dies sin-
gulos ab ortu Solis ad occasum computatos a
veteribus dividi solitos in partes aequales xn ,
quas horas dicerent ; ac proinde sextam iemper
horam cum ipso meridiei momento congruis-
se? Sunt quidem qui e Pliniano loco expuncìis
illis h:ra sexta , legendum putent Bruma consetto
die , vel Roma consetto die . At prajterquamquod
in optimis quibusque codicibus hor*m sextam
legimus ; si quis eam hìc umbram intelligen-
dam esse arbitraretur , qua; in iplo diei sine ha-
beri debeat, nx ille quidem graviffimè salie-
retur . Cùm Plinius dixerit , Jìrato lapide ad
magnhndmem Obebsci , crii par feret umbra ;ejaf-
modi proseclo umbram intellexit, quse vel ma-
gnitudini Obeliici, vel illi strato lapideo sequa-
lis eslèt ; illa enim vox cui, cùm nihil aliud
ibidem occurrat, ad quod reserri poflìt, ad al-
terum ex iis referatur, neceflè est. Jam vero
in extremo diei exitu umbram in plano hori-
zontali projectam , cujufmodi nimirum esse de-
buit lapideum ilJud Campi Martii ftratum ,
in infinitum protendi, nemo fané non novit ;
qua; iccirco nec magnitudini Obelifci par
elle potuit , nec ipfi ftrato . Quamobrem
de hora fexta , nimirum de meridiei ciijuf-
piam umbra intelligendum effe Plinium , omni-
no patet.
At nec iliud minus evidenter deducitur , de
ipfo hyemalis Solftitii meridie Plinianum Jo-
cum accipi oportere . Id quidem fubobfeurè li-
cet, fatis tamen innuunt voces illa; Bruma con-
fetta die . Cùm enim a Coeli vertice longiffimè
rccelfit Sol, xùm brevifllmi dies , ac maxime
omnium diuturna; nodìes evafere quod quidem
in ipfo hyemali Solftitio accidit ; tum enim
vero , fi Solis fpecìemus curfum , Brumam quo-
dammodo confici, intelligemus, licet enim polì
ipfum hyemale Solftitiu ri augeri foleant frigo-
la, adhuc tamen eae frigorum ipforum cau-
fae , qua: a Solis motibus pendent, ipfo Solftitii
die. ad iunimum yeluti apicem confeendunt,
Ora qui sui bel principio , prima di efamìnare
1' uso dell' Obelisco , conviene esporre con diligenza
quello, che in orno alla grandezza del lajìrico , e
all' ombra dell' Obelisco medefimo pare che Plinio
abbia alquanto ofeuramente sroposio . Dico adun-
que , che da quanto accenna Plinio assai chiara-
mente ricavasi , che il lafirico era uguale in lun-
ghezza a quell' ombra , che V Obelisco gettava nel
mezzodì del Solsiizio d'Inverno.
In primo luogo e assai patente , che qui si par-
la dAl' ombra di un mezzodì. Nomina Plinio l'
ora fesia hora sexta , la quale , non vi è chi non
sappia, ejsere siata prejso gli antichi Romani l'ora
appunto del mezzodì. huperoche chi mai non sa,
che ciaseun giorno computato dal naseere al tramon-
tare del Sole dagli Antichi silea dividersi in 12
parti uguali, che si chiamavano ore , e che però
l'óra Jefia cadeva appunto nel mezzodì ? Vi fono
alcuni , che togliendo dal passo di Plinio quell'
hora sexta , silmano , doverfi leggere : Bruma:
conseclo die , 0 pure Rom.t conrecro die. Ma
ol're che ne' mi glori c.dici noi leggiamo hora fexta,
se giudicale alcuno doversi qui invadere quell'
ombra , che v} deve ejsere al fin del giorno , an-
drebbe q'tesii senza alcun dubio bruttamente ingan-
nai . Avendo detto Plinio , ftrato lapide ad ma-
gnitudinem Obelifci -, cui par sieret umbra , in-
tere egli senza fallo ima tal ombra , che uguale
dì venisse 0 all' altezza dell' Obelisco, 0 a quel la-
sirico ; giacche quel cui , non trovandosi ivi al-
tro , a cui riserirlo , conviene fi ri sri fi a , 0 a quel-
lo ftrato lapide , 0 a quel magnitudini Obeli-
fci . Ora ognuno fa bene , che l' ombra gittata al
sin del giorno su d' un piano orizontale, come do-
veva esjere quel lajkico di Campo Marzo , deve
d'sienderfi all' infinito ; onde una tal' ombra non^>
poteva ejfere uguale ne all' altezza dell' Obelifco,
ne a quel lafirico . Quindi rimane chiaro , che
"Plinio fi deve intendere dell' ombra di un ora fe-
jìa , che e quanto dire di un mezzodì .
»
Ma nulla meno evidentemente ricavafi, che il
pajs') di Plinio fi deve imendere appunto del mez-
z d\ del Solfiizio iemale . Quefiò non tanto chia-
ramente e vero , ma pure abbafianza lo accen-
nano quelle panie Bruma; conicela; die . Impe-
rocché allora quando il Scie fi e già feofiato quan-
to più può lontano dalla cima del Cielo , quando
più che mai corti i giorni , e le notti fono già di-
venute più che mai lunghe , ciò che appunto ac-
cade nel Solfiizio iemale , allora s, fe il corfo del
Sole rìfguardafi, potremo dire , che in certo modo
fix già venuto a capo /' Inverno . Giacche quan-
tunque dopo lo siejfo Solsiizio iemale fi fogliano
accrefeere ì freddi, ad ogni modo quelle cagioni de'
freddi