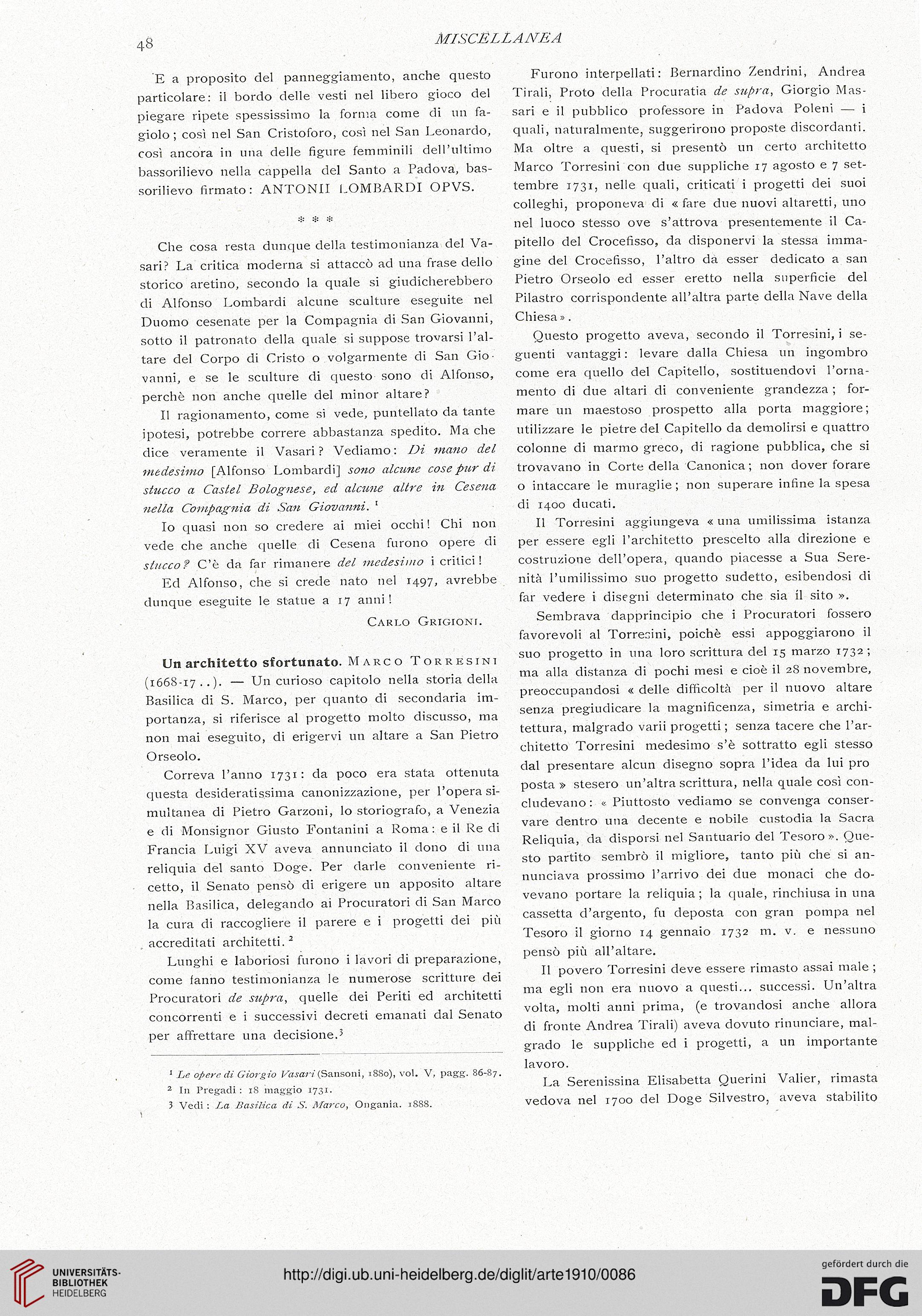48
MISCELLANEA
E a proposito del panneggiamento, anche questo
particolare: il bordo delle vesti nel libero gioco del
piegare ripete spessissimo la forma come di un fa-
giolo ; così nel San Cristoforo, così nel San Leonardo,
così ancora in una delle figure femminili dell’ultimo
bassorilievo nella cappella del Santo a Padova, bas-
sorilievo firmato: ANTONII LOMBARDI OPVS.
Che cosa resta dunque della testimonianza del Va-
sari ? La critica moderna si attaccò ad una frase dello
storico aretino, secondo la quale si giudicherebbero
di Alfonso Lombardi alcune sculture eseguite nel
Duomo cesenate per la Compagnia di San Giovanni,
sotto il patronato della quale si suppose trovarsi l’al-
tare del Corpo di Cristo o volgarmente di San Gio-
vanni, e se le sculture di questo sono di Alfonso,
perchè non anche quelle del minor altare?
Il ragionamento, come si vede, puntellato da tante
ipotesi, potrebbe correre abbastanza spedito. Ma che
dice veramente il Vasari? Vediamo: Di mano del
medesimo [Alfonso Lombardi] sono alcune cose pur di
stucco a Castel Bolognese, ed alcune altre in Cesena
nella Compagnia di San Giovanni. 1
Io quasi non so credere ai miei occhi ! Chi non
vede che anche quelle di Cesena furono opere di
stucco? C’è da far rimanere del medesimo i critici!
Ed Alfonso, che si crede nato nel 1497, avrebbe
dunque eseguite le statue a 17 anni!
Carlo Grigionl
Un architetto sfortunato. Marco T or resini
(1668-17..). — Un curioso capitolo nella storia della
Basilica di S. Marco, per quanto di secondaria im-
portanza, si riferisce al progetto molto discusso, ma
non mai eseguito, di erigervi un altare a San Pietro
Orseolo.
Correva l’anno 1731 : da poco era stata ottenuta
questa desideratissima canonizzazione, per l’opera si-
multanea di Pietro Garzoni, lo storiografo, a Venezia
e di Monsignor Giusto Fontanini a Roma : e il Re di
Francia Luigi XV aveva annunciato il dono di una
reliquia del santo Doge. Per darle conveniente ri-
cetto, il Senato pensò di erigere un apposito altare
nella Basilica, delegando ai Procuratori di San Marco
la cura di raccogliere il parere e i progetti dei più
accreditati architetti.2 3
Lunghi e laboriosi furono i lavori di preparazione,
come fanno testimonianza le numerose scritture dei
Procuratori de supra, quelle dei Periti ed architetti
concorrenti e i successivi decreti emanati dal Senato
per affrettare una decisione.5
1 Le opere di Giorgio Vasari (Sansoni, 1880), voi. V, pagg. 86-87.
2 In Pregaci! : 18 maggio 1731.
3 Vedi : La Basilica di S. Marco, Ongania. 1888.
Furono interpellati: Bernardino Zendrini, Andrea
Tirali, Proto della Procuratia de supra, Giorgio Mas-
sari e il pubblico professore in Padova Poleni — i
quali, naturalmente, suggerirono proposte discordanti.
Ma oltre a questi, si presentò un certo architetto
Marco Torresini con due suppliche 17 agosto e 7 set-
tembre 1731, nelle quali, criticati i progetti dei suoi
colleghi, proponeva di «fare due nuovi altaretti, uno
nel luoco stesso ove s’attrova presentemente il Ca-
pitello del Crocefisso, da disponervi la stessa imma-
gine del Crocefisso, l’altro da esser dedicato a san
Pietro Orseolo ed esser eretto nella superficie del
Pilastro corrispondente all’altra parte della Nave della
Chiesa ».
Questo progetto aveva, secondo il Torresini, i se-
guenti vantaggi : levare dalla Chiesa un ingombro
come era quello del Capitello, sostituendovi l’orna-
mento di due altari di conveniente grandezza ; for-
mare un maestoso prospetto alla porta maggiore;
utilizzare le pietre del Capitello da demolirsi e quattro
colonne di marmo greco, di ragione pubblica, che si
trovavano in Corte della Canonica ; non dover forare
o intaccare le muraglie; non superare infine la spesa
di 1400 ducati.
Il Torresini aggiungeva « una umilissima istanza
per essere egli l’architetto prescelto alla direzione e
costruzione dell’opera, quando piacesse a Sua Sere-
nità l’umilissimo suo progetto sudetto, esibendosi di
far vedere i disegni determinato che sia il sito ».
Sembrava dapprincipio che i Procuratori fossero
favorevoli al Torresini, poiché essi appoggiarono il
suo progetto in una loro scrittura del 15 marzo 1732;
ma alla distanza di pochi mesi e cioè il 28 novembre,
preoccupandosi « delle difficoltà per il nuovo altare
senza pregiudicare la magnificenza, simetria e archi-
tettura, malgrado varii progetti ; senza tacere che l’ar-
chitetto Torresini medesimo s’è sottratto egli stesso
dal presentare alcun disegno sopra l’idea da lui prò
posta » stesero un’altra scrittura, nella quale così con-
cludevano : « Piuttosto vediamo se convenga conser-
vare dentro una decente e nobile custodia la Sacra
Reliquia, da disporsi nel Santuario del Tesoro». Que-
sto partito sembrò il migliore, tanto più che si an-
nunciava prossimo l’arrivo dei due monaci che do-
vevano portare la reliquia; la quale, rinchiusa in una
cassetta d’argento, fu deposta con gran pompa nel
Tesoro il giorno 14 gennaio 1732 m. v. e nessuno
pensò più all’altare.
Il povero Torresini deve essere rimasto assai male ;
ma egli non era nuovo a questi... successi. Un’altra
volta, molti anni prima, (e trovandosi anche allora
di fronte Andrea Tirali) aveva dovuto rinunciare, mal-
grado le suppliche ed i progetti, a un importante
lavoro.
La Serenissina Elisabetta Querini Valier, rimasta
vedova nel 1700 del Doge Silvestro, aveva stabilito
MISCELLANEA
E a proposito del panneggiamento, anche questo
particolare: il bordo delle vesti nel libero gioco del
piegare ripete spessissimo la forma come di un fa-
giolo ; così nel San Cristoforo, così nel San Leonardo,
così ancora in una delle figure femminili dell’ultimo
bassorilievo nella cappella del Santo a Padova, bas-
sorilievo firmato: ANTONII LOMBARDI OPVS.
Che cosa resta dunque della testimonianza del Va-
sari ? La critica moderna si attaccò ad una frase dello
storico aretino, secondo la quale si giudicherebbero
di Alfonso Lombardi alcune sculture eseguite nel
Duomo cesenate per la Compagnia di San Giovanni,
sotto il patronato della quale si suppose trovarsi l’al-
tare del Corpo di Cristo o volgarmente di San Gio-
vanni, e se le sculture di questo sono di Alfonso,
perchè non anche quelle del minor altare?
Il ragionamento, come si vede, puntellato da tante
ipotesi, potrebbe correre abbastanza spedito. Ma che
dice veramente il Vasari? Vediamo: Di mano del
medesimo [Alfonso Lombardi] sono alcune cose pur di
stucco a Castel Bolognese, ed alcune altre in Cesena
nella Compagnia di San Giovanni. 1
Io quasi non so credere ai miei occhi ! Chi non
vede che anche quelle di Cesena furono opere di
stucco? C’è da far rimanere del medesimo i critici!
Ed Alfonso, che si crede nato nel 1497, avrebbe
dunque eseguite le statue a 17 anni!
Carlo Grigionl
Un architetto sfortunato. Marco T or resini
(1668-17..). — Un curioso capitolo nella storia della
Basilica di S. Marco, per quanto di secondaria im-
portanza, si riferisce al progetto molto discusso, ma
non mai eseguito, di erigervi un altare a San Pietro
Orseolo.
Correva l’anno 1731 : da poco era stata ottenuta
questa desideratissima canonizzazione, per l’opera si-
multanea di Pietro Garzoni, lo storiografo, a Venezia
e di Monsignor Giusto Fontanini a Roma : e il Re di
Francia Luigi XV aveva annunciato il dono di una
reliquia del santo Doge. Per darle conveniente ri-
cetto, il Senato pensò di erigere un apposito altare
nella Basilica, delegando ai Procuratori di San Marco
la cura di raccogliere il parere e i progetti dei più
accreditati architetti.2 3
Lunghi e laboriosi furono i lavori di preparazione,
come fanno testimonianza le numerose scritture dei
Procuratori de supra, quelle dei Periti ed architetti
concorrenti e i successivi decreti emanati dal Senato
per affrettare una decisione.5
1 Le opere di Giorgio Vasari (Sansoni, 1880), voi. V, pagg. 86-87.
2 In Pregaci! : 18 maggio 1731.
3 Vedi : La Basilica di S. Marco, Ongania. 1888.
Furono interpellati: Bernardino Zendrini, Andrea
Tirali, Proto della Procuratia de supra, Giorgio Mas-
sari e il pubblico professore in Padova Poleni — i
quali, naturalmente, suggerirono proposte discordanti.
Ma oltre a questi, si presentò un certo architetto
Marco Torresini con due suppliche 17 agosto e 7 set-
tembre 1731, nelle quali, criticati i progetti dei suoi
colleghi, proponeva di «fare due nuovi altaretti, uno
nel luoco stesso ove s’attrova presentemente il Ca-
pitello del Crocefisso, da disponervi la stessa imma-
gine del Crocefisso, l’altro da esser dedicato a san
Pietro Orseolo ed esser eretto nella superficie del
Pilastro corrispondente all’altra parte della Nave della
Chiesa ».
Questo progetto aveva, secondo il Torresini, i se-
guenti vantaggi : levare dalla Chiesa un ingombro
come era quello del Capitello, sostituendovi l’orna-
mento di due altari di conveniente grandezza ; for-
mare un maestoso prospetto alla porta maggiore;
utilizzare le pietre del Capitello da demolirsi e quattro
colonne di marmo greco, di ragione pubblica, che si
trovavano in Corte della Canonica ; non dover forare
o intaccare le muraglie; non superare infine la spesa
di 1400 ducati.
Il Torresini aggiungeva « una umilissima istanza
per essere egli l’architetto prescelto alla direzione e
costruzione dell’opera, quando piacesse a Sua Sere-
nità l’umilissimo suo progetto sudetto, esibendosi di
far vedere i disegni determinato che sia il sito ».
Sembrava dapprincipio che i Procuratori fossero
favorevoli al Torresini, poiché essi appoggiarono il
suo progetto in una loro scrittura del 15 marzo 1732;
ma alla distanza di pochi mesi e cioè il 28 novembre,
preoccupandosi « delle difficoltà per il nuovo altare
senza pregiudicare la magnificenza, simetria e archi-
tettura, malgrado varii progetti ; senza tacere che l’ar-
chitetto Torresini medesimo s’è sottratto egli stesso
dal presentare alcun disegno sopra l’idea da lui prò
posta » stesero un’altra scrittura, nella quale così con-
cludevano : « Piuttosto vediamo se convenga conser-
vare dentro una decente e nobile custodia la Sacra
Reliquia, da disporsi nel Santuario del Tesoro». Que-
sto partito sembrò il migliore, tanto più che si an-
nunciava prossimo l’arrivo dei due monaci che do-
vevano portare la reliquia; la quale, rinchiusa in una
cassetta d’argento, fu deposta con gran pompa nel
Tesoro il giorno 14 gennaio 1732 m. v. e nessuno
pensò più all’altare.
Il povero Torresini deve essere rimasto assai male ;
ma egli non era nuovo a questi... successi. Un’altra
volta, molti anni prima, (e trovandosi anche allora
di fronte Andrea Tirali) aveva dovuto rinunciare, mal-
grado le suppliche ed i progetti, a un importante
lavoro.
La Serenissina Elisabetta Querini Valier, rimasta
vedova nel 1700 del Doge Silvestro, aveva stabilito