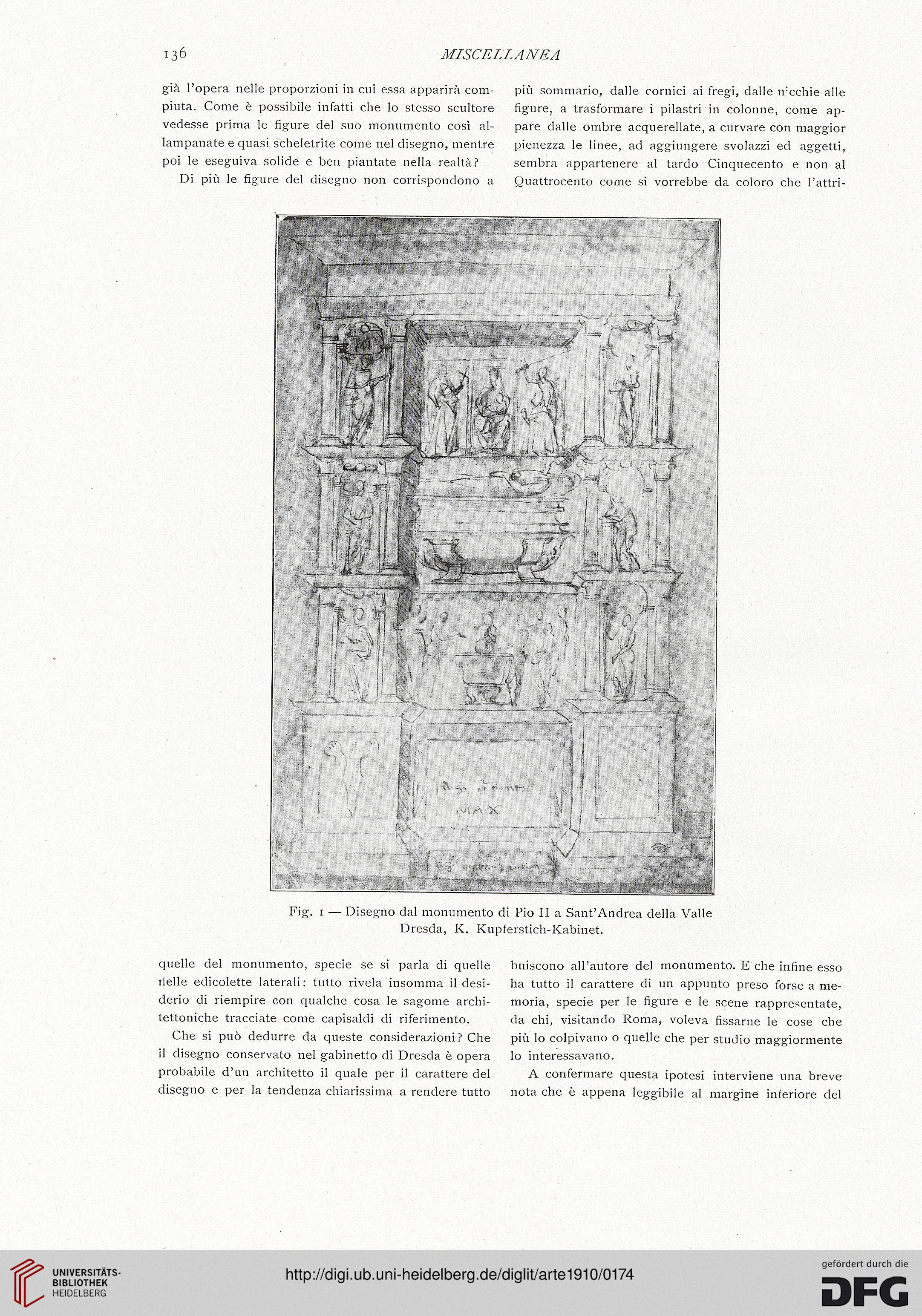136
MISCELLANEA
già l’opera nelle proporzioni in cui essa apparirà com-
piuta. Come è possibile infatti che lo stesso scultore
vedesse prima le figure del suo monumento così al-
lampanate e quasi scheletrite come nel disegno, mentre
poi le eseguiva solide e ben piantate nella realtà?
Di più le figure del disegno non corrispondono a
più sommario, dalle cornici ai fregi, dalle mcchie alle
figure, a trasformare i pilastri in colonne, come ap-
pare dalle ombre acquerellate, a curvare con maggior
pienezza le linee, ad aggiungere svolazzi ed aggetti,
sembra appartenere al tardo Cinquecento e non al
Quattrocento come si vorrebbe da coloro che l’attri-
Fig. r — Disegno dal monumento di Pio II a Sant’Andrea della Valle
Dresda, K. Kupferstich-Kabinet.
quelle del monumento, specie se si parla di quelle
rtelle edicolette laterali: tutto rivela insomma il desi-
derio di riempire con qualche cosa le sagome archi-
tettoniche tracciate come capisaldi di riferimento.
Che si può dedurre da queste considerazioni ? Che
il disegno conservato nel gabinetto di Dresda è opera
probabile d’un architetto il quale per il carattere del
disegno e per la tendenza chiarissima a rendere tutto
buiscono all’autore del monumento. E che infine esso
ha tutto il carattere di un appunto preso forse a me-
moria, specie per le figure e le scene rappresentate,
da chi, visitando Roma, voleva fissarne le cose che
più lo colpivano o quelle che per studio maggiormente
lo interessavano.
A confermare questa ipotesi interviene una breve
nota che è appena leggibile al margine inferiore del
MISCELLANEA
già l’opera nelle proporzioni in cui essa apparirà com-
piuta. Come è possibile infatti che lo stesso scultore
vedesse prima le figure del suo monumento così al-
lampanate e quasi scheletrite come nel disegno, mentre
poi le eseguiva solide e ben piantate nella realtà?
Di più le figure del disegno non corrispondono a
più sommario, dalle cornici ai fregi, dalle mcchie alle
figure, a trasformare i pilastri in colonne, come ap-
pare dalle ombre acquerellate, a curvare con maggior
pienezza le linee, ad aggiungere svolazzi ed aggetti,
sembra appartenere al tardo Cinquecento e non al
Quattrocento come si vorrebbe da coloro che l’attri-
Fig. r — Disegno dal monumento di Pio II a Sant’Andrea della Valle
Dresda, K. Kupferstich-Kabinet.
quelle del monumento, specie se si parla di quelle
rtelle edicolette laterali: tutto rivela insomma il desi-
derio di riempire con qualche cosa le sagome archi-
tettoniche tracciate come capisaldi di riferimento.
Che si può dedurre da queste considerazioni ? Che
il disegno conservato nel gabinetto di Dresda è opera
probabile d’un architetto il quale per il carattere del
disegno e per la tendenza chiarissima a rendere tutto
buiscono all’autore del monumento. E che infine esso
ha tutto il carattere di un appunto preso forse a me-
moria, specie per le figure e le scene rappresentate,
da chi, visitando Roma, voleva fissarne le cose che
più lo colpivano o quelle che per studio maggiormente
lo interessavano.
A confermare questa ipotesi interviene una breve
nota che è appena leggibile al margine inferiore del