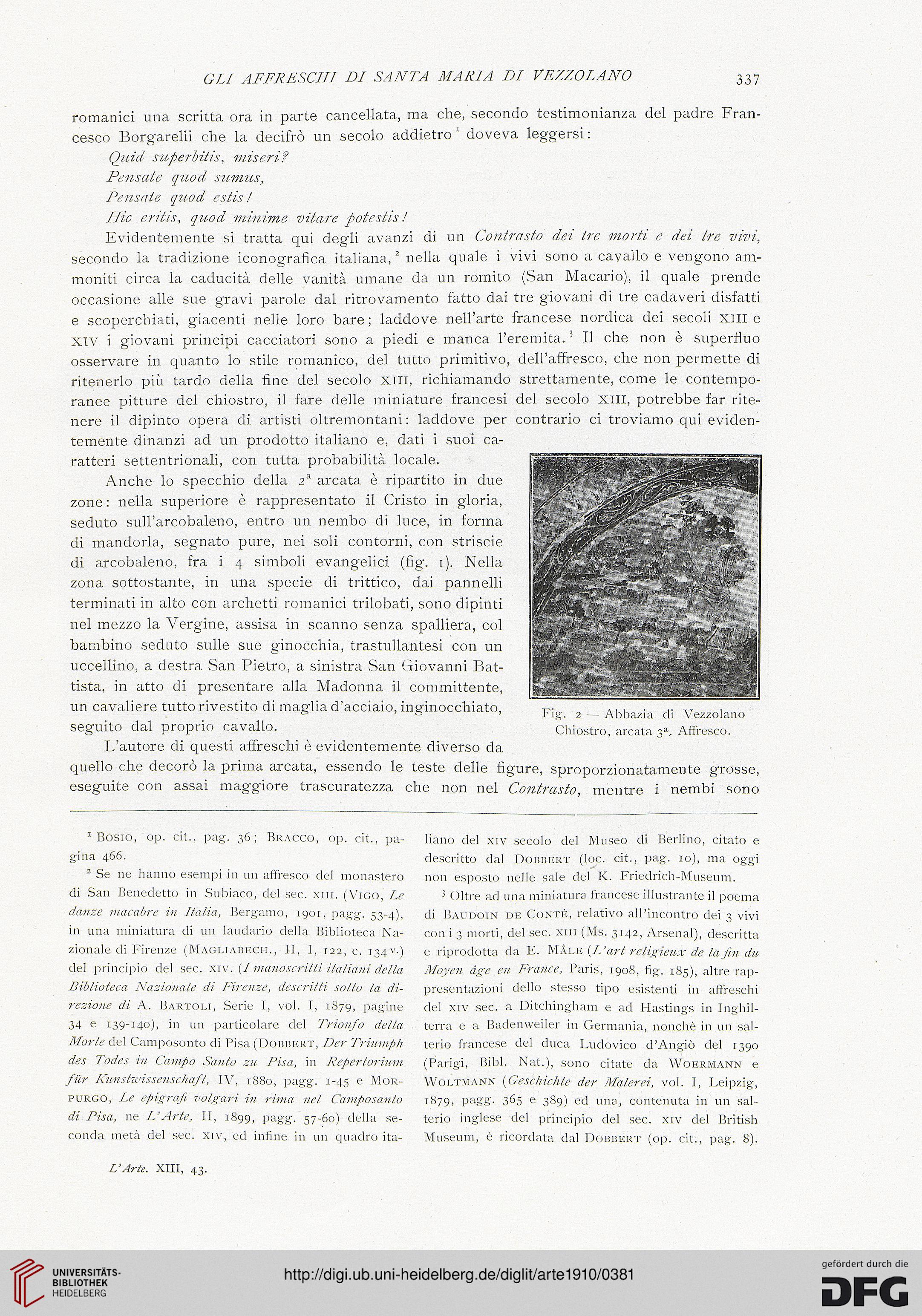GLI AFFRESCHI DI SANTA MARIA DI VEZZOLANO
337
romanici una scritta ora in parte cancellata, ma che, secondo testimonianza del padre Fran-
cesco Borgarelli che la decifrò un secolo addietro1 doveva leggersi:
Quid superbitis, miseri?
Pensate quod sumus,
Pensate quod estis !
Hic eritis, quod minime vitate potestis !
Evidentemente si tratta qui degli avanzi di un Contrasto dei tre morti e dei tre vivi,
secondo la tradizione iconografica italiana,2 nella quale i vivi sono a cavallo e vengono am-
moniti circa la caducità delle vanità umane da un romito (San Macario), il quale prende
occasione alle sue gravi parole dal ritrovamento fatto dai tre giovani di tre cadaveri disfatti
e scoperchiati, giacenti nelle loro bare; laddove nell’arte francese nordica dei secoli xm e
XIV i giovani principi cacciatori sono a piedi e manca l’eremita.3 II che non è superfluo
osservare in quanto lo stile romanico, del tutto primitivo, dell’affresco, che non permette di
ritenerlo più tardo della fine del secolo xm, richiamando strettamente, come le contempo-
ranee pitture del chiostro, il fare delle miniature francesi del secolo XIII, potrebbe far rite-
nere il dipinto opera di artisti oltremontani: laddove per contrario ci troviamo qui eviden-
temente dinanzi ad un prodotto italiano e, dati i suoi ca-
ratteri settentrionali, con tutta probabilità locale.
Anche lo specchio della 2a arcata è ripartito in due
zone: nella superiore è rappresentato il Cristo in gloria,
seduto sull’arcobaleno, entro un nembo di luce, in forma
di mandorla, segnato pure, nei soli contorni, con striscie
di arcobaleno, fra i 4 simboli evangelici (fig. 1). Nella
zona sottostante, in una specie di trittico, dai pannelli
terminati in alto con archetti romanici trilobati, sono dipinti
nel mezzo la Vergine, assisa in scanno senza spalliera, col
bambino sedato sulle sue ginocchia, trastullantesi con un
uccellino, a destra San Pietro, a sinistra San Giovanni Bat-
tista, in atto di presentare alla Madonna il committente,
un cavaliere tutto rivestito di maglia d’acciaio, inginocchiato,
seguito dal proprio cavallo.
L’autore di questi affreschi è evidentemente diverso da
quello che decorò la prima arcata, essendo le teste delle figure, sproporzionatamente grosse,
eseguite con assai maggiore trascuratezza che non nel Contrasto, mentre i nembi sono
1 Bosio, op. cil., pag. 36; Bracco, op. cit., pa-
gina 466.
2 Se ne hanno esempi in un affresco del monastero
di San Benedetto in Subiaco, del sec. xm, (Vigo, Le
danze macabre in Italia, Bergamo, 1901, pagg. 53-4),
in una miniatura di un laudario della Biblioteca Na-
zionale di Firenze (Magliabeci-i., II, I, 122, c. 134v-)
del principio del sec. xiv. (/ manoscritti italiani'della
Biblioteca Nazionale di Firenze, descritti sotto la di-
rezione di A. Bartoli, Serie I, voi. I, 1879, pagine
34 e 139-140), in un particolare del Trionfo della
Morte del Camposonto di Pisa (Dobbert, Der Triumpfi-
de s Todes in Campo Santo zu Pisa, in Repertorium
fùr Kunstwissenschaft, IV, 1880, pagg. 1-45 e Mor-
purgo, Le epigrafi volgari in rima nel Camposanto
di Pisa, ne L’Arte, II, 1899, pagg. 57-60) della se-
conda metà del sec. xiv, ed infine in un quadro ita-
liano del xiv secolo del Museo di Berlino, citato e
descritto dal Dobbert (loc. cit., pag. io), ma oggi
non esposto nelle sale del K. Friedrich-Museum.
5 Oltre ad una miniatura francese illustrante il poema
di Baudoin de Conte, relativo all’incontro dei 3 vivi
con i 3 morti, del sec. xm (Ms. 3142, Arsenal), descritta
e riprodotta da E. Male (L’art religieux de la fin da
Moyen dge en France, Paris, 1908, fig. 185), altre rap-
presentazioni dello stesso tipo esistenti in affreschi
del xiv sec. a Ditchingham e ad Hastings in Inghil-
terra e a Badenweiler in Germania, nonché in un sal-
terio francese del duca Ludovico d’Angiò del 1390
(Parigi, Bibl. Nat.), sono citate da Woermann e
Woltmann (Geschichte der Malerei, voi. 1, Leipzig,
1879, pagg. 365 e 389) ed una, contenuta in un sal-
terio inglese del principio del sec. xiv del British
Museum, è ricordata dal Dobbert (op. cit., pag. 8).
L’Arte. XIII, 43.
337
romanici una scritta ora in parte cancellata, ma che, secondo testimonianza del padre Fran-
cesco Borgarelli che la decifrò un secolo addietro1 doveva leggersi:
Quid superbitis, miseri?
Pensate quod sumus,
Pensate quod estis !
Hic eritis, quod minime vitate potestis !
Evidentemente si tratta qui degli avanzi di un Contrasto dei tre morti e dei tre vivi,
secondo la tradizione iconografica italiana,2 nella quale i vivi sono a cavallo e vengono am-
moniti circa la caducità delle vanità umane da un romito (San Macario), il quale prende
occasione alle sue gravi parole dal ritrovamento fatto dai tre giovani di tre cadaveri disfatti
e scoperchiati, giacenti nelle loro bare; laddove nell’arte francese nordica dei secoli xm e
XIV i giovani principi cacciatori sono a piedi e manca l’eremita.3 II che non è superfluo
osservare in quanto lo stile romanico, del tutto primitivo, dell’affresco, che non permette di
ritenerlo più tardo della fine del secolo xm, richiamando strettamente, come le contempo-
ranee pitture del chiostro, il fare delle miniature francesi del secolo XIII, potrebbe far rite-
nere il dipinto opera di artisti oltremontani: laddove per contrario ci troviamo qui eviden-
temente dinanzi ad un prodotto italiano e, dati i suoi ca-
ratteri settentrionali, con tutta probabilità locale.
Anche lo specchio della 2a arcata è ripartito in due
zone: nella superiore è rappresentato il Cristo in gloria,
seduto sull’arcobaleno, entro un nembo di luce, in forma
di mandorla, segnato pure, nei soli contorni, con striscie
di arcobaleno, fra i 4 simboli evangelici (fig. 1). Nella
zona sottostante, in una specie di trittico, dai pannelli
terminati in alto con archetti romanici trilobati, sono dipinti
nel mezzo la Vergine, assisa in scanno senza spalliera, col
bambino sedato sulle sue ginocchia, trastullantesi con un
uccellino, a destra San Pietro, a sinistra San Giovanni Bat-
tista, in atto di presentare alla Madonna il committente,
un cavaliere tutto rivestito di maglia d’acciaio, inginocchiato,
seguito dal proprio cavallo.
L’autore di questi affreschi è evidentemente diverso da
quello che decorò la prima arcata, essendo le teste delle figure, sproporzionatamente grosse,
eseguite con assai maggiore trascuratezza che non nel Contrasto, mentre i nembi sono
1 Bosio, op. cil., pag. 36; Bracco, op. cit., pa-
gina 466.
2 Se ne hanno esempi in un affresco del monastero
di San Benedetto in Subiaco, del sec. xm, (Vigo, Le
danze macabre in Italia, Bergamo, 1901, pagg. 53-4),
in una miniatura di un laudario della Biblioteca Na-
zionale di Firenze (Magliabeci-i., II, I, 122, c. 134v-)
del principio del sec. xiv. (/ manoscritti italiani'della
Biblioteca Nazionale di Firenze, descritti sotto la di-
rezione di A. Bartoli, Serie I, voi. I, 1879, pagine
34 e 139-140), in un particolare del Trionfo della
Morte del Camposonto di Pisa (Dobbert, Der Triumpfi-
de s Todes in Campo Santo zu Pisa, in Repertorium
fùr Kunstwissenschaft, IV, 1880, pagg. 1-45 e Mor-
purgo, Le epigrafi volgari in rima nel Camposanto
di Pisa, ne L’Arte, II, 1899, pagg. 57-60) della se-
conda metà del sec. xiv, ed infine in un quadro ita-
liano del xiv secolo del Museo di Berlino, citato e
descritto dal Dobbert (loc. cit., pag. io), ma oggi
non esposto nelle sale del K. Friedrich-Museum.
5 Oltre ad una miniatura francese illustrante il poema
di Baudoin de Conte, relativo all’incontro dei 3 vivi
con i 3 morti, del sec. xm (Ms. 3142, Arsenal), descritta
e riprodotta da E. Male (L’art religieux de la fin da
Moyen dge en France, Paris, 1908, fig. 185), altre rap-
presentazioni dello stesso tipo esistenti in affreschi
del xiv sec. a Ditchingham e ad Hastings in Inghil-
terra e a Badenweiler in Germania, nonché in un sal-
terio francese del duca Ludovico d’Angiò del 1390
(Parigi, Bibl. Nat.), sono citate da Woermann e
Woltmann (Geschichte der Malerei, voi. 1, Leipzig,
1879, pagg. 365 e 389) ed una, contenuta in un sal-
terio inglese del principio del sec. xiv del British
Museum, è ricordata dal Dobbert (op. cit., pag. 8).
L’Arte. XIII, 43.