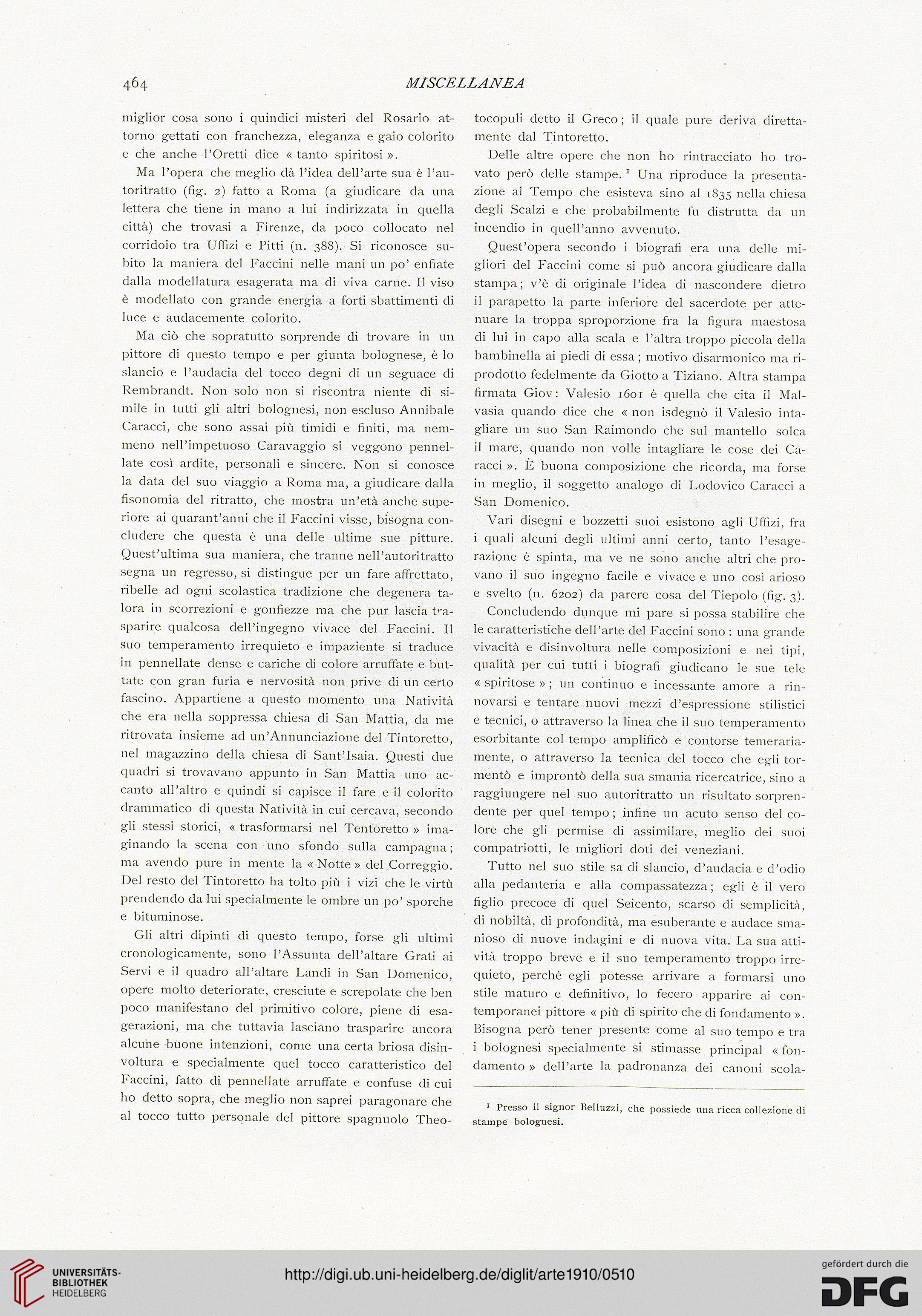464
MISCELLANEA
miglior cosa sono i quindici misteri del Rosario at-
torno gettati con franchezza, eleganza e gaio colorito
e che anche LO retti dice « tanto spiritosi ».
Ma l’opera che meglio dà l’idea dell’arte sua è l’au-
toritratto (fìg. 2) fatto a Roma (a giudicare da una
lettera che tiene in mano a lui indirizzata in quella
città) che trovasi a Firenze, da poco collocato nel
corridoio tra Uffizi e Pitti (n. 388). Si riconosce su-
bito la maniera del Faccini nelle mani un po’ enfiate
dalla modellatura esagerata ma di viva carne. Il viso
è modellato con grande energia a forti sbattimenti di
luce e audacemente colorito.
Ma ciò che sopratutto sorprende di trovare in un
pittore di questo tempo e per giunta bolognese, è lo
slancio e l’audacia del tocco degni di un seguace di
Rembrandt. Non solo non si riscontra niente di si-
mile in tutti gli altri bolognesi, non escluso Annibaie
Caracci, che sono assai più timidi e finiti, ma nem-
meno nell’impetuoso Caravaggio si veggono pennel-
late così ardite, personali e sincere. Non si conosce
la data del suo viaggio a Roma ma, a giudicare dalla
fisonomia del ritratto, che mostra un’età anche supe-
riore ai quarant’anni che il Faccini visse, bisogna con-
cludere che questa è una delle ultime sue pitture.
Quest’ultima sua maniera, che tranne nell’autoritratto
segna un regresso, si distingue per un fare affrettato,
ribelle ad ogni scolastica tradizione che degenera ta-
lora in scorrezioni e gonfiezze ma che pur lascia tra-
sparire qualcosa dell’ingegno vivace del Faccini. Il
suo temperamento irrequieto e impaziente si traduce
in pennellate dense e cariche di colore arruffate e but-
tate con gran furia e nervosità non prive di un certo
fascino. Appartiene a questo momento una Natività
che era nella soppressa chiesa di San Mattia, da me
ritrovata insieme ad un’Annunciazione del 'Tintoretto,
nel magazzino della chiesa di Sant’Isaia. Questi due
quadri si trovavano appunto in San Mattia uno ac-
canto all’altro e quindi si capisce il fare e il colorito
drammatico di questa Natività in cui cercava, secondo
gli stessi storici, « trasformarsi nel Tenforetto » ima-
ginando la scena con uno sfondo sulla campagna ;
ma avendo pure in mente la «Notte» del Correggio.
Del resto del Tintoretto ha tolto più i vizi che le virtù
prendendo da lui specialmente le ombre un po’ sporche
e bituminose.
Gli altri dipinti di questo tempo, forse gli ultimi
cronologicamente, sono PAssunta dell’altare Grati ai
Servi e il quadro all’altare Landi in San Domenico,
opere molto deteriorate, cresciute e screpolate che ben
poco manifestano del primitivo colore, piene di esa-
gerazioni, ma che tuttavia lasciano trasparire ancora
alcune buone intenzioni, come una certa briosa disin-
voltura e specialmente quel tocco caratteristico del
Faccini, fatto di pennellate arruffate e confuse di cui
ho detto sopra, che meglio non saprei paragonare che
al tocco tutto personale del pittore spagnuolo Theo-
tocopuli detto il Greco ; il quale pure deriva diretta-
mente dal Tintoretto.
Delle altre opere che non ho rintracciato ho tro-
vato però delle stampe. 1 Una riproduce la presenta-
zione al Tempo che esisteva sino al 1835 nella chiesa
degli Scalzi e che probabilmente fu distrutta da un
incendio in quell’anno avvenuto.
Quest’opera secondo i biografi era una delle mi-
gliori del Faccini come si può ancora giudicare dalla
stampa ; v’è di originale l’idea di nascondere dietro
il parapetto la parte inferiore del sacerdote per atte-
nuare la troppa sproporzione fra la figura maestosa
di lui in capo alla scala e l’altra troppo piccola della
bambinella ai piedi di essa ; motivo disarmonico ma ri-
prodotto fedelmente da Giotto a Tiziano. Altra stampa
firmata Giov : Valesio 1601 è quella che cita il Mal-
vasia quando dice che « non isdegnò il Valesio inta-
gliare un suo San Raimondo che sul mantello solca
il mare, quando non volle intagliare le cose dei Ca-
racci ». E buona composizione che ricorda, ma forse
in meglio, il soggetto analogo di Lodovico Caracci a
San Domenico.
Vari disegni e bozzetti suoi esistono agli Uffizi, fra
i quali alcuni degli ultimi anni certo, tanto l’esage-
razione è spinta, ma ve ne sono anche altri che pro-
vano il suo ingegno facile e vivace e uno così arioso
e svelto (n. 6202) da parere cosa del Tiepolo (fig. 3).
Concludendo dunque mi pare si possa stabilire che
le caratteristiche dell’arte del Faccini sono : una grande
vivacità e disinvoltura nelle composizioni e nei tipi,
qualità per cui tutti i biografi giudicano le sue tele
« spiritose » ; un continuo e incessante amore a rin-
novarsi e tentare nuovi mezzi d’espressione stilistici
e tecnici, o attraverso la linea che il suo temperamento
esorbitante col tempo amplificò e contorse temeraria-
mente, o attraverso la tecnica del tocco che egli tor-
mentò e improntò della sua smania ricercatrice, sino a
raggiungere nel suo autoritratto un risultato sorpren-
dente per quel tempo ; infine un acuto senso del co-
lore che gli permise di assimilare, meglio dei suoi
compatriotti, le migliori doti dei veneziani.
Tutto nel suo stile sa di slancio, d’audacia e d’odio
alla pedanteria e alla compassatezza ; egli è il vero
figlio precoce di quel Seicento, scarso di semplicità,
di nobiltà, di profondità, ma esuberante e audace sma-
nioso di nuove indagini e di nuova vita. La sua atti-
vità troppo breve e il suo temperamento troppo irre-
quieto, perchè egli potesse arrivare a formarsi uno
stile maturo e definitivo, lo fecero apparire ai con-
temporanei pittore « più di spirito che di fondamento ».
Bisogna però tener presente come al suo tempo e tra
i bolognesi specialmente si stimasse principal « fon-
damento » dell’arte la padronanza dei canoni scola-
1 Presso il signor Belluzzi, che possiede una ricca collezione di
stampe bolognesi.
MISCELLANEA
miglior cosa sono i quindici misteri del Rosario at-
torno gettati con franchezza, eleganza e gaio colorito
e che anche LO retti dice « tanto spiritosi ».
Ma l’opera che meglio dà l’idea dell’arte sua è l’au-
toritratto (fìg. 2) fatto a Roma (a giudicare da una
lettera che tiene in mano a lui indirizzata in quella
città) che trovasi a Firenze, da poco collocato nel
corridoio tra Uffizi e Pitti (n. 388). Si riconosce su-
bito la maniera del Faccini nelle mani un po’ enfiate
dalla modellatura esagerata ma di viva carne. Il viso
è modellato con grande energia a forti sbattimenti di
luce e audacemente colorito.
Ma ciò che sopratutto sorprende di trovare in un
pittore di questo tempo e per giunta bolognese, è lo
slancio e l’audacia del tocco degni di un seguace di
Rembrandt. Non solo non si riscontra niente di si-
mile in tutti gli altri bolognesi, non escluso Annibaie
Caracci, che sono assai più timidi e finiti, ma nem-
meno nell’impetuoso Caravaggio si veggono pennel-
late così ardite, personali e sincere. Non si conosce
la data del suo viaggio a Roma ma, a giudicare dalla
fisonomia del ritratto, che mostra un’età anche supe-
riore ai quarant’anni che il Faccini visse, bisogna con-
cludere che questa è una delle ultime sue pitture.
Quest’ultima sua maniera, che tranne nell’autoritratto
segna un regresso, si distingue per un fare affrettato,
ribelle ad ogni scolastica tradizione che degenera ta-
lora in scorrezioni e gonfiezze ma che pur lascia tra-
sparire qualcosa dell’ingegno vivace del Faccini. Il
suo temperamento irrequieto e impaziente si traduce
in pennellate dense e cariche di colore arruffate e but-
tate con gran furia e nervosità non prive di un certo
fascino. Appartiene a questo momento una Natività
che era nella soppressa chiesa di San Mattia, da me
ritrovata insieme ad un’Annunciazione del 'Tintoretto,
nel magazzino della chiesa di Sant’Isaia. Questi due
quadri si trovavano appunto in San Mattia uno ac-
canto all’altro e quindi si capisce il fare e il colorito
drammatico di questa Natività in cui cercava, secondo
gli stessi storici, « trasformarsi nel Tenforetto » ima-
ginando la scena con uno sfondo sulla campagna ;
ma avendo pure in mente la «Notte» del Correggio.
Del resto del Tintoretto ha tolto più i vizi che le virtù
prendendo da lui specialmente le ombre un po’ sporche
e bituminose.
Gli altri dipinti di questo tempo, forse gli ultimi
cronologicamente, sono PAssunta dell’altare Grati ai
Servi e il quadro all’altare Landi in San Domenico,
opere molto deteriorate, cresciute e screpolate che ben
poco manifestano del primitivo colore, piene di esa-
gerazioni, ma che tuttavia lasciano trasparire ancora
alcune buone intenzioni, come una certa briosa disin-
voltura e specialmente quel tocco caratteristico del
Faccini, fatto di pennellate arruffate e confuse di cui
ho detto sopra, che meglio non saprei paragonare che
al tocco tutto personale del pittore spagnuolo Theo-
tocopuli detto il Greco ; il quale pure deriva diretta-
mente dal Tintoretto.
Delle altre opere che non ho rintracciato ho tro-
vato però delle stampe. 1 Una riproduce la presenta-
zione al Tempo che esisteva sino al 1835 nella chiesa
degli Scalzi e che probabilmente fu distrutta da un
incendio in quell’anno avvenuto.
Quest’opera secondo i biografi era una delle mi-
gliori del Faccini come si può ancora giudicare dalla
stampa ; v’è di originale l’idea di nascondere dietro
il parapetto la parte inferiore del sacerdote per atte-
nuare la troppa sproporzione fra la figura maestosa
di lui in capo alla scala e l’altra troppo piccola della
bambinella ai piedi di essa ; motivo disarmonico ma ri-
prodotto fedelmente da Giotto a Tiziano. Altra stampa
firmata Giov : Valesio 1601 è quella che cita il Mal-
vasia quando dice che « non isdegnò il Valesio inta-
gliare un suo San Raimondo che sul mantello solca
il mare, quando non volle intagliare le cose dei Ca-
racci ». E buona composizione che ricorda, ma forse
in meglio, il soggetto analogo di Lodovico Caracci a
San Domenico.
Vari disegni e bozzetti suoi esistono agli Uffizi, fra
i quali alcuni degli ultimi anni certo, tanto l’esage-
razione è spinta, ma ve ne sono anche altri che pro-
vano il suo ingegno facile e vivace e uno così arioso
e svelto (n. 6202) da parere cosa del Tiepolo (fig. 3).
Concludendo dunque mi pare si possa stabilire che
le caratteristiche dell’arte del Faccini sono : una grande
vivacità e disinvoltura nelle composizioni e nei tipi,
qualità per cui tutti i biografi giudicano le sue tele
« spiritose » ; un continuo e incessante amore a rin-
novarsi e tentare nuovi mezzi d’espressione stilistici
e tecnici, o attraverso la linea che il suo temperamento
esorbitante col tempo amplificò e contorse temeraria-
mente, o attraverso la tecnica del tocco che egli tor-
mentò e improntò della sua smania ricercatrice, sino a
raggiungere nel suo autoritratto un risultato sorpren-
dente per quel tempo ; infine un acuto senso del co-
lore che gli permise di assimilare, meglio dei suoi
compatriotti, le migliori doti dei veneziani.
Tutto nel suo stile sa di slancio, d’audacia e d’odio
alla pedanteria e alla compassatezza ; egli è il vero
figlio precoce di quel Seicento, scarso di semplicità,
di nobiltà, di profondità, ma esuberante e audace sma-
nioso di nuove indagini e di nuova vita. La sua atti-
vità troppo breve e il suo temperamento troppo irre-
quieto, perchè egli potesse arrivare a formarsi uno
stile maturo e definitivo, lo fecero apparire ai con-
temporanei pittore « più di spirito che di fondamento ».
Bisogna però tener presente come al suo tempo e tra
i bolognesi specialmente si stimasse principal « fon-
damento » dell’arte la padronanza dei canoni scola-
1 Presso il signor Belluzzi, che possiede una ricca collezione di
stampe bolognesi.