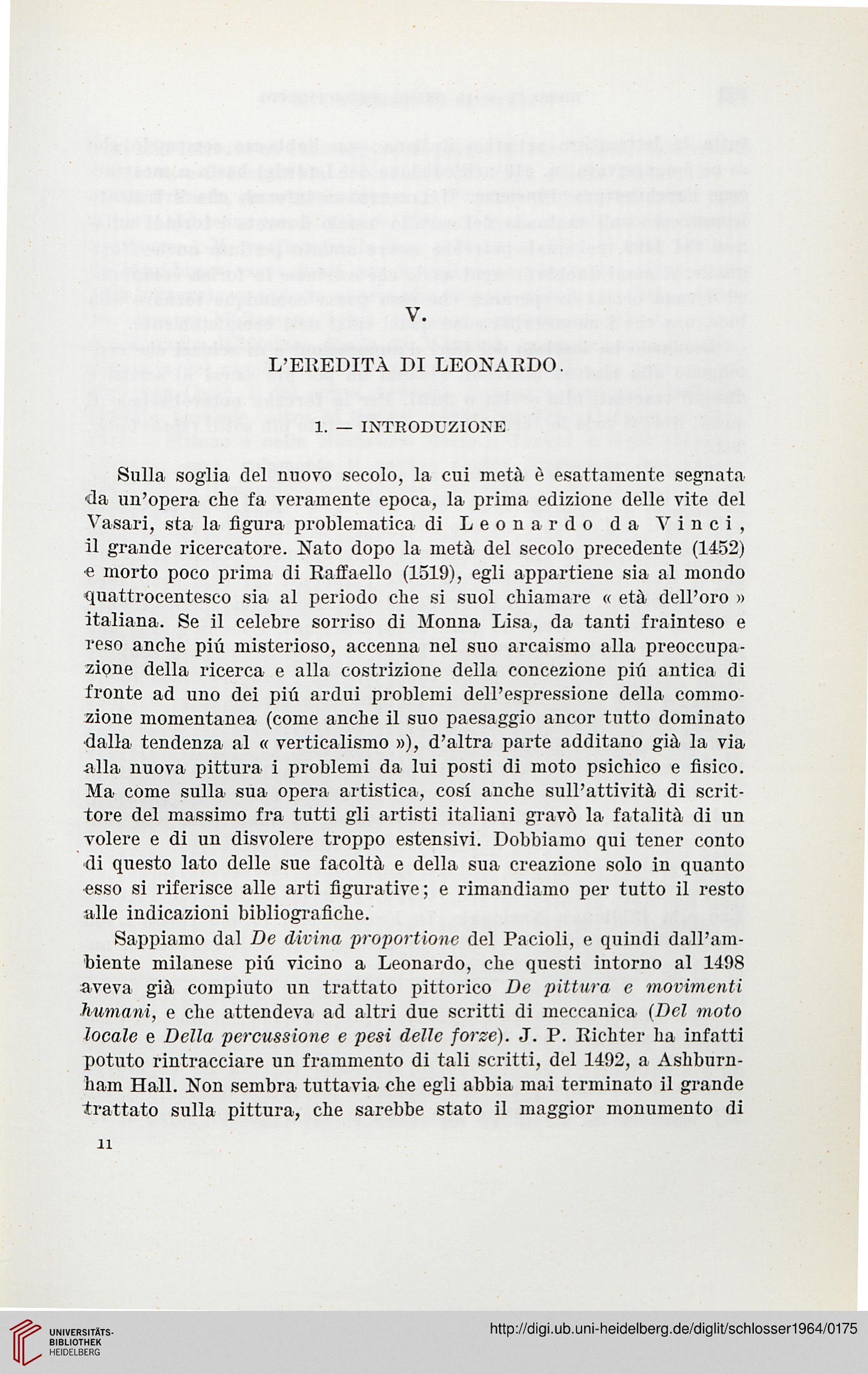V.
L'EREDITÀ DI LEONARDO.
1. — INTRODUZIONE
Sulla soglia del nuovo secolo, la cui metà è esattamente segnata
da un'opera che fa veramente epoca, la prima edizione delle vite del
Vasari, sta la figura problematica di Leonardo da Vinci,
il grande ricercatore. Nato dopo la metà del secolo precedente (1452)
€ morto poco prima di Raffaello (1519), egli appartiene sia al mondo
quattrocentesco sia al periodo che si suol chiamare « età dell'oro »
italiana. Se il celebre sorriso di Monna Lisa, da tanti frainteso e
reso anche più misterioso, accenna nel suo arcaismo alla preoccupa-
zione della ricerca e alla costrizione della concezione più antica di
fronte ad uno dei più ardui problemi dell'espressione della commo-
zione momentanea (come anche il suo paesaggio ancor tutto dominato
dalla tendenza al « verticalismo »), d'altra parte additano già la via
alla nuova pittura i problemi da lui posti di moto psichico e fisico.
Ma come sulla sua opera artistica, cosi anche sull'attività di scrit-
tore del massimo fra tutti gli artisti italiani gravò la fatalità di un
volere e di un disvolere troppo estensivi. Dobbiamo qui tener conto
■di questo lato delle sue facoltà e della sua creazione solo in quanto
«sso si riferisce alle arti figurative; e rimandiamo per tutto il resto
alle indicazioni bibliografiche.
Sappiamo dal De divina proportione del Pacioli, e quindi dall'am-
biente milanese più vicino a Leonardo, che questi intorno al 1498
aveva già compiuto un trattato pittorico De pittura e movimenti
humani, e che attendeva ad altri due scritti di meccanica (Del moto
locale e Della percussione e pesi delle forze). J. P. Richter ha infatti
potuto rintracciare un frammento di tali scritti, del 1492, a Ashburn-
ham Hall. Non sembra tuttavia che egli abbia mai terminato il grande
trattato sulla pittura, che sarebbe stato il maggior monumento di
a
L'EREDITÀ DI LEONARDO.
1. — INTRODUZIONE
Sulla soglia del nuovo secolo, la cui metà è esattamente segnata
da un'opera che fa veramente epoca, la prima edizione delle vite del
Vasari, sta la figura problematica di Leonardo da Vinci,
il grande ricercatore. Nato dopo la metà del secolo precedente (1452)
€ morto poco prima di Raffaello (1519), egli appartiene sia al mondo
quattrocentesco sia al periodo che si suol chiamare « età dell'oro »
italiana. Se il celebre sorriso di Monna Lisa, da tanti frainteso e
reso anche più misterioso, accenna nel suo arcaismo alla preoccupa-
zione della ricerca e alla costrizione della concezione più antica di
fronte ad uno dei più ardui problemi dell'espressione della commo-
zione momentanea (come anche il suo paesaggio ancor tutto dominato
dalla tendenza al « verticalismo »), d'altra parte additano già la via
alla nuova pittura i problemi da lui posti di moto psichico e fisico.
Ma come sulla sua opera artistica, cosi anche sull'attività di scrit-
tore del massimo fra tutti gli artisti italiani gravò la fatalità di un
volere e di un disvolere troppo estensivi. Dobbiamo qui tener conto
■di questo lato delle sue facoltà e della sua creazione solo in quanto
«sso si riferisce alle arti figurative; e rimandiamo per tutto il resto
alle indicazioni bibliografiche.
Sappiamo dal De divina proportione del Pacioli, e quindi dall'am-
biente milanese più vicino a Leonardo, che questi intorno al 1498
aveva già compiuto un trattato pittorico De pittura e movimenti
humani, e che attendeva ad altri due scritti di meccanica (Del moto
locale e Della percussione e pesi delle forze). J. P. Richter ha infatti
potuto rintracciare un frammento di tali scritti, del 1492, a Ashburn-
ham Hall. Non sembra tuttavia che egli abbia mai terminato il grande
trattato sulla pittura, che sarebbe stato il maggior monumento di
a