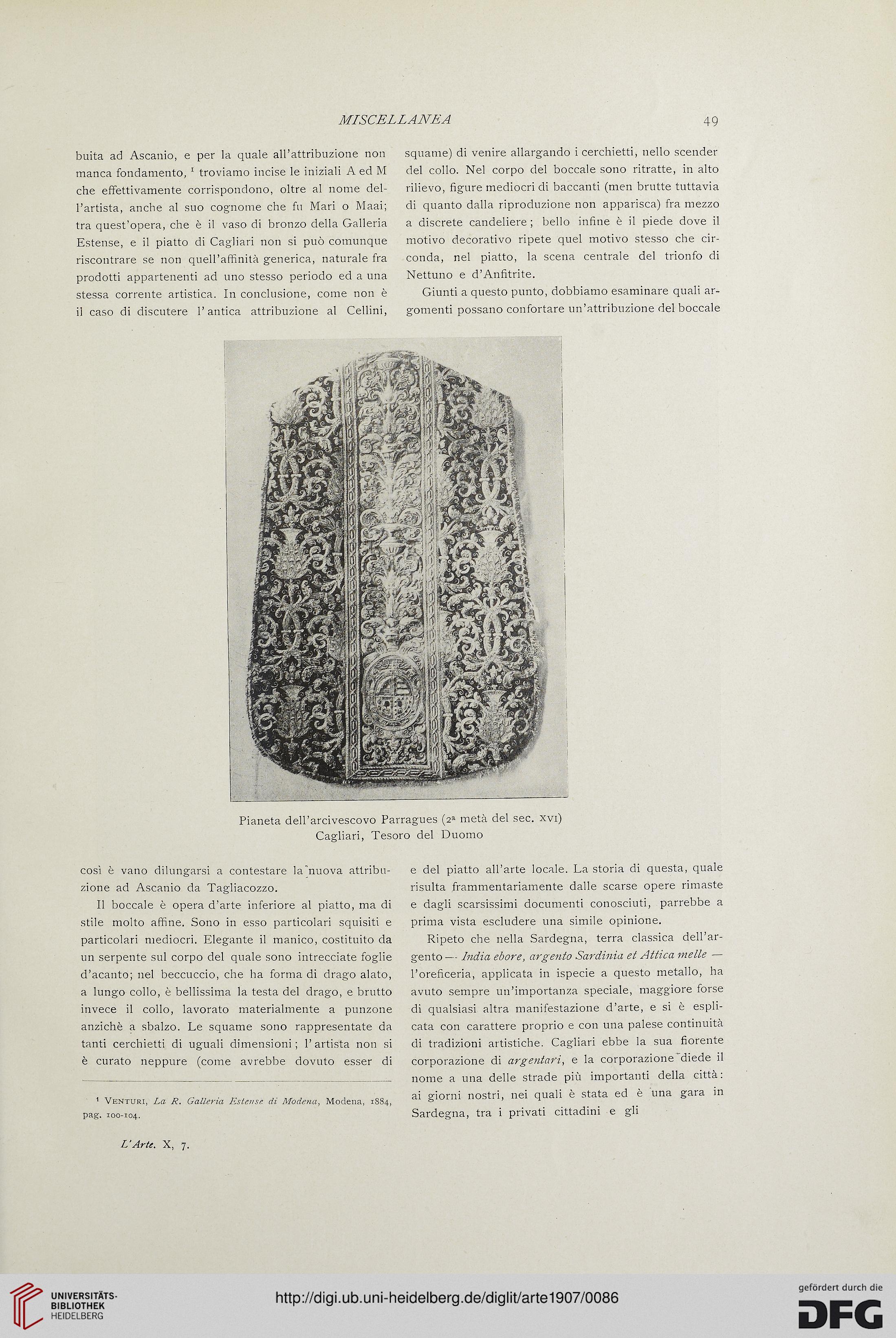MISCELLANEA
49
buita ad Ascanio, e per la quale all’attribuzione non
manca fondamento, 1 troviamo incise le iniziali A ed M
che effettivamente corrispondono, oltre al nome del-
l’artista, anche al suo cognome che fu Mari o Maai;
tra quest’opera, che è il vaso di bronzo della Galleria
Estense, e il piatto di Cagliari non si può comunque
riscontrare se non quell’affinità generica, naturale fra
prodotti appartenenti ad uno stesso periodo ed a una
stessa corrente artistica. In conclusione, come non è
il caso di discutere l’antica attribuzione al Celimi,
squame) di venire allargando i cerchietti, nello scender
del collo. Nel corpo del boccale sono ritratte, in alto
rilievo, figure mediocri di baccanti (men brutte tuttavia
di quanto dalla riproduzione non apparisca) fra mezzo
a discrete candeliere ; bello infine è il piede dove il
motivo decorativo ripete quel motivo stesso che cir-
conda, nel piatto, la scena centrale del trionfo di
Nettuno e d’Anfitrite.
Giunti a questo punto, dobbiamo esaminare quali ar-
gomenti possano confortare un’attribuzione del boccale
Pianeta dell’arcivescovo Parragues (2a metà del sec. xvi)
Cagliari, Tesoro del Duomo
cosi è vano dilungarsi a contestare la'nuova attribu-
zione ad Ascanio da Tagliacozzo.
Il boccale è opera d’arte inferiore al piatto, ma di
stile molto affine. Sono in esso particolari squisiti e
particolari mediocri. Elegante il manico, costituito da
un serpente sul corpo del quale sono intrecciate foglie
d’acanto; nel beccuccio, che ha forma di drago alato,
a lungo collo, è bellissima la testa del drago, e brutto
invece il collo, lavorato materialmente a punzone
anziché a sbalzo. Le squame sono rappresentate da
tanti cerchietti di uguali dimensioni; l’artista non si
è curato neppure (come avrebbe dovuto esser di
1 Venturi, La R. Galleria Estense di Modena, Modena, 1884,
pag. 100-104.
e del piatto all’arte locale. La storia di questa, quale
risulta frammentariamente dalle scarse opere rimaste
e dagli scarsissimi documenti conosciuti, parrebbe a
prima vista escludere una simile opinione.
Ripeto che nella Sardegna, terra classica dell’ar-
gento — India ebore, argento Sardinia et Attica mette —
l’oreficeria, applicata in ispecie a questo metallo, ha
avuto sempre un’importanza speciale, maggiore forse
di qualsiasi altra manifestazione d’arte, e si è espli-
cata con carattere proprio e con una palese continuità
di tradizioni artistiche. Cagliari ebbe la sua fiorente
corporazione di argentari, e la corporazione diede il
nome a una delle strade più importanti della città:
ai giorni nostri, nei quali è stata ed è una gara in
Sardegna, tra i privati cittadini e gli
L'Arte. X, 7.
49
buita ad Ascanio, e per la quale all’attribuzione non
manca fondamento, 1 troviamo incise le iniziali A ed M
che effettivamente corrispondono, oltre al nome del-
l’artista, anche al suo cognome che fu Mari o Maai;
tra quest’opera, che è il vaso di bronzo della Galleria
Estense, e il piatto di Cagliari non si può comunque
riscontrare se non quell’affinità generica, naturale fra
prodotti appartenenti ad uno stesso periodo ed a una
stessa corrente artistica. In conclusione, come non è
il caso di discutere l’antica attribuzione al Celimi,
squame) di venire allargando i cerchietti, nello scender
del collo. Nel corpo del boccale sono ritratte, in alto
rilievo, figure mediocri di baccanti (men brutte tuttavia
di quanto dalla riproduzione non apparisca) fra mezzo
a discrete candeliere ; bello infine è il piede dove il
motivo decorativo ripete quel motivo stesso che cir-
conda, nel piatto, la scena centrale del trionfo di
Nettuno e d’Anfitrite.
Giunti a questo punto, dobbiamo esaminare quali ar-
gomenti possano confortare un’attribuzione del boccale
Pianeta dell’arcivescovo Parragues (2a metà del sec. xvi)
Cagliari, Tesoro del Duomo
cosi è vano dilungarsi a contestare la'nuova attribu-
zione ad Ascanio da Tagliacozzo.
Il boccale è opera d’arte inferiore al piatto, ma di
stile molto affine. Sono in esso particolari squisiti e
particolari mediocri. Elegante il manico, costituito da
un serpente sul corpo del quale sono intrecciate foglie
d’acanto; nel beccuccio, che ha forma di drago alato,
a lungo collo, è bellissima la testa del drago, e brutto
invece il collo, lavorato materialmente a punzone
anziché a sbalzo. Le squame sono rappresentate da
tanti cerchietti di uguali dimensioni; l’artista non si
è curato neppure (come avrebbe dovuto esser di
1 Venturi, La R. Galleria Estense di Modena, Modena, 1884,
pag. 100-104.
e del piatto all’arte locale. La storia di questa, quale
risulta frammentariamente dalle scarse opere rimaste
e dagli scarsissimi documenti conosciuti, parrebbe a
prima vista escludere una simile opinione.
Ripeto che nella Sardegna, terra classica dell’ar-
gento — India ebore, argento Sardinia et Attica mette —
l’oreficeria, applicata in ispecie a questo metallo, ha
avuto sempre un’importanza speciale, maggiore forse
di qualsiasi altra manifestazione d’arte, e si è espli-
cata con carattere proprio e con una palese continuità
di tradizioni artistiche. Cagliari ebbe la sua fiorente
corporazione di argentari, e la corporazione diede il
nome a una delle strade più importanti della città:
ai giorni nostri, nei quali è stata ed è una gara in
Sardegna, tra i privati cittadini e gli
L'Arte. X, 7.