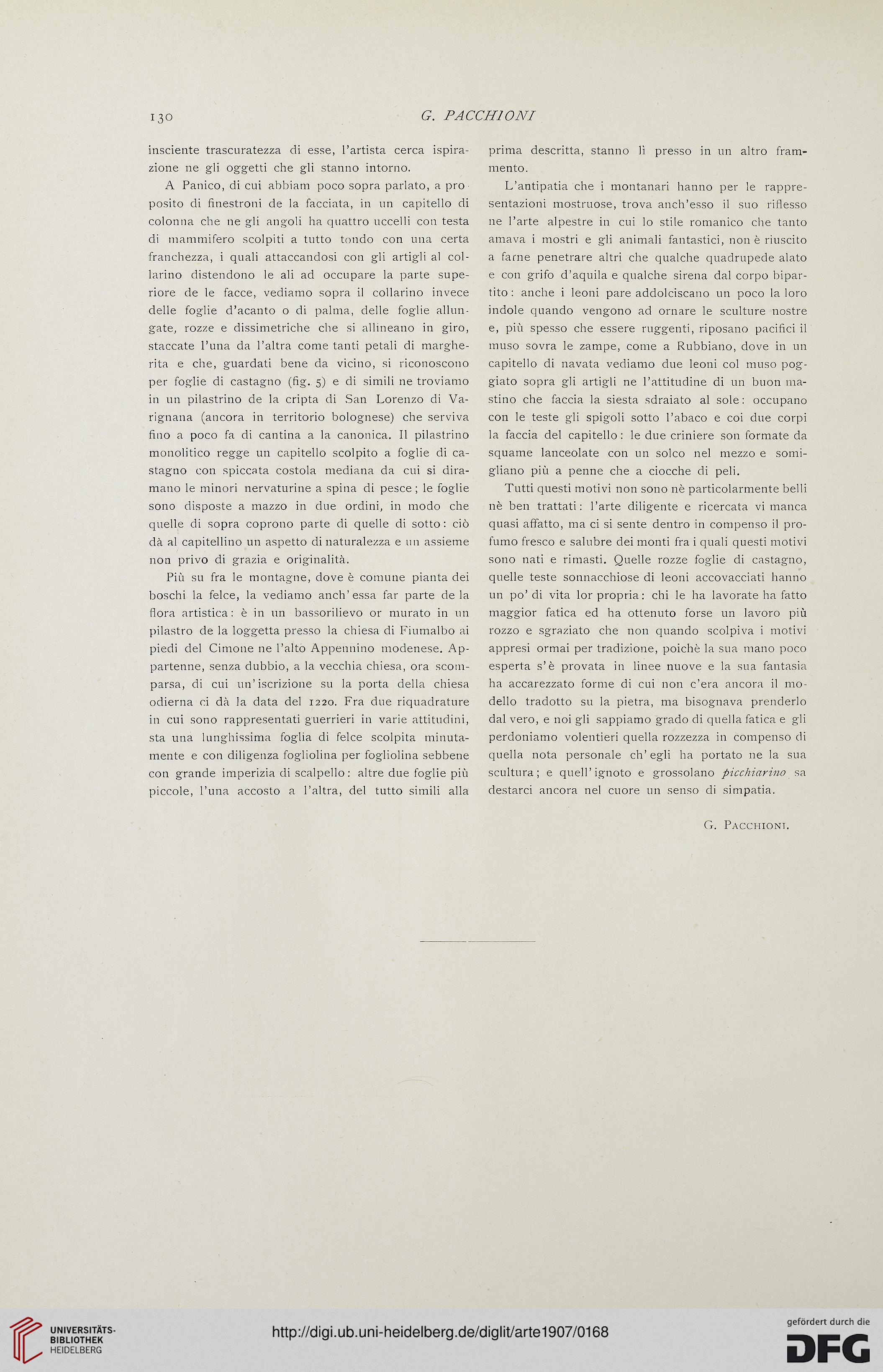130
G. PACCHIONI
insciente trascuratezza di esse, l’artista cerca ispira-
zione ne gli oggetti che gli stanno intorno.
A Panico, di cui abbiam poco sopra parlato, a prò
posito di finestroni de la facciata, in un capitello di
colonna che ne gli angoli ha quattro uccelli con testa
di mammifero scolpiti a tutto tondo con una certa
franchezza, i quali attaccandosi con gli artigli al col-
larino distendono le ali ad occupare la parte supe-
riore de le facce, vediamo sopra il collarino invece
delle foglie d’acanto o di palma, delle foglie allun-
gate, rozze e dosimetriche che si allineano in giro,
staccate l’una da l’altra come tanti petali di marghe-
rita e che, guardati bene da vicino, si riconoscono
per foglie di castagno (fig. 5) e di simili ne troviamo
in un pilastrino de la cripta di San Lorenzo di Va-
rignana (ancora in territorio bolognese) che serviva
fino a poco fa di cantina a la canonica. Il pilastrino
monolitico regge un capitello scolpito a foglie di ca-
stagno con spiccata costola mediana da cui si dira-
mano le minori nervaturine a spina di pesce; le foglie
sono disposte a mazzo in due ordini, in modo che
quelle di sopra coprono parte di quelle di sotto: ciò
dà al capitellino un aspetto di naturalezza e un assieme
non privo di grazia e originalità.
Più su fra le montagne, dove è comune pianta dei
boschi la felce, la vediamo aneli’essa far parte de la
flora artistica: è in un bassorilievo or murato in un
pilastro de la loggetta presso la chiesa di Fiumalbo ai
piedi del Cimone ne l’alto Appennino modenese. Ap-
partenne, senza dubbio, a la vecchia chiesa, ora scom-
parsa, di cui un’iscrizione su la porta della chiesa
odierna ci dà la data del 1220. Fra due riquadrature
in cui sono rappresentati guerrieri in varie attitudini,
sta una lunghissima foglia di felce scolpita minuta-
mente e con diligenza fogliolina per fogliolina sebbene
con grande imperizia di scalpello: altre due foglie più
piccole, l’una accosto a l’altra, del tutto simili alla
prima descritta, stanno lì presso in un altro fram-
mento.
L’antipatia che i montanari hanno per le rappre-
sentazioni mostruose, trova anch’esso il suo riflesso
ne l’arte alpestre in cui lo stile romanico che tanto
amava i mostri e gli animali fantastici, non è riuscito
a farne penetrare altri che qualche quadrupede alato
e con grifo d’aquila e qualche sirena dal corpo bipar-
tito: anche i leoni pare addolciscano un poco la loro
indole quando vengono ad ornare le sculture nostre
e, più spesso che essere ruggenti, riposano pacifici il
muso sovra le zampe, come a Rubbiano, dove in un
capitello di navata vediamo due leoni col muso pog-
giato sopra gli artigli ne l’attitudine di un buon ma-
stino che faccia la siesta sdraiato al sole: occupano
con le teste gli spigoli sotto l’abaco e coi due corpi
la faccia del capitello : le due criniere son formate da
squame lanceolate con un solco nel mezzo e somi-
gliano più a penne che a ciocche di peli.
Tutti questi motivi non sono nè particolarmente belli
nè ben trattati: l’arte diligente e ricercata vi manca
quasi affatto, ma ci si sente dentro in compenso il pro-
fumo fresco e salubre dei monti fra i quali questi motivi
sotto nati e rimasti. Quelle rozze foglie di castagno,
quelle teste sonnacchiose di leoni accovacciati hanno
un po’ di vita lor propria: chi le ha lavorate ha fatto
maggior fatica ed ha ottenuto forse un lavoro più
rozzo e sgraziato che non quando scolpiva i motivi
appresi ormai per tradizione, poiché la sua mano poco
esperta s’è provata in linee nuove e la sua fantasia
ha accarezzato forme di cui non c’era ancora il mo-
dello tradotto su la pietra, ma bisognava prenderlo
dal vero, e noi gli sappiamo grado di quella fatica e gli
perdoniamo volentieri quella rozzezza in compenso di
quella nota personale eh’ egli ha portato ne la sua
scultura; e quell’ignoto e grossolano picchiarìno sa
destarci ancora nel cuore un senso di simpatia.
G. Pacchioni.
G. PACCHIONI
insciente trascuratezza di esse, l’artista cerca ispira-
zione ne gli oggetti che gli stanno intorno.
A Panico, di cui abbiam poco sopra parlato, a prò
posito di finestroni de la facciata, in un capitello di
colonna che ne gli angoli ha quattro uccelli con testa
di mammifero scolpiti a tutto tondo con una certa
franchezza, i quali attaccandosi con gli artigli al col-
larino distendono le ali ad occupare la parte supe-
riore de le facce, vediamo sopra il collarino invece
delle foglie d’acanto o di palma, delle foglie allun-
gate, rozze e dosimetriche che si allineano in giro,
staccate l’una da l’altra come tanti petali di marghe-
rita e che, guardati bene da vicino, si riconoscono
per foglie di castagno (fig. 5) e di simili ne troviamo
in un pilastrino de la cripta di San Lorenzo di Va-
rignana (ancora in territorio bolognese) che serviva
fino a poco fa di cantina a la canonica. Il pilastrino
monolitico regge un capitello scolpito a foglie di ca-
stagno con spiccata costola mediana da cui si dira-
mano le minori nervaturine a spina di pesce; le foglie
sono disposte a mazzo in due ordini, in modo che
quelle di sopra coprono parte di quelle di sotto: ciò
dà al capitellino un aspetto di naturalezza e un assieme
non privo di grazia e originalità.
Più su fra le montagne, dove è comune pianta dei
boschi la felce, la vediamo aneli’essa far parte de la
flora artistica: è in un bassorilievo or murato in un
pilastro de la loggetta presso la chiesa di Fiumalbo ai
piedi del Cimone ne l’alto Appennino modenese. Ap-
partenne, senza dubbio, a la vecchia chiesa, ora scom-
parsa, di cui un’iscrizione su la porta della chiesa
odierna ci dà la data del 1220. Fra due riquadrature
in cui sono rappresentati guerrieri in varie attitudini,
sta una lunghissima foglia di felce scolpita minuta-
mente e con diligenza fogliolina per fogliolina sebbene
con grande imperizia di scalpello: altre due foglie più
piccole, l’una accosto a l’altra, del tutto simili alla
prima descritta, stanno lì presso in un altro fram-
mento.
L’antipatia che i montanari hanno per le rappre-
sentazioni mostruose, trova anch’esso il suo riflesso
ne l’arte alpestre in cui lo stile romanico che tanto
amava i mostri e gli animali fantastici, non è riuscito
a farne penetrare altri che qualche quadrupede alato
e con grifo d’aquila e qualche sirena dal corpo bipar-
tito: anche i leoni pare addolciscano un poco la loro
indole quando vengono ad ornare le sculture nostre
e, più spesso che essere ruggenti, riposano pacifici il
muso sovra le zampe, come a Rubbiano, dove in un
capitello di navata vediamo due leoni col muso pog-
giato sopra gli artigli ne l’attitudine di un buon ma-
stino che faccia la siesta sdraiato al sole: occupano
con le teste gli spigoli sotto l’abaco e coi due corpi
la faccia del capitello : le due criniere son formate da
squame lanceolate con un solco nel mezzo e somi-
gliano più a penne che a ciocche di peli.
Tutti questi motivi non sono nè particolarmente belli
nè ben trattati: l’arte diligente e ricercata vi manca
quasi affatto, ma ci si sente dentro in compenso il pro-
fumo fresco e salubre dei monti fra i quali questi motivi
sotto nati e rimasti. Quelle rozze foglie di castagno,
quelle teste sonnacchiose di leoni accovacciati hanno
un po’ di vita lor propria: chi le ha lavorate ha fatto
maggior fatica ed ha ottenuto forse un lavoro più
rozzo e sgraziato che non quando scolpiva i motivi
appresi ormai per tradizione, poiché la sua mano poco
esperta s’è provata in linee nuove e la sua fantasia
ha accarezzato forme di cui non c’era ancora il mo-
dello tradotto su la pietra, ma bisognava prenderlo
dal vero, e noi gli sappiamo grado di quella fatica e gli
perdoniamo volentieri quella rozzezza in compenso di
quella nota personale eh’ egli ha portato ne la sua
scultura; e quell’ignoto e grossolano picchiarìno sa
destarci ancora nel cuore un senso di simpatia.
G. Pacchioni.