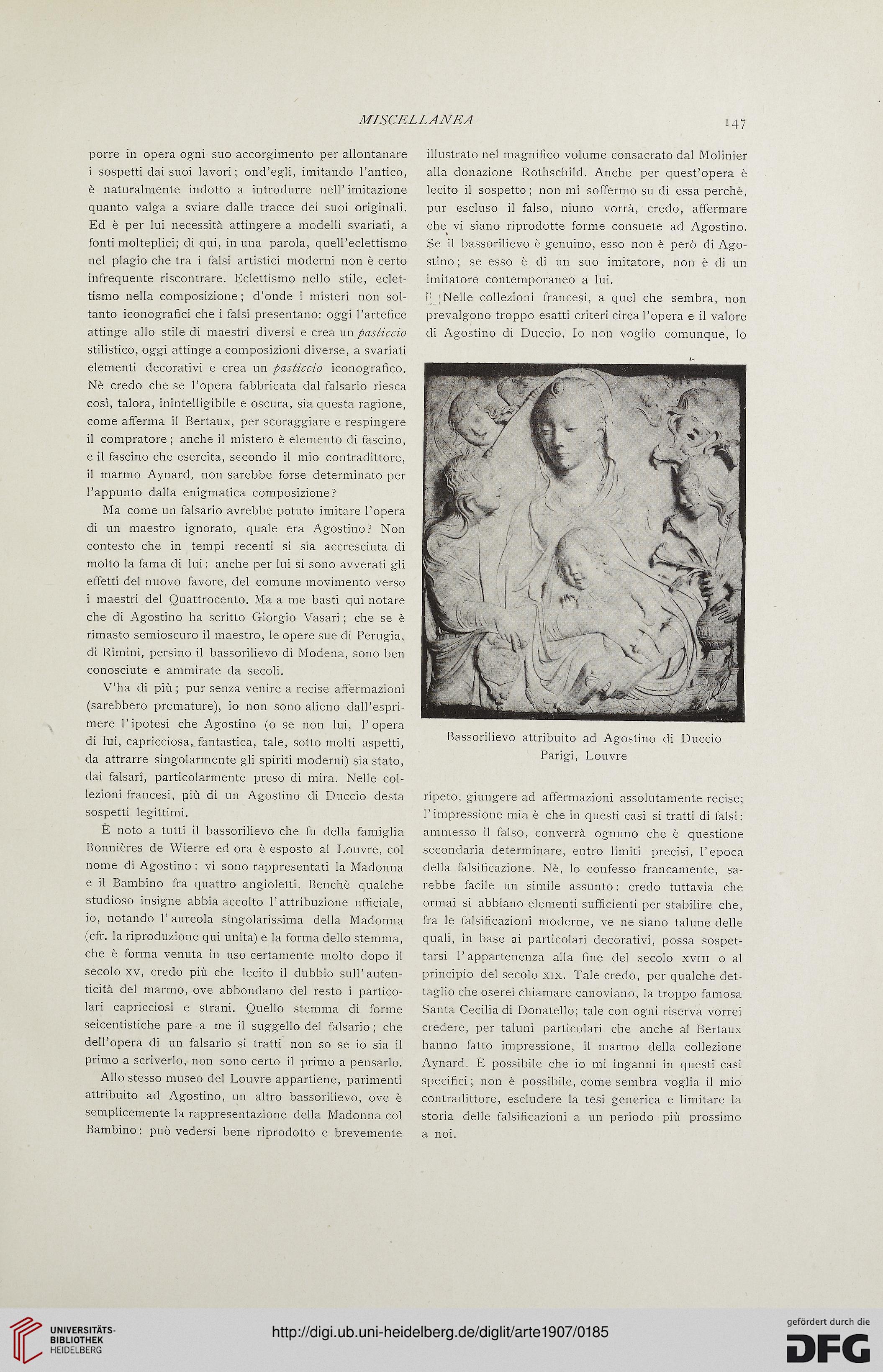MISCELLANEA
147
porre in opera ogni suo accorgimento per allontanare
i sospetti dai suoi lavori; ond’egli, imitando l’antico,
è naturalmente indotto a introdurre nell’ imitazione
quanto valga a sviare dalle tracce dei suoi originali.
Ed è per lui necessità attingere a modelli svariati, a
fonti molteplici; di qui, in una parola, quell’eclettismo
nel plagio che tra i falsi artistici moderni non è certo
infrequente riscontrare. Eclettismo nello stile, eclet-
tismo nella composizione ; d’onde i misteri non sol-
tanto iconografici che i falsi presentano: oggi l’artefice
attinge allo stile di maestri diversi e crea un pasticcio
stilistico, oggi attinge a composizioni diverse, a svariati
elementi decorativi e crea un pastìccio iconografico.
Nè credo che se l’opera fabbricata dal falsario riesca
così, talora, inintelligibile e oscura, sia questa ragione,
come afferma il Bertaux, per scoraggiare e respingere
il compratore; anche il mistero è elemento di fascino,
e il fascino che esercita, secondo il mio contradittore,
il marmo Aynard, non sarebbe forse determinato per
l’appunto dalla enigmatica composizione?
Ma come un falsario avrebbe potuto imitare l’opera
di un maestro ignorato, quale era Agostino? Non
contesto che in tempi recenti si sia accresciuta di
molto la fama di lui : anche per lui si sono avverati gli
effetti del nuovo favore, del comune movimento verso
i maestri del Quattrocento. Ma a me basti qui notare
che di Agostino ha scritto Giorgio Vasari; che se è
rimasto semioscuro il maestro, le opere sue di Perugia,
di Rimini, persino il bassorilievo di Modena, sono ben
conosciute e ammirate da secoli.
V’ha di più ; pur senza venire a recise affermazioni
(sarebbero premature), io non sono alieno dall’espri-
mere l’ipotesi che Agostino (o se non lui, l’opera
di lui, capricciosa, fantastica, tale, sotto molti aspetti,
da attrarre singolarmente gli spiriti moderni) sia stato,
dai falsari, particolarmente preso di mira. Nelle col-
lezioni francesi, più di un Agostino di Duccio desta
sospetti legittimi.
È noto a tutti il bassorilievo che fu della famiglia
Bonnières de Wierre ed ora è esposto al Louvre, col
nome di Agostino : vi sono rappresentati la Madonna
e il Bambino fra quattro angioletti. Benché qualche
studioso insigne abbia accolto l’attribuzione ufficiale,
io, notando l’aureola singolarissima della Madonna
(cfr. la riproduzione qui unita) e la forma dello stemma,
che è forma venuta in uso certamente molto dopo il
secolo xv, credo più che lecito il dubbio sull’auten-
ticità del marmo, ove abbondano del resto i partico-
lari capricciosi e strani. Quello stemma di forme
seicentistiche pare a me il suggello del falsario; che
dell’opera di un falsario si tratti non so se io sia il
primo a scriverlo, non sono certo il primo a pensarlo.
Allo stesso museo del Louvre appartiene, parimenti
attribuito ad Agostino, un altro bassorilievo, ove è
semplicemente la rappresentazione della Madonna col
Bambino : può vedersi bene riprodotto e brevemente
illustrato nel magnifico volume consacrato dal Molinier
alla donazione Rothschild. Anche per quest’opera è
lecito il sospetto; non mi soffermo su di essa perchè,
pur escluso il falso, niuno vorrà, credo, affermare
che vi siano riprodotte forme consuete ad Agostino.
Se il bassorilievo è genuino, esso non è però di Ago-
stino ; se esso è di un suo imitatore, non è di un
imitatore contemporaneo a lui.
fi Nelle collezioni francesi, a quel che sembra, non
prevalgono troppo esatti criteri circa l’opera e il valore
di Agostino di Duccio. Io non voglio comunque, lo
Bassorilievo attribuito ad Agostino di Duccio
Parigi, Louvre
ripeto, giungere ad affermazioni assolutamente recise;
l’impressione mia è che in questi casi si tratti di falsi:
ammesso il falso, converrà ognuno che è questione
secondaria determinare, entro limiti precisi, l’epoca
della falsificazione. Nè, lo confesso francamente, sa-
rebbe facile un simile assunto: credo tuttavia che
ormai si abbiano elementi sufficienti per stabilire che,
fra le falsificazioni moderne, ve ne siano talune delle
quali, in base ai particolari decorativi, possa sospet-
tarsi l’appartenenza alla fine del secolo xvm o al
principio del secolo xix. Tale credo, per qualche det-
taglio che oserei chiamare canoviano, la troppo famosa
Santa Cecilia di Donatello; tale con ogni riserva vorrei
credere, per taluni particolari che anche al Bertaux
hanno fatto impressione, il marmo della collezione
Aynard. È possibile che io mi inganni in questi casi
specifici ; non è possibile, come sembra voglia il mio
contradittore, escludere la tesi generica e limitare la
storia delle falsificazioni a un periodo più prossimo
a noi.
147
porre in opera ogni suo accorgimento per allontanare
i sospetti dai suoi lavori; ond’egli, imitando l’antico,
è naturalmente indotto a introdurre nell’ imitazione
quanto valga a sviare dalle tracce dei suoi originali.
Ed è per lui necessità attingere a modelli svariati, a
fonti molteplici; di qui, in una parola, quell’eclettismo
nel plagio che tra i falsi artistici moderni non è certo
infrequente riscontrare. Eclettismo nello stile, eclet-
tismo nella composizione ; d’onde i misteri non sol-
tanto iconografici che i falsi presentano: oggi l’artefice
attinge allo stile di maestri diversi e crea un pasticcio
stilistico, oggi attinge a composizioni diverse, a svariati
elementi decorativi e crea un pastìccio iconografico.
Nè credo che se l’opera fabbricata dal falsario riesca
così, talora, inintelligibile e oscura, sia questa ragione,
come afferma il Bertaux, per scoraggiare e respingere
il compratore; anche il mistero è elemento di fascino,
e il fascino che esercita, secondo il mio contradittore,
il marmo Aynard, non sarebbe forse determinato per
l’appunto dalla enigmatica composizione?
Ma come un falsario avrebbe potuto imitare l’opera
di un maestro ignorato, quale era Agostino? Non
contesto che in tempi recenti si sia accresciuta di
molto la fama di lui : anche per lui si sono avverati gli
effetti del nuovo favore, del comune movimento verso
i maestri del Quattrocento. Ma a me basti qui notare
che di Agostino ha scritto Giorgio Vasari; che se è
rimasto semioscuro il maestro, le opere sue di Perugia,
di Rimini, persino il bassorilievo di Modena, sono ben
conosciute e ammirate da secoli.
V’ha di più ; pur senza venire a recise affermazioni
(sarebbero premature), io non sono alieno dall’espri-
mere l’ipotesi che Agostino (o se non lui, l’opera
di lui, capricciosa, fantastica, tale, sotto molti aspetti,
da attrarre singolarmente gli spiriti moderni) sia stato,
dai falsari, particolarmente preso di mira. Nelle col-
lezioni francesi, più di un Agostino di Duccio desta
sospetti legittimi.
È noto a tutti il bassorilievo che fu della famiglia
Bonnières de Wierre ed ora è esposto al Louvre, col
nome di Agostino : vi sono rappresentati la Madonna
e il Bambino fra quattro angioletti. Benché qualche
studioso insigne abbia accolto l’attribuzione ufficiale,
io, notando l’aureola singolarissima della Madonna
(cfr. la riproduzione qui unita) e la forma dello stemma,
che è forma venuta in uso certamente molto dopo il
secolo xv, credo più che lecito il dubbio sull’auten-
ticità del marmo, ove abbondano del resto i partico-
lari capricciosi e strani. Quello stemma di forme
seicentistiche pare a me il suggello del falsario; che
dell’opera di un falsario si tratti non so se io sia il
primo a scriverlo, non sono certo il primo a pensarlo.
Allo stesso museo del Louvre appartiene, parimenti
attribuito ad Agostino, un altro bassorilievo, ove è
semplicemente la rappresentazione della Madonna col
Bambino : può vedersi bene riprodotto e brevemente
illustrato nel magnifico volume consacrato dal Molinier
alla donazione Rothschild. Anche per quest’opera è
lecito il sospetto; non mi soffermo su di essa perchè,
pur escluso il falso, niuno vorrà, credo, affermare
che vi siano riprodotte forme consuete ad Agostino.
Se il bassorilievo è genuino, esso non è però di Ago-
stino ; se esso è di un suo imitatore, non è di un
imitatore contemporaneo a lui.
fi Nelle collezioni francesi, a quel che sembra, non
prevalgono troppo esatti criteri circa l’opera e il valore
di Agostino di Duccio. Io non voglio comunque, lo
Bassorilievo attribuito ad Agostino di Duccio
Parigi, Louvre
ripeto, giungere ad affermazioni assolutamente recise;
l’impressione mia è che in questi casi si tratti di falsi:
ammesso il falso, converrà ognuno che è questione
secondaria determinare, entro limiti precisi, l’epoca
della falsificazione. Nè, lo confesso francamente, sa-
rebbe facile un simile assunto: credo tuttavia che
ormai si abbiano elementi sufficienti per stabilire che,
fra le falsificazioni moderne, ve ne siano talune delle
quali, in base ai particolari decorativi, possa sospet-
tarsi l’appartenenza alla fine del secolo xvm o al
principio del secolo xix. Tale credo, per qualche det-
taglio che oserei chiamare canoviano, la troppo famosa
Santa Cecilia di Donatello; tale con ogni riserva vorrei
credere, per taluni particolari che anche al Bertaux
hanno fatto impressione, il marmo della collezione
Aynard. È possibile che io mi inganni in questi casi
specifici ; non è possibile, come sembra voglia il mio
contradittore, escludere la tesi generica e limitare la
storia delle falsificazioni a un periodo più prossimo
a noi.