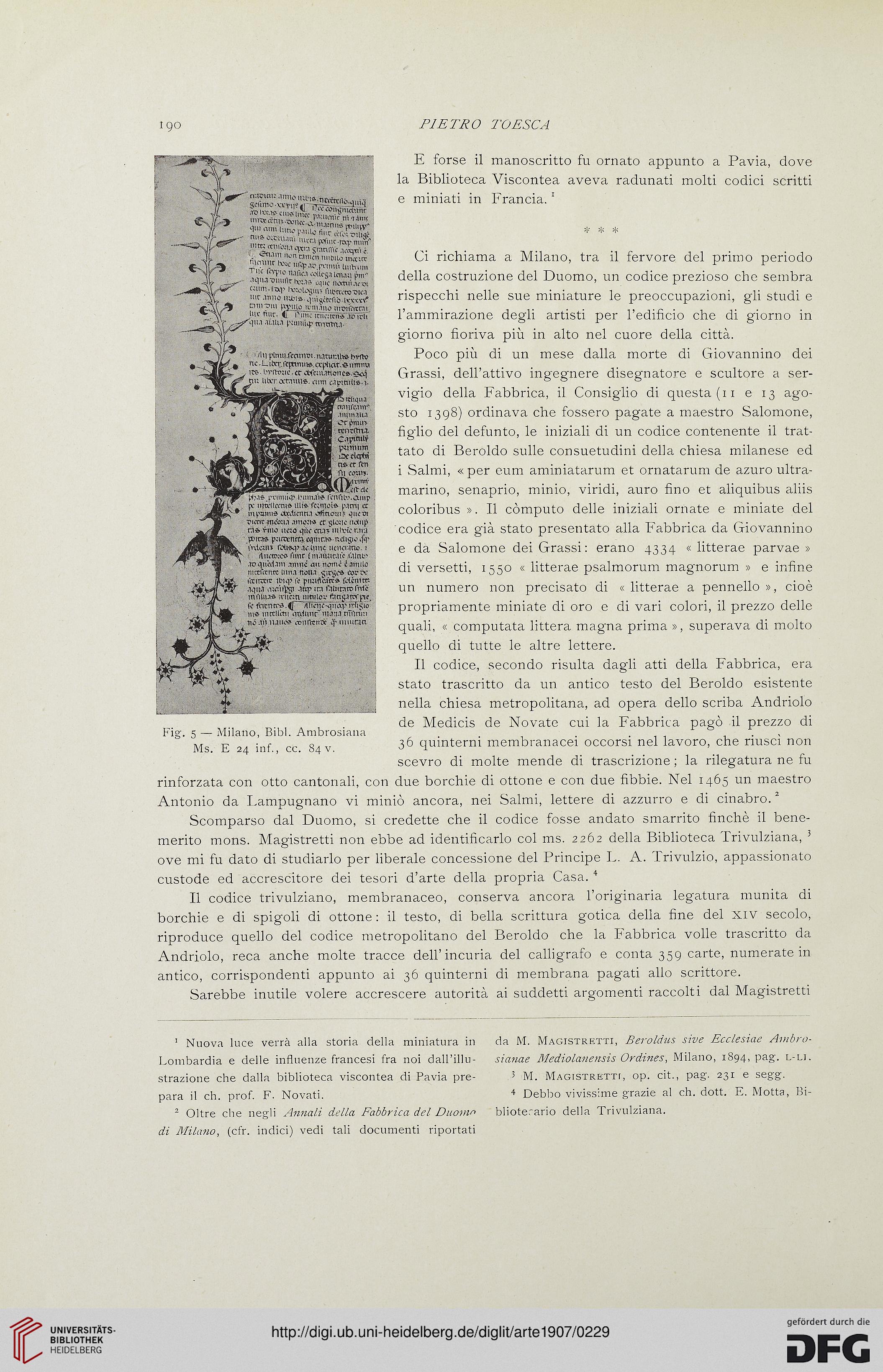PIETRO TOESCA
E forse il manoscritto fu ornato appunto a Pavia, dove
la Biblioteca Viscontea aveva radunati molti codici scritti
e miniati in Francia.1
* * *
Ci richiama a Milano, tra il fervore del primo periodo
della costruzione del Duomo, un codice prezioso che sembra
rispecchi nelle sue miniature le preoccupazioni, gii studi e
l’ammirazione degli artisti per l’edificio che di giorno in
giorno fioriva più in alto nel cuore della città.
Poco più di un mese dalla morte di Giovannino dei
Grassi, dell’attivo ingegnere disegnatore e scultore a ser-
vigio della Fabbrica, il Consiglio di questa (11 e 13 ago-
sto 1398) ordinava che fossero pagate a maestro Salomone,
figlio del defunto, le iniziali di un codice contenente il trat-
tato di Beroldo sulle consuetudini della chiesa milanese ed
i Salmi, «per eum aminiatarum et ornatarum de azuro ultra-
marino, senaprio, minio, viridi, auro fino et aliquibus aliis
coloribus ». Il computo delle iniziali ornate e miniate del
codice era già stato presentato alla Fabbrica da Giovannino
e da Salomone dei Grassi: erano 4334 « litterae parvae »
di versetti, 1550 « litterae psalmorum magnorum » e infine
un numero non precisato di « litterae a pennello », cioè
propriamente miniate di oro e di vari colori, il prezzo delle
quali, « computata littera magna prima », superava di molto
quello di tutte le altre lettere.
Il codice, secondo risulta dagli atti della Fabbrica, era
stato trascritto da un antico testo del Beroldo esistente
nella chiesa metropolitana, ad opera dello scriba Andriolo
de Medicis de Novate cui la Fabbrica pagò il prezzo di
36 quinterni membranacei occorsi nel lavoro, che riuscì non
scevro di molte mende di trascrizione ; la rilegatura ne fu
rinforzata con otto cantonali, con due borchie di ottone e con due fibbie. Nel 1465 un maestro
Antonio da Lampugnano vi miniò ancora, nei Salmi, lettere di azzurro e di cinabro.2
Scomparso dal Duomo, si credette che il codice fosse andato smarrito finché il bene-
merito mons. Magistretti non ebbe ad identificarlo col ms. 2262 della Biblioteca Trivulziana, 3
ove mi fu dato di studiarlo per liberale concessione del Principe L. A. Trivulzio, appassionato
custode ed accrescitore dei tesori d’arte della propria Casa. 4
Il codice trivulziano, membranaceo, conserva ancora l’originaria legatura munita di
borchie e di spigoli di ottone : il testo, di bella scrittura gotica della fine del Xiv secolo,
riproduce quello del codice metropolitano del Beroldo che la Fabbrica volle trascritto da
Andriolo, reca anche molte tracce dell’incuria del calligrafo e conta 359 carte, numerate in
antico, corrispondenti appunto ai 36 quinterni di membrana pagati allo scrittore.
Sarebbe inutile volere accrescere autorità ai suddetti argomenti raccolti dal Magistretti
190
tr.rpinu .inno , -
$eumo-vvyii?|! ,'T.Tr^'w :vluul
.ro ivi.» cn Juw, 44Ù Vurt',nr
mnv cr tir. ovile,- ' 4 Il,,r m 'T ',l"<
gm ami ittF
m«*W>Un'‘ intVi (xìiucl'iavmmf'
4™ Sronffic .vàtrù è
t'uwnr v'°n ?"K" mit"lù >n*;tr
Tl,v ,-lV ^ "'Tiv.fvimii Untumi
‘oltcS-i icn.i;i piti"
■ i-l i.l Dmuif tv;.iu ciptc noeti ti irvi
carni, uxp Ivieloijiut fuunvro-oic.l
111
run om uyiuo n mino iiivhVuxii
Utc ttur- t rime iruc:Tn»7tvirli
Ap^qu.l.lùU.UU
IMiUp ttnmn.1.
/Ili plmu.fccum» nitunUte h\-nv
nc.UitxiM'cpniime. cvpUcir.i&imtin.i
, i». t.'i-ftTCìc.et aVcnunoncs-.c-cij
JiUtxT.emuli*. ami c.ìpmui».i.
itlmu.1
ilIlfMW'.
.imiti.iu.i
or |>nui>
n.Tititii.1.
C.ipimlr
pAituiitn
Oc cicliti
ne- cr rcn
fu co-.ut-
/Tyuintl-
.\l4crt-cic
piM*.pvnniitp ì.’iim.i» rcnfilv.amp
(v njtcllcon» un* fermo» pimi cc
m panna av.1i cu tu cifmcni -• .pievi
■mene incoili .uno;» cr glene naiip
ri* vino uno .pio ciuf ni l vie rii.)
.para» ptireimrr.i cgmr.» r.digio.f.r
micini rotis.y io lime iicuci 'mc. i
rtuotrte* finir iiii.imir.nc fimi"
-lo o ned .un .mine ,m nome cimilo
marcenti: iint.i noni girgo* corvo
lixiraiv ìbup fc ptuirtò.m* facilitr.
.igni muntiti -lnpir.1 Cilunuvfnle
infilili* ivii«ti niwloy ftinvj.ircvpic,
fc iiicnn».<f iFciic-giiar irligio
ni* in reniti i nnltinr' in.i'i.i nTilnm
nòni nino* confitti» 4niiiir.tn
Fig. 5 — Milano, Bibl. Ambrosiana
Ms. E 24 inf., cc. 84 v.
1 Nuova luce verrà alla storia della miniatura in
Lombardia e delle influenze francesi fra noi dall’illu-
strazione che dalla biblioteca viscontea di Pavia pre-
para il eh. prof. F. Novati.
2 Oltre che negli Annali della Fabbrica del Duomo
di Milano, (cfr. indici) vedi tali documenti riportati
da M. Magistretti, Beroldus sive Ecclesiae Ambro-
sia7iae Mediolanensis Ordities, Milano, 1894, pag. l-li.
3 M. Magistretti, op. cit., pag. 231 e segg.
4 Debbo vivissime grazie al eh. dott. E. Motta, Bi-
blioterario della Trivulziana.
E forse il manoscritto fu ornato appunto a Pavia, dove
la Biblioteca Viscontea aveva radunati molti codici scritti
e miniati in Francia.1
* * *
Ci richiama a Milano, tra il fervore del primo periodo
della costruzione del Duomo, un codice prezioso che sembra
rispecchi nelle sue miniature le preoccupazioni, gii studi e
l’ammirazione degli artisti per l’edificio che di giorno in
giorno fioriva più in alto nel cuore della città.
Poco più di un mese dalla morte di Giovannino dei
Grassi, dell’attivo ingegnere disegnatore e scultore a ser-
vigio della Fabbrica, il Consiglio di questa (11 e 13 ago-
sto 1398) ordinava che fossero pagate a maestro Salomone,
figlio del defunto, le iniziali di un codice contenente il trat-
tato di Beroldo sulle consuetudini della chiesa milanese ed
i Salmi, «per eum aminiatarum et ornatarum de azuro ultra-
marino, senaprio, minio, viridi, auro fino et aliquibus aliis
coloribus ». Il computo delle iniziali ornate e miniate del
codice era già stato presentato alla Fabbrica da Giovannino
e da Salomone dei Grassi: erano 4334 « litterae parvae »
di versetti, 1550 « litterae psalmorum magnorum » e infine
un numero non precisato di « litterae a pennello », cioè
propriamente miniate di oro e di vari colori, il prezzo delle
quali, « computata littera magna prima », superava di molto
quello di tutte le altre lettere.
Il codice, secondo risulta dagli atti della Fabbrica, era
stato trascritto da un antico testo del Beroldo esistente
nella chiesa metropolitana, ad opera dello scriba Andriolo
de Medicis de Novate cui la Fabbrica pagò il prezzo di
36 quinterni membranacei occorsi nel lavoro, che riuscì non
scevro di molte mende di trascrizione ; la rilegatura ne fu
rinforzata con otto cantonali, con due borchie di ottone e con due fibbie. Nel 1465 un maestro
Antonio da Lampugnano vi miniò ancora, nei Salmi, lettere di azzurro e di cinabro.2
Scomparso dal Duomo, si credette che il codice fosse andato smarrito finché il bene-
merito mons. Magistretti non ebbe ad identificarlo col ms. 2262 della Biblioteca Trivulziana, 3
ove mi fu dato di studiarlo per liberale concessione del Principe L. A. Trivulzio, appassionato
custode ed accrescitore dei tesori d’arte della propria Casa. 4
Il codice trivulziano, membranaceo, conserva ancora l’originaria legatura munita di
borchie e di spigoli di ottone : il testo, di bella scrittura gotica della fine del Xiv secolo,
riproduce quello del codice metropolitano del Beroldo che la Fabbrica volle trascritto da
Andriolo, reca anche molte tracce dell’incuria del calligrafo e conta 359 carte, numerate in
antico, corrispondenti appunto ai 36 quinterni di membrana pagati allo scrittore.
Sarebbe inutile volere accrescere autorità ai suddetti argomenti raccolti dal Magistretti
190
tr.rpinu .inno , -
$eumo-vvyii?|! ,'T.Tr^'w :vluul
.ro ivi.» cn Juw, 44Ù Vurt',nr
mnv cr tir. ovile,- ' 4 Il,,r m 'T ',l"<
gm ami ittF
m«*W>Un'‘ intVi (xìiucl'iavmmf'
4™ Sronffic .vàtrù è
t'uwnr v'°n ?"K" mit"lù >n*;tr
Tl,v ,-lV ^ "'Tiv.fvimii Untumi
‘oltcS-i icn.i;i piti"
■ i-l i.l Dmuif tv;.iu ciptc noeti ti irvi
carni, uxp Ivieloijiut fuunvro-oic.l
111
run om uyiuo n mino iiivhVuxii
Utc ttur- t rime iruc:Tn»7tvirli
Ap^qu.l.lùU.UU
IMiUp ttnmn.1.
/Ili plmu.fccum» nitunUte h\-nv
nc.UitxiM'cpniime. cvpUcir.i&imtin.i
, i». t.'i-ftTCìc.et aVcnunoncs-.c-cij
JiUtxT.emuli*. ami c.ìpmui».i.
itlmu.1
ilIlfMW'.
.imiti.iu.i
or |>nui>
n.Tititii.1.
C.ipimlr
pAituiitn
Oc cicliti
ne- cr rcn
fu co-.ut-
/Tyuintl-
.\l4crt-cic
piM*.pvnniitp ì.’iim.i» rcnfilv.amp
(v njtcllcon» un* fermo» pimi cc
m panna av.1i cu tu cifmcni -• .pievi
■mene incoili .uno;» cr glene naiip
ri* vino uno .pio ciuf ni l vie rii.)
.para» ptireimrr.i cgmr.» r.digio.f.r
micini rotis.y io lime iicuci 'mc. i
rtuotrte* finir iiii.imir.nc fimi"
-lo o ned .un .mine ,m nome cimilo
marcenti: iint.i noni girgo* corvo
lixiraiv ìbup fc ptuirtò.m* facilitr.
.igni muntiti -lnpir.1 Cilunuvfnle
infilili* ivii«ti niwloy ftinvj.ircvpic,
fc iiicnn».<f iFciic-giiar irligio
ni* in reniti i nnltinr' in.i'i.i nTilnm
nòni nino* confitti» 4niiiir.tn
Fig. 5 — Milano, Bibl. Ambrosiana
Ms. E 24 inf., cc. 84 v.
1 Nuova luce verrà alla storia della miniatura in
Lombardia e delle influenze francesi fra noi dall’illu-
strazione che dalla biblioteca viscontea di Pavia pre-
para il eh. prof. F. Novati.
2 Oltre che negli Annali della Fabbrica del Duomo
di Milano, (cfr. indici) vedi tali documenti riportati
da M. Magistretti, Beroldus sive Ecclesiae Ambro-
sia7iae Mediolanensis Ordities, Milano, 1894, pag. l-li.
3 M. Magistretti, op. cit., pag. 231 e segg.
4 Debbo vivissime grazie al eh. dott. E. Motta, Bi-
blioterario della Trivulziana.