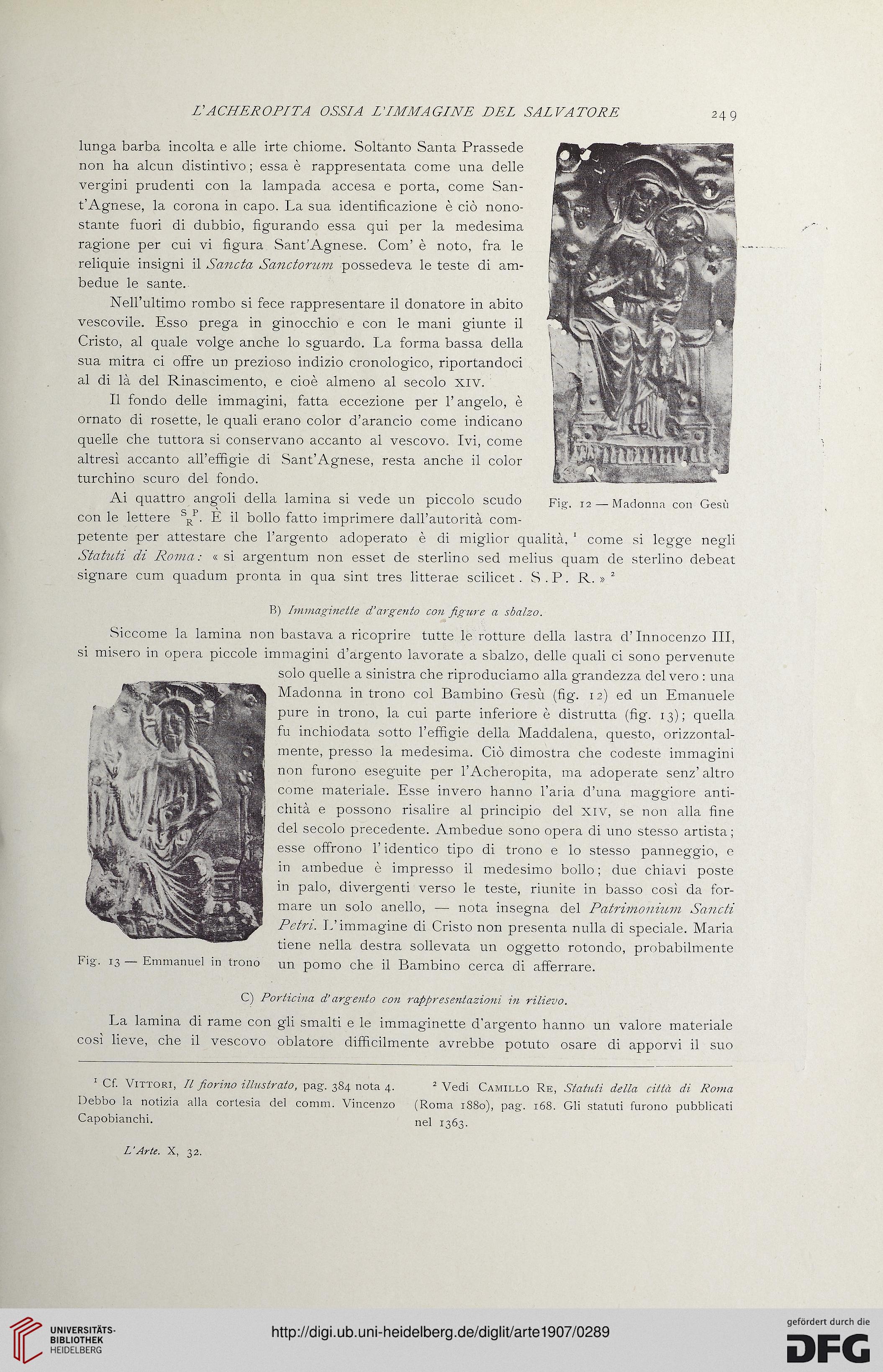L’ACHEROPITA OSSIA L'IMMAGINE DEL SALVATOLE
249
lunga barba incolta e alle irte chiome. Soltanto Santa Prassede
non ha alcun distintivo ; essa è rappresentata come una delle
vergini prudenti con la lampada accesa e porta, come San-
t’Agnese, la corona in capo. La sua identificazione è ciò nono-
stante fuori di dubbio, figurando essa qui per la medesima
ragione per cui vi figura Sant’Agnese. Com’ è noto, fra le
reliquie insigni il Sancta Scinctorum possedeva le teste di am-
bedue le sante.
Nell’ultimo rombo si fece rappresentare il donatore in abito
vescovile. Esso prega in ginocchio e con le mani giunte il
Cristo, al quale volge anche lo sguardo. La forma bassa della
sua mitra ci offre un prezioso indizio cronologico, riportandoci
al di là del Rinascimento, e cioè almeno al secolo xiv.
Il fondo delle immagini, fatta eccezione per l’angelo, è
ornato di rosette, le quali erano color d’arancio come indicano
quelle che tuttora si conservano accanto al vescovo. Ivi, come
altresì accanto all’effigie di Sant’Agnese, resta anche il color
turchino scuro del fondo.
Ai quattro angoli della lamina si vede un piccolo scudo
con le lettere SRP. E il bollo fatto imprimere dall’autorità com-
petente per attestare che l’argento adoperato è di miglior qualità, 1 come si legge negli
Statuti di Roma: « si argentimi non esset de steriino sed melius quam de steriino debeat
signare cum quadum pronta in qua sint tres litterae scilicet . S.P. R. » 2
B) Immaginette d’argento con figure a sbalzo.
Siccome la lamina non bastava a ricoprire tutte le rotture della lastra d’Innocenzo III,
si misero in opera piccole immagini d’argento lavorate a sbalzo, delle quali ci sono pervenute
solo quelle a sinistra che riproduciamo alla grandezza del vero : una
Madonna in trono col Bambino Gesù (fig. 12) ed un Emanuele
pure in trono, la cui parte inferiore è distrutta (fig. 13) ; quella
fu inchiodata sotto l’effigie della Maddalena, questo, orizzontal-
mente, presso la medesima. Ciò dimostra che codeste immagini
non furono eseguite per l’Acheropita, ma adoperate senz’ altro
come materiale. Esse invero hanno l’aria d’una maggiore anti-
chità e possono risalire al principio del XIV, se non alla fine
del secolo precedente. Ambedue sono opera di uno stesso artista;
esse offrono l’identico tipo di trono e lo stesso panneggio, e
in ambedue è impresso il medesimo bollo ; due chiavi poste
in palo, divergenti verso le teste, riunite in basso così da for-
mare un solo anello, — nota insegna del Patrimonium Sancii
Petm. L’immagine di Cristo non presenta nulla di speciale. Maria
tiene nella destra sollevata un oggetto rotondo, probabilmente
un pomo che il Bambino cerca di afferrare.
C) Porticina d’argento con rappresentazioni in rilievo.
La lamina di rame con gli smalti e le immaginette d’argento hanno un valore materiale
così lieve, che il vescovo oblatore difficilmente avrebbe potuto osare di apporvi il suo
1 Cf. Vittori, Il fiorino illustrato, pag. 384 nota 4. 2 Vedi Camillo Re, Statuti della città di Roma
Debbo la notizia alla cortesia del conuu. Vincenzo (Roma 1S80), pag. 168. Gli statuti furono pubblicati
Capobianchi. nel 1363.
L’Arte. X, 32.
249
lunga barba incolta e alle irte chiome. Soltanto Santa Prassede
non ha alcun distintivo ; essa è rappresentata come una delle
vergini prudenti con la lampada accesa e porta, come San-
t’Agnese, la corona in capo. La sua identificazione è ciò nono-
stante fuori di dubbio, figurando essa qui per la medesima
ragione per cui vi figura Sant’Agnese. Com’ è noto, fra le
reliquie insigni il Sancta Scinctorum possedeva le teste di am-
bedue le sante.
Nell’ultimo rombo si fece rappresentare il donatore in abito
vescovile. Esso prega in ginocchio e con le mani giunte il
Cristo, al quale volge anche lo sguardo. La forma bassa della
sua mitra ci offre un prezioso indizio cronologico, riportandoci
al di là del Rinascimento, e cioè almeno al secolo xiv.
Il fondo delle immagini, fatta eccezione per l’angelo, è
ornato di rosette, le quali erano color d’arancio come indicano
quelle che tuttora si conservano accanto al vescovo. Ivi, come
altresì accanto all’effigie di Sant’Agnese, resta anche il color
turchino scuro del fondo.
Ai quattro angoli della lamina si vede un piccolo scudo
con le lettere SRP. E il bollo fatto imprimere dall’autorità com-
petente per attestare che l’argento adoperato è di miglior qualità, 1 come si legge negli
Statuti di Roma: « si argentimi non esset de steriino sed melius quam de steriino debeat
signare cum quadum pronta in qua sint tres litterae scilicet . S.P. R. » 2
B) Immaginette d’argento con figure a sbalzo.
Siccome la lamina non bastava a ricoprire tutte le rotture della lastra d’Innocenzo III,
si misero in opera piccole immagini d’argento lavorate a sbalzo, delle quali ci sono pervenute
solo quelle a sinistra che riproduciamo alla grandezza del vero : una
Madonna in trono col Bambino Gesù (fig. 12) ed un Emanuele
pure in trono, la cui parte inferiore è distrutta (fig. 13) ; quella
fu inchiodata sotto l’effigie della Maddalena, questo, orizzontal-
mente, presso la medesima. Ciò dimostra che codeste immagini
non furono eseguite per l’Acheropita, ma adoperate senz’ altro
come materiale. Esse invero hanno l’aria d’una maggiore anti-
chità e possono risalire al principio del XIV, se non alla fine
del secolo precedente. Ambedue sono opera di uno stesso artista;
esse offrono l’identico tipo di trono e lo stesso panneggio, e
in ambedue è impresso il medesimo bollo ; due chiavi poste
in palo, divergenti verso le teste, riunite in basso così da for-
mare un solo anello, — nota insegna del Patrimonium Sancii
Petm. L’immagine di Cristo non presenta nulla di speciale. Maria
tiene nella destra sollevata un oggetto rotondo, probabilmente
un pomo che il Bambino cerca di afferrare.
C) Porticina d’argento con rappresentazioni in rilievo.
La lamina di rame con gli smalti e le immaginette d’argento hanno un valore materiale
così lieve, che il vescovo oblatore difficilmente avrebbe potuto osare di apporvi il suo
1 Cf. Vittori, Il fiorino illustrato, pag. 384 nota 4. 2 Vedi Camillo Re, Statuti della città di Roma
Debbo la notizia alla cortesia del conuu. Vincenzo (Roma 1S80), pag. 168. Gli statuti furono pubblicati
Capobianchi. nel 1363.
L’Arte. X, 32.