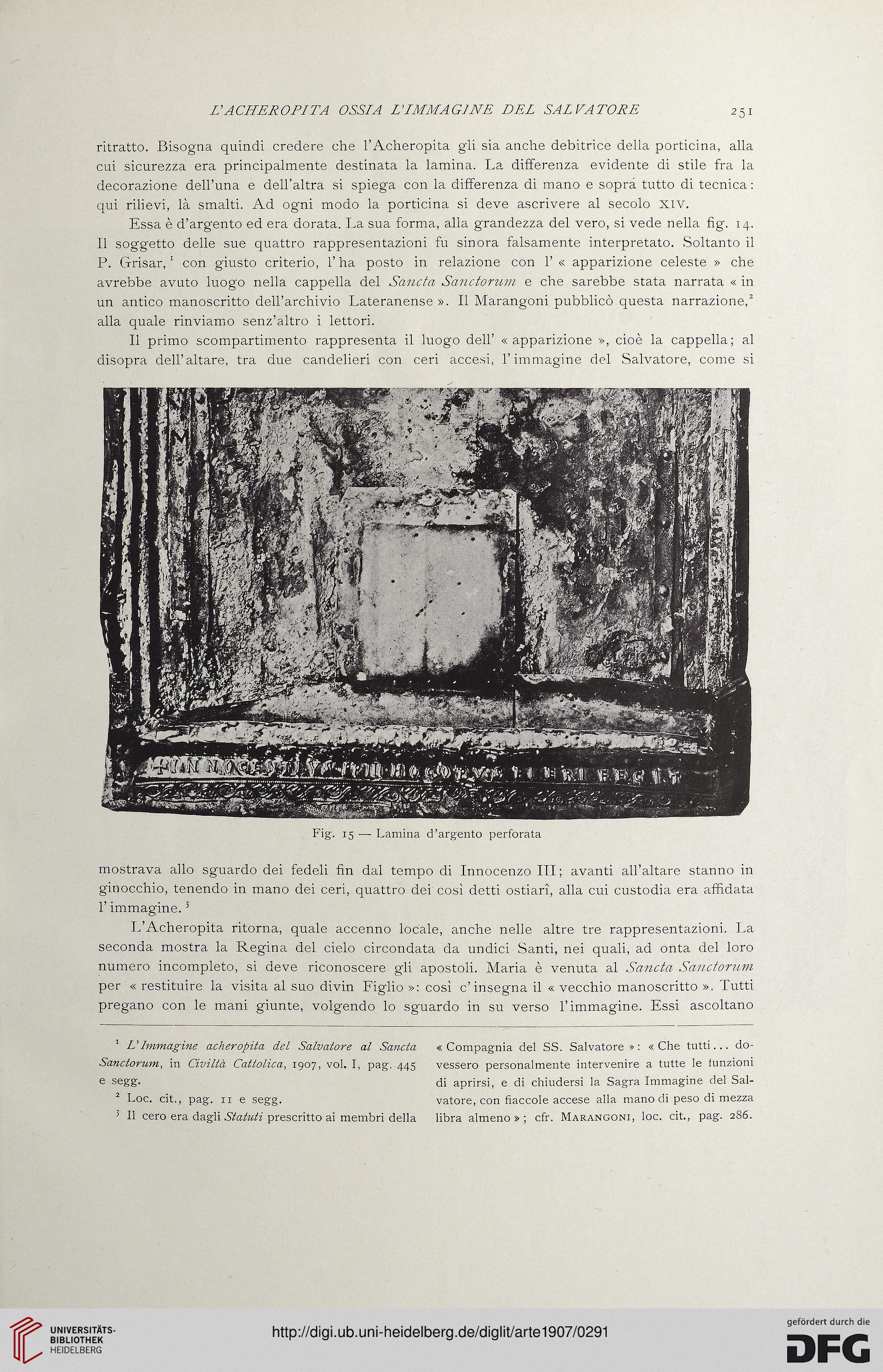Il AGITERÒ RITA OSSIA L'IMMAGINE DEL SALVATORE
251
ritratto. Bisogna quindi credere che l’Acheropita gli sia anche debitrice della porticina, alla
cui sicurezza era principalmente destinata la lamina. La differenza evidente di stile fra la
decorazione dell’una e dell’altra si spiega con la differenza di mano e sopra tutto di tecnica :
qui rilievi, là smalti. Ad ogni modo la porticina si deve ascrivere al secolo XIV.
Essa è d’argento ed era dorata. La sua forma, alla grandezza del vero, si vede nella fig. 14.
Il soggetto delle sue quattro rappresentazioni fu sinora falsamente interpretato. Soltanto il
P. Grisar,1 con giusto criterio, l’ha posto in relazione con 1’ « apparizione celeste » che
avrebbe avuto luogo nella cappella del Scinda Sandorum e che sarebbe stata narrata « in
un antico manoscritto dell’archivio Lateranense ». Il Marangoni pubblicò questa narrazione,1 2
alla quale rinviamo senz’altro i lettori.
Il primo scompartimento rappresenta il luogo dell’ «apparizione », cioè la cappella; al
disopra dell’altare, tra due candelieri con ceri accesi, l’immagine del Salvatore, come si
Fig. 15 — Lamina d’argento perforata
mostrava allo sguardo dei fedeli fin dal tempo di Innocenzo III; avanti all’altare stanno in
ginocchio, tenendo in mano dei ceri, quattro dei così detti ostiari, alla cui custodia era affidata
l’immagine.3
L’Acheropita ritorna, quale accenno locale, anche nelle altre tre rappresentazioni. La
seconda mostra la Regina del cielo circondata da undici Santi, nei quali, ad onta del loro
numero incompleto, sì deve riconoscere gli apostoli. Maria è venuta al Sanda Sandorum
per « restituire la visita al suo divin Figlio »: così c’insegna il « vecchio manoscritto ». lutti
pregano con le mani giunte, volgendo lo sguardo in su verso l’immagine. Essi ascoltano
1 L'Immagine acheropìta del Salvatore al Sancta
Sandorum, in Civiltà Cattolica, 1907, voi. I, pag. 445
e segg.
2 Loc. cit., pag. 11 e segg.
’ Il cero era dagli Statuti prescritto ai membri della
«Compagnia del SS. Salvatore »: «Che tutti... do-
vessero personalmente intervenire a tutte le funzioni
di aprirsi, e di chiudersi la Sagra Immagine del Sal-
vatore, con fiaccole accese alla mano di peso di mezza
libra almeno » ; cfr. Marangoni, loc. cit., pag. 286.
251
ritratto. Bisogna quindi credere che l’Acheropita gli sia anche debitrice della porticina, alla
cui sicurezza era principalmente destinata la lamina. La differenza evidente di stile fra la
decorazione dell’una e dell’altra si spiega con la differenza di mano e sopra tutto di tecnica :
qui rilievi, là smalti. Ad ogni modo la porticina si deve ascrivere al secolo XIV.
Essa è d’argento ed era dorata. La sua forma, alla grandezza del vero, si vede nella fig. 14.
Il soggetto delle sue quattro rappresentazioni fu sinora falsamente interpretato. Soltanto il
P. Grisar,1 con giusto criterio, l’ha posto in relazione con 1’ « apparizione celeste » che
avrebbe avuto luogo nella cappella del Scinda Sandorum e che sarebbe stata narrata « in
un antico manoscritto dell’archivio Lateranense ». Il Marangoni pubblicò questa narrazione,1 2
alla quale rinviamo senz’altro i lettori.
Il primo scompartimento rappresenta il luogo dell’ «apparizione », cioè la cappella; al
disopra dell’altare, tra due candelieri con ceri accesi, l’immagine del Salvatore, come si
Fig. 15 — Lamina d’argento perforata
mostrava allo sguardo dei fedeli fin dal tempo di Innocenzo III; avanti all’altare stanno in
ginocchio, tenendo in mano dei ceri, quattro dei così detti ostiari, alla cui custodia era affidata
l’immagine.3
L’Acheropita ritorna, quale accenno locale, anche nelle altre tre rappresentazioni. La
seconda mostra la Regina del cielo circondata da undici Santi, nei quali, ad onta del loro
numero incompleto, sì deve riconoscere gli apostoli. Maria è venuta al Sanda Sandorum
per « restituire la visita al suo divin Figlio »: così c’insegna il « vecchio manoscritto ». lutti
pregano con le mani giunte, volgendo lo sguardo in su verso l’immagine. Essi ascoltano
1 L'Immagine acheropìta del Salvatore al Sancta
Sandorum, in Civiltà Cattolica, 1907, voi. I, pag. 445
e segg.
2 Loc. cit., pag. 11 e segg.
’ Il cero era dagli Statuti prescritto ai membri della
«Compagnia del SS. Salvatore »: «Che tutti... do-
vessero personalmente intervenire a tutte le funzioni
di aprirsi, e di chiudersi la Sagra Immagine del Sal-
vatore, con fiaccole accese alla mano di peso di mezza
libra almeno » ; cfr. Marangoni, loc. cit., pag. 286.