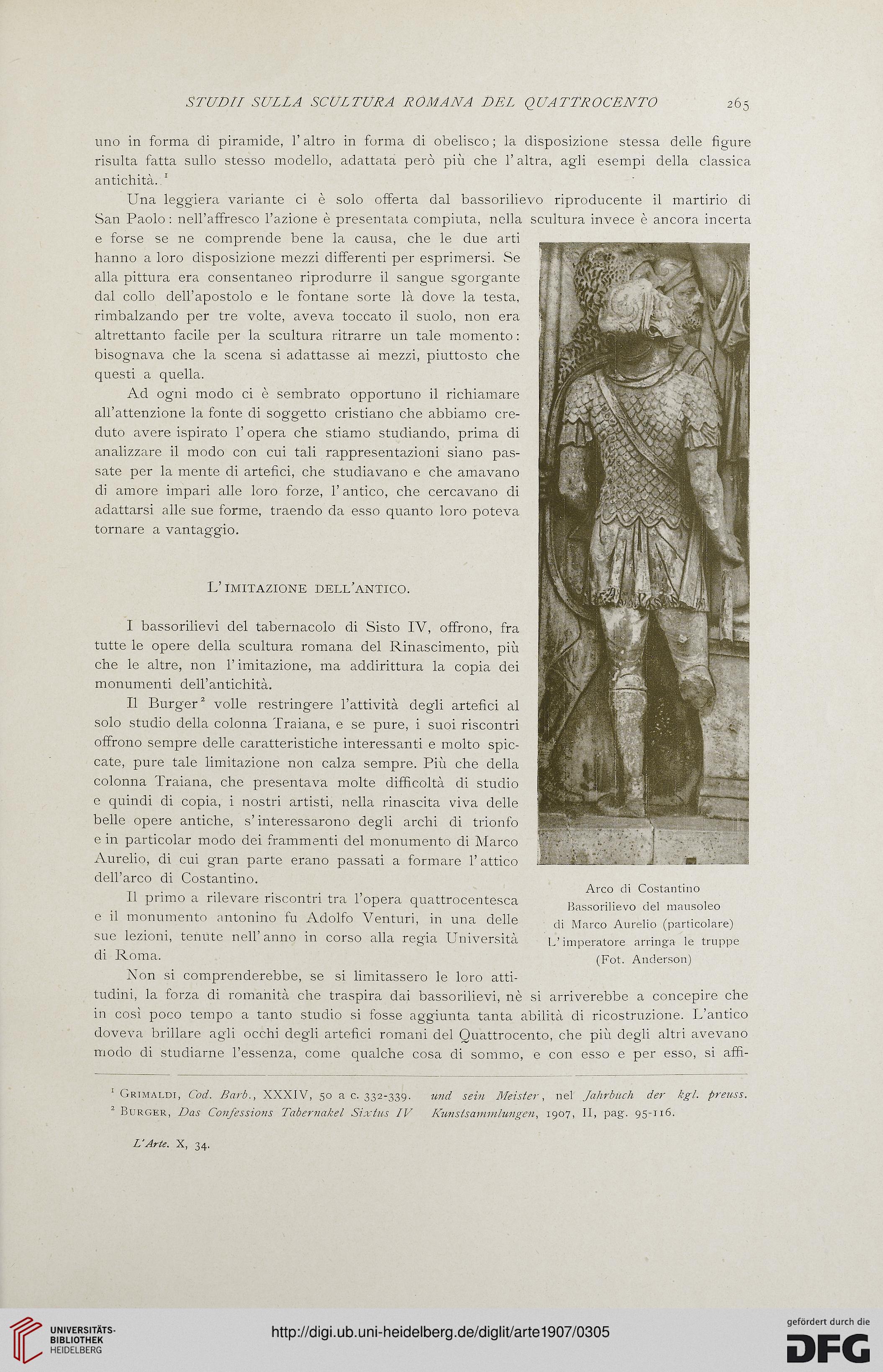STUDI/ SULLA SCULTURA ROMANA DEL QUATTROCENTO
265
uno in forma eli piramide, l’altro in forma di obelisco; la disposizione stessa delle figure
risulta fatta sullo stesso modello, adattata però più che l’altra, agli esempi della classica
antichità. 1
Una leggiera variante ci è solo offerta dal bassorilievo riproducente il martirio di
San Paolo: nell’affresco l’azione è presentata compiuta, nella scultura invece è ancora incerta
e forse se ne comprende bene la causa, che le due arti
hanno a loro disposizione mezzi differenti per esprimersi. Se
alla pittura era consentaneo riprodurre il sangue sgorgante
dal collo dell’apostolo e le fontane sorte là dove la testa,
rimbalzando per tre volte, aveva toccato il suolo, non era
altrettanto facile per la scultura ritrarre un tale momento :
bisognava che la scena si adattasse ai mezzi, piuttosto che
questi a quella.
Ad ogni modo ci è sembrato opportuno il richiamare
all’attenzione la fonte di soggetto cristiano che abbiamo cre-
duto avere ispirato l’opera che stiamo studiando, prima di
analizzare il modo con cui tali rappresentazioni siano pas-
sate per la mente di artefici, che studiavano e che amavano
di amore impari alle loro forze, l’antico, che cercavano di
adattarsi alle sue forme, traendo da esso quanto loro poteva
tornare a vantaggio.
V IMITAZIONE DELL’ANTICO.
I bassorilievi del tabernacolo di Sisto IV, offrono, fra
tutte le opere della scultura romana del Rinascimento, più
che le altre, non l’imitazione, ma addirittura la copia dei
monumenti dell’antichità.
II Burger1 2 volle restringere l’attività degli artefici al
solo studio della colonna Traiana, e se pure, i suoi riscontri
offrono sempre delle caratteristiche mteressanti e molto spic-
cate, pure tale limitazione non calza sempre. Più che della
colonna Traiana, che presentava molte difficoltà di studio
e quindi di copia, i nostri artisti, nella rinascita viva delle
belle opere antiche, s’interessarono degli archi di trionfo
e in particolar modo dei frammenti del monumento di Marco
Aurelio, di cui gran parte erano passati a formare l’attico
dell’arco di Costantino.
Il primo a rilevare riscontri tra l’opera quattrocentesca
e il monumento antonino fu Adolfo Venturi, in una delle
sue lezioni, tenute nell’anno in corso alla regia Università
di Roma.
Non si comprenderebbe, se si limitassero le loro atti-
tudini, la forza di romanità che traspira dai bassorilievi, nè si arriverebbe a concepire che
in così poco tempo a tanto studio si fosse aggiunta tanta abilità di ricostruzione. L’antico
doveva brillare agli occhi degli artefici romani del Quattrocento, che più degli altri avevano
modo di studiarne l’essenza, come qualche cosa di sommo, e con esso e per esso, si affi-
Arco di Costantino
Bassorilievo del mausoleo
di Marco Aurelio (particolare)
L’imperatore arringa le truppe
(Fot. Anderson)
1 Grimaldi, Cod. Barb., XXXIV, 50 a c. 332-339. u?id sein Meister, nel Jahrbuch der kg/, preuss.
2 Burger, Das Confessions Tabernakel Sixtus IV Kunstsammlungen, 1907, II, pag. 95-116.
L'Arte. X, 34.
265
uno in forma eli piramide, l’altro in forma di obelisco; la disposizione stessa delle figure
risulta fatta sullo stesso modello, adattata però più che l’altra, agli esempi della classica
antichità. 1
Una leggiera variante ci è solo offerta dal bassorilievo riproducente il martirio di
San Paolo: nell’affresco l’azione è presentata compiuta, nella scultura invece è ancora incerta
e forse se ne comprende bene la causa, che le due arti
hanno a loro disposizione mezzi differenti per esprimersi. Se
alla pittura era consentaneo riprodurre il sangue sgorgante
dal collo dell’apostolo e le fontane sorte là dove la testa,
rimbalzando per tre volte, aveva toccato il suolo, non era
altrettanto facile per la scultura ritrarre un tale momento :
bisognava che la scena si adattasse ai mezzi, piuttosto che
questi a quella.
Ad ogni modo ci è sembrato opportuno il richiamare
all’attenzione la fonte di soggetto cristiano che abbiamo cre-
duto avere ispirato l’opera che stiamo studiando, prima di
analizzare il modo con cui tali rappresentazioni siano pas-
sate per la mente di artefici, che studiavano e che amavano
di amore impari alle loro forze, l’antico, che cercavano di
adattarsi alle sue forme, traendo da esso quanto loro poteva
tornare a vantaggio.
V IMITAZIONE DELL’ANTICO.
I bassorilievi del tabernacolo di Sisto IV, offrono, fra
tutte le opere della scultura romana del Rinascimento, più
che le altre, non l’imitazione, ma addirittura la copia dei
monumenti dell’antichità.
II Burger1 2 volle restringere l’attività degli artefici al
solo studio della colonna Traiana, e se pure, i suoi riscontri
offrono sempre delle caratteristiche mteressanti e molto spic-
cate, pure tale limitazione non calza sempre. Più che della
colonna Traiana, che presentava molte difficoltà di studio
e quindi di copia, i nostri artisti, nella rinascita viva delle
belle opere antiche, s’interessarono degli archi di trionfo
e in particolar modo dei frammenti del monumento di Marco
Aurelio, di cui gran parte erano passati a formare l’attico
dell’arco di Costantino.
Il primo a rilevare riscontri tra l’opera quattrocentesca
e il monumento antonino fu Adolfo Venturi, in una delle
sue lezioni, tenute nell’anno in corso alla regia Università
di Roma.
Non si comprenderebbe, se si limitassero le loro atti-
tudini, la forza di romanità che traspira dai bassorilievi, nè si arriverebbe a concepire che
in così poco tempo a tanto studio si fosse aggiunta tanta abilità di ricostruzione. L’antico
doveva brillare agli occhi degli artefici romani del Quattrocento, che più degli altri avevano
modo di studiarne l’essenza, come qualche cosa di sommo, e con esso e per esso, si affi-
Arco di Costantino
Bassorilievo del mausoleo
di Marco Aurelio (particolare)
L’imperatore arringa le truppe
(Fot. Anderson)
1 Grimaldi, Cod. Barb., XXXIV, 50 a c. 332-339. u?id sein Meister, nel Jahrbuch der kg/, preuss.
2 Burger, Das Confessions Tabernakel Sixtus IV Kunstsammlungen, 1907, II, pag. 95-116.
L'Arte. X, 34.