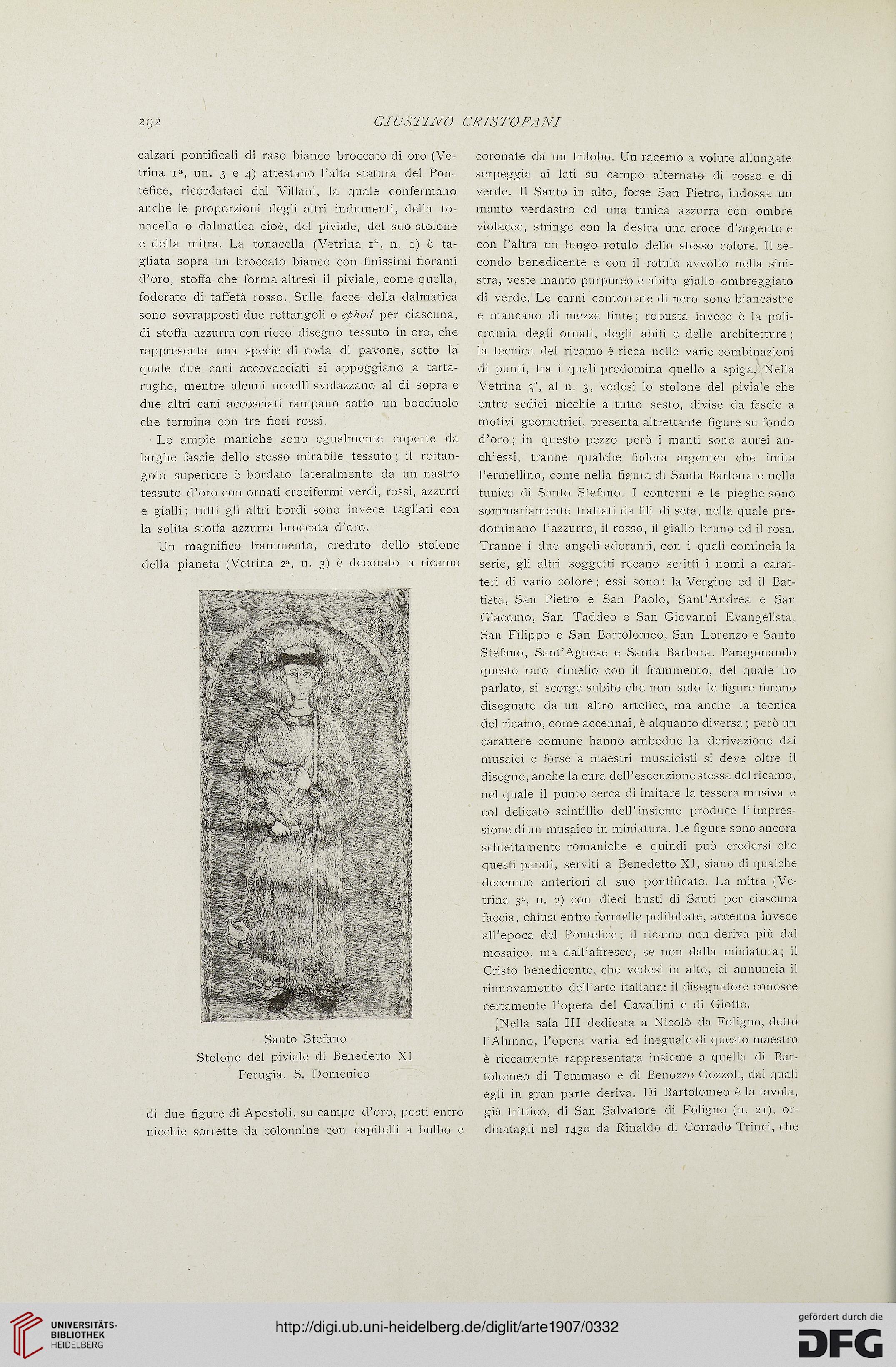292
GIUSTINO CRISTOFANI
calzari pontificali di raso bianco broccato di oro (Ve-
trina ia, nn. 3 e 4) attestano l’alta statura del Pon-
tefice, ricordataci dal Villani, la quale confermano
anche le proporzioni degli altri indumenti, della to-
nacella o dalmatica cioè, del piviale, del suo stolone
e della mitra. La tonacella (Vetrina ia, n. 1) è ta-
gliata sopra un broccato bianco con finissimi fiorami
d’oro, stoffa che forma altresì il piviale, come quella,
foderato di taffetà rosso. Sulle facce della dalmatica
sono sovrapposti due rettangoli o ephod per ciascuna,
di stoffa azzurra con ricco disegno tessuto in oro, che
rappresenta una specie di coda di pavone, sotto la
quale due cani accovacciati si appoggiano a tarta-
rughe, mentre alcuni uccelli svolazzano al di sopra e
due altri cani accosciati rampano sotto un bocciuolo
che termina con tre fiori rossi.
Le ampie maniche sono egualmente coperte da
larghe fascie dello stesso mirabile tessuto ; il rettan-
golo superiore è bordato lateralmente da un nastro
tessuto d’oro con ornati crociformi verdi, rossi, azzurri
e gialli ; tutti gli altri bordi sono invece tagliati con
la solita stoffa azzurra broccata d’oro.
Un magnifico frammento, creduto dello stolone
della pianeta (Vetrina 2a, n. 3) è decorato a ricamo
Santo Stefano
Stolone del piviale di Benedetto XI
Perugia. S. Domenico
di due figure di Apostoli, su campo d’oro, posti entro
nicchie sorrette da colonnine con capitelli a bulbo e
coronate da un trilobo. Un racemo a volute allungate
serpeggia ai lati su campo alternato di rosso e di
verde. Il Santo in alto, forse San Pietro, indossa un
manto verdastro ed una tunica azzurra con ombre
violacee, stringe con la destra una croce d’argento e
con l’altra un lungo rotulo dello stesso colore. Il se-
condo benedicente e con il rotulo avvolto nella sini-
stra, veste manto purpureo e abito giallo ombreggiato
di verde. Le carni contornate di nero sono biancastre
e mancano di mezze tinte; robusta invece è la poli-
cromia degli ornati, degli abiti e delle architetture;
la tecnica del ricamo è ricca nelle varie combinazioni
di punti, tra i quali predomina quello a spiga. Nella
Vetrina 3’, al n. 3, vedesi lo stolone del piviale che
entro sedici nicchie a tutto sesto, divise da fascie a
motivi geometrici, presenta altrettante figure su fondo
d’oro ; in questo pezzo però i manti sono aurei an-
ch’essi, tranne qualche fodera argentea che imita
l’ermellino, come nella figura di Santa Barbara e nella
tunica di Santo Stefano. I contorni e le pieghe sono
sommariamente trattati da fili di seta, nella quale pre-
dominano l’azzurro, il rosso, il giallo bruno ed il rosa.
Tranne i due angeli adoranti, con i quali comincia la
serie, gli altri soggetti recano scritti i nomi a carat-
teri di vario colore; essi sono: la Vergine ed il Bat-
tista, San Pietro e San Paolo, Sant’Andrea e San
Giacomo, San Taddeo e San Giovanni Evangelista,
San Filippo e San Bartolomeo, San Lorenzo e Santo
Stefano, Sant’Agnese e Santa Barbara. Paragonando
questo raro cimelio con il frammento, del quale ho
parlato, si scorge subito che non solo le figure furono
disegnate da un altro artefice, ma anche la tecnica
del ricamo, come accennai, è alquanto diversa ; però un
carattere comune hanno ambedue la derivazione dai
musaici e forse a maestri musaicisti si deve oltre il
disegno, anche la cura dell’esecuzione stessa del ricamo,
nel quale il punto cerca di imitare la tessera musiva e
col delicato scintillìo dell’insieme produce l’impres-
sione di un musaico in miniatura. Le figure sono ancora
schiettamente romaniche e quindi può credersi che
questi parati, serviti a Benedetto XI, siano di qualche
decennio anteriori al suo pontificato. La mitra (Ve-
trina 3a, n. 2) con dieci busti di Santi per ciascuna
faccia, chiusi entro formelle polilobate, accenna invece
all’epoca del Pontefice; il ricamo non deriva più dal
mosaico, ma dall’affresco, se non dalla miniatura; il
Cristo benedicente, che vedesi in alto, ci annuncia il
rinnovamento dell’arte italiana: il disegnatore conosce
certamente l’opera del Cavallini e di Giotto.
[Nella sala III dedicata a Nicolò da Foligno, detto
l’Alunno, l’opera varia ed ineguale di questo maestro
è riccamente rappresentata insieme a quella di Bar-
tolomeo di Tommaso e di Benozzo Gozzoli, dai quali
egli in gran parte deriva. Di Bartolomeo è la tavola,
già trittico, di San Salvatore di Foligno (n. 21), or-
dinatagli nel 1430 da Rinaldo di Corrado Trinci, che
GIUSTINO CRISTOFANI
calzari pontificali di raso bianco broccato di oro (Ve-
trina ia, nn. 3 e 4) attestano l’alta statura del Pon-
tefice, ricordataci dal Villani, la quale confermano
anche le proporzioni degli altri indumenti, della to-
nacella o dalmatica cioè, del piviale, del suo stolone
e della mitra. La tonacella (Vetrina ia, n. 1) è ta-
gliata sopra un broccato bianco con finissimi fiorami
d’oro, stoffa che forma altresì il piviale, come quella,
foderato di taffetà rosso. Sulle facce della dalmatica
sono sovrapposti due rettangoli o ephod per ciascuna,
di stoffa azzurra con ricco disegno tessuto in oro, che
rappresenta una specie di coda di pavone, sotto la
quale due cani accovacciati si appoggiano a tarta-
rughe, mentre alcuni uccelli svolazzano al di sopra e
due altri cani accosciati rampano sotto un bocciuolo
che termina con tre fiori rossi.
Le ampie maniche sono egualmente coperte da
larghe fascie dello stesso mirabile tessuto ; il rettan-
golo superiore è bordato lateralmente da un nastro
tessuto d’oro con ornati crociformi verdi, rossi, azzurri
e gialli ; tutti gli altri bordi sono invece tagliati con
la solita stoffa azzurra broccata d’oro.
Un magnifico frammento, creduto dello stolone
della pianeta (Vetrina 2a, n. 3) è decorato a ricamo
Santo Stefano
Stolone del piviale di Benedetto XI
Perugia. S. Domenico
di due figure di Apostoli, su campo d’oro, posti entro
nicchie sorrette da colonnine con capitelli a bulbo e
coronate da un trilobo. Un racemo a volute allungate
serpeggia ai lati su campo alternato di rosso e di
verde. Il Santo in alto, forse San Pietro, indossa un
manto verdastro ed una tunica azzurra con ombre
violacee, stringe con la destra una croce d’argento e
con l’altra un lungo rotulo dello stesso colore. Il se-
condo benedicente e con il rotulo avvolto nella sini-
stra, veste manto purpureo e abito giallo ombreggiato
di verde. Le carni contornate di nero sono biancastre
e mancano di mezze tinte; robusta invece è la poli-
cromia degli ornati, degli abiti e delle architetture;
la tecnica del ricamo è ricca nelle varie combinazioni
di punti, tra i quali predomina quello a spiga. Nella
Vetrina 3’, al n. 3, vedesi lo stolone del piviale che
entro sedici nicchie a tutto sesto, divise da fascie a
motivi geometrici, presenta altrettante figure su fondo
d’oro ; in questo pezzo però i manti sono aurei an-
ch’essi, tranne qualche fodera argentea che imita
l’ermellino, come nella figura di Santa Barbara e nella
tunica di Santo Stefano. I contorni e le pieghe sono
sommariamente trattati da fili di seta, nella quale pre-
dominano l’azzurro, il rosso, il giallo bruno ed il rosa.
Tranne i due angeli adoranti, con i quali comincia la
serie, gli altri soggetti recano scritti i nomi a carat-
teri di vario colore; essi sono: la Vergine ed il Bat-
tista, San Pietro e San Paolo, Sant’Andrea e San
Giacomo, San Taddeo e San Giovanni Evangelista,
San Filippo e San Bartolomeo, San Lorenzo e Santo
Stefano, Sant’Agnese e Santa Barbara. Paragonando
questo raro cimelio con il frammento, del quale ho
parlato, si scorge subito che non solo le figure furono
disegnate da un altro artefice, ma anche la tecnica
del ricamo, come accennai, è alquanto diversa ; però un
carattere comune hanno ambedue la derivazione dai
musaici e forse a maestri musaicisti si deve oltre il
disegno, anche la cura dell’esecuzione stessa del ricamo,
nel quale il punto cerca di imitare la tessera musiva e
col delicato scintillìo dell’insieme produce l’impres-
sione di un musaico in miniatura. Le figure sono ancora
schiettamente romaniche e quindi può credersi che
questi parati, serviti a Benedetto XI, siano di qualche
decennio anteriori al suo pontificato. La mitra (Ve-
trina 3a, n. 2) con dieci busti di Santi per ciascuna
faccia, chiusi entro formelle polilobate, accenna invece
all’epoca del Pontefice; il ricamo non deriva più dal
mosaico, ma dall’affresco, se non dalla miniatura; il
Cristo benedicente, che vedesi in alto, ci annuncia il
rinnovamento dell’arte italiana: il disegnatore conosce
certamente l’opera del Cavallini e di Giotto.
[Nella sala III dedicata a Nicolò da Foligno, detto
l’Alunno, l’opera varia ed ineguale di questo maestro
è riccamente rappresentata insieme a quella di Bar-
tolomeo di Tommaso e di Benozzo Gozzoli, dai quali
egli in gran parte deriva. Di Bartolomeo è la tavola,
già trittico, di San Salvatore di Foligno (n. 21), or-
dinatagli nel 1430 da Rinaldo di Corrado Trinci, che