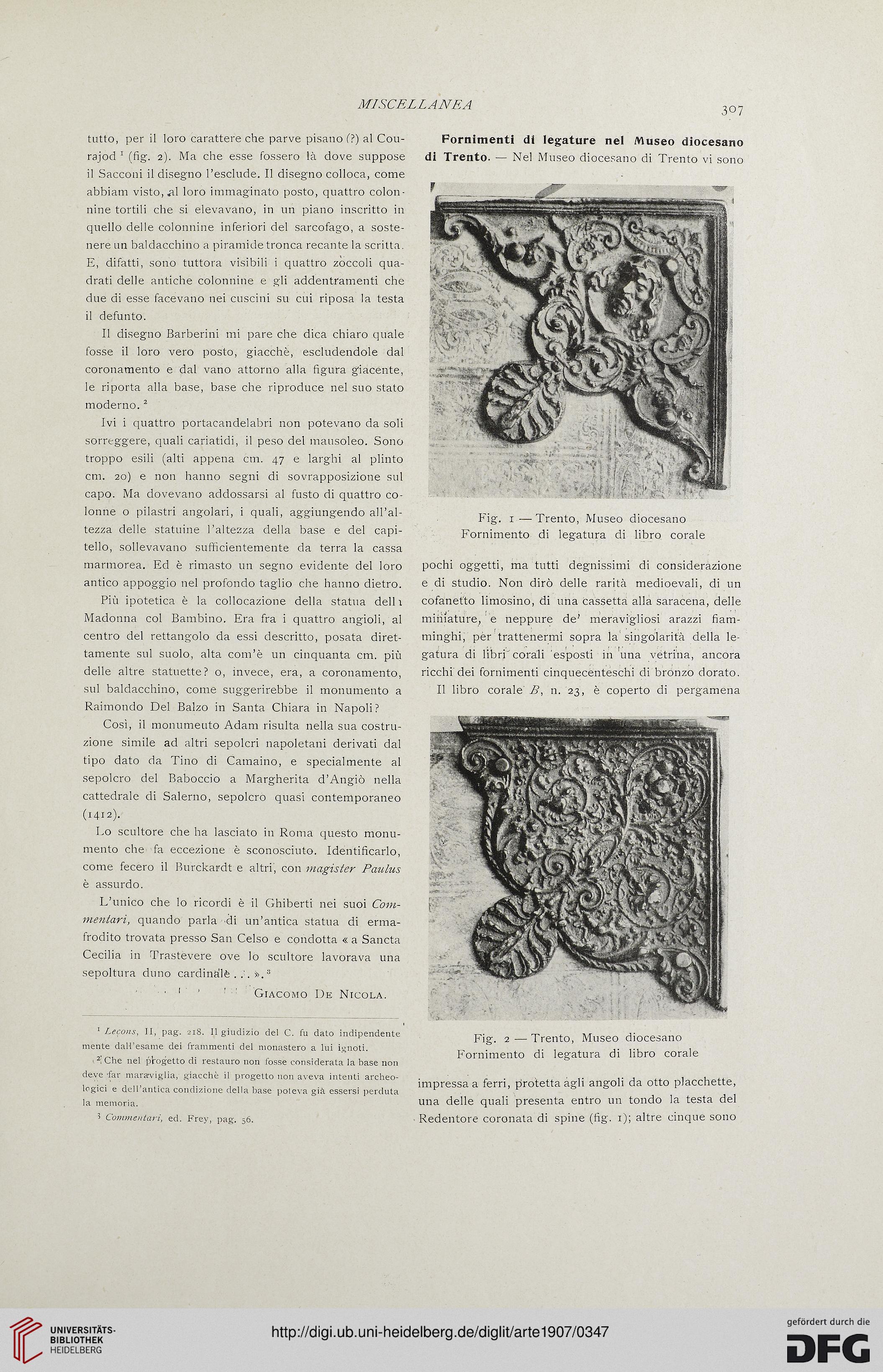MISCELLANEA
307
tutto, per il loro carattere che parve pisano (?) al Cou-
rajod 1 (fig. 2). Ma che esse fossero là dove suppose
il Sacconi il disegno l’esclude. Il disegno colloca, come
abbiam visto, <rl loro immaginato posto, quattro colon-
nine tortili che si elevavano, in un piano inscritto in
quello delle colonnine inferiori del sarcofago, a soste-
nere un baldacchino a piramide tronca recante la scritta.
E, difatti, sono tuttora visibili i quattro zoccoli qua-
drati delle antiche colonnine e gli addentramenti che
due di esse facevano nei cuscini su cui riposa la testa
il defunto.
Il disegno Barberini mi pare che dica chiaro quale
fosse il loro vero posto, giacche, escludendole dal
coronamento e dal vano attorno alla figura giacente,
le riporta alla base, base che riproduce nel suo stato
moderno.2
Ivi i quattro portacandelabri non potevano da soli
sorreggere, quali cariatidi, il peso del mausoleo. Sono
troppo esili (alti appena ctn. 47 e larghi al plinto
era. 20) e non hanno segni di sovrapposizione sul
capo. Ma dovevano addossarsi al fusto di quattro co-
lonne o pilastri angolari, i quali, aggiungendo all’al-
tezza delle statuine l’altezza della base e del capi-
tello, sollevavano sufficientemente da terra la cassa
marmorea. Ed è rimasto un segno evidente del loro
antico appoggio nel profondo taglio che hanno dietro.
Più ipotetica è la collocazione della statua dell a
Madonna col Bambino. Era fra i quattro angioligai
centro del rettangolo da essi descritto, posata diret-
tamente sul suolo, alta com’è un cinquanta cm. più
delle altre statuette? o, invece, era, a coronamento,
sul baldacchino, come suggerirebbe il monumento a
Raimondo Del Balzo in Santa Chiara in Napoli?
Così, il monumento Adam risulta nella sua costru-
zione simile ad altri sepolcri napoletani derivati dal
tipo dato da Tino di Catnaino, e specialmente al
sepolcro del Baboccio a Margherita d’Angiò nella
cattedrale di Salerno, sepolcro quasi contemporaneo
(1412).
Lo scultore che ha lasciato in Roma questo monu-
mento che fa eccezione è sconosciuto. Identificarlo,
come fecero il Burckardt e altri, con magister Paulus
è assurdo.
L’unico che lo ricordi è il Ghiberti nei suoi Com-
mentari, quando parla di un’antica statua di erma-
frodito trovata presso San Celso e condotta « a Sancta
Cecilia in Trastevere ove lo scultore lavorava una
sepoltura duno cardinàlè 3 * 5
■ 1 1 ’ Giacomo De Nicola.
1 Lecons, II, pag. 218. Il giudizio del C. fu dato indipendente
mente daH’esame dei frammenti del monastero a lui ignoti.
A Che nel progetto di restauro non fosse considerata la base non
deve -far mara-viglia,' giacché il progetto non aveva intenti archeo-
logici e dell’antica condizione della base poteva già essersi perduta
la memoria.
5 Commentari, ed. Frey, pag. 56.
Fornimenti di legature nel Museo diocesano
di Trento. — Nel Museo diocesano di Trento vi sono
Fig. 1—Trento, Museo diocesano
Fornimento di legatura di libro corale
pochi oggetti, ma tutti degnissimi di considerazione
e di studio. Non dirò delle rarità medioevali, di un
cofanetto limosino, di una cassetta alla saracena, delle
miniature, e neppure de’ meravigliosi arazzi fiam-
minghi, pèr trattenermi sopra la singolarità della le-
gatura di libri- corali esposti in una vetrina, ancora
ricchi dei fornimenti cinquecenteschi di bronzo dorato.
Il libro corale B, n. 23, è coperto di pergamena
Fig. 2 — Trento, Museo diocesano
Fornimento di legatura di libro corale
impressa a ferri, protetta agli angoli da otto placchette,
una delle quali presenta entro un tondo la testa del
Redentore coronata di spine (fig. 1); altre cinque sono
307
tutto, per il loro carattere che parve pisano (?) al Cou-
rajod 1 (fig. 2). Ma che esse fossero là dove suppose
il Sacconi il disegno l’esclude. Il disegno colloca, come
abbiam visto, <rl loro immaginato posto, quattro colon-
nine tortili che si elevavano, in un piano inscritto in
quello delle colonnine inferiori del sarcofago, a soste-
nere un baldacchino a piramide tronca recante la scritta.
E, difatti, sono tuttora visibili i quattro zoccoli qua-
drati delle antiche colonnine e gli addentramenti che
due di esse facevano nei cuscini su cui riposa la testa
il defunto.
Il disegno Barberini mi pare che dica chiaro quale
fosse il loro vero posto, giacche, escludendole dal
coronamento e dal vano attorno alla figura giacente,
le riporta alla base, base che riproduce nel suo stato
moderno.2
Ivi i quattro portacandelabri non potevano da soli
sorreggere, quali cariatidi, il peso del mausoleo. Sono
troppo esili (alti appena ctn. 47 e larghi al plinto
era. 20) e non hanno segni di sovrapposizione sul
capo. Ma dovevano addossarsi al fusto di quattro co-
lonne o pilastri angolari, i quali, aggiungendo all’al-
tezza delle statuine l’altezza della base e del capi-
tello, sollevavano sufficientemente da terra la cassa
marmorea. Ed è rimasto un segno evidente del loro
antico appoggio nel profondo taglio che hanno dietro.
Più ipotetica è la collocazione della statua dell a
Madonna col Bambino. Era fra i quattro angioligai
centro del rettangolo da essi descritto, posata diret-
tamente sul suolo, alta com’è un cinquanta cm. più
delle altre statuette? o, invece, era, a coronamento,
sul baldacchino, come suggerirebbe il monumento a
Raimondo Del Balzo in Santa Chiara in Napoli?
Così, il monumento Adam risulta nella sua costru-
zione simile ad altri sepolcri napoletani derivati dal
tipo dato da Tino di Catnaino, e specialmente al
sepolcro del Baboccio a Margherita d’Angiò nella
cattedrale di Salerno, sepolcro quasi contemporaneo
(1412).
Lo scultore che ha lasciato in Roma questo monu-
mento che fa eccezione è sconosciuto. Identificarlo,
come fecero il Burckardt e altri, con magister Paulus
è assurdo.
L’unico che lo ricordi è il Ghiberti nei suoi Com-
mentari, quando parla di un’antica statua di erma-
frodito trovata presso San Celso e condotta « a Sancta
Cecilia in Trastevere ove lo scultore lavorava una
sepoltura duno cardinàlè 3 * 5
■ 1 1 ’ Giacomo De Nicola.
1 Lecons, II, pag. 218. Il giudizio del C. fu dato indipendente
mente daH’esame dei frammenti del monastero a lui ignoti.
A Che nel progetto di restauro non fosse considerata la base non
deve -far mara-viglia,' giacché il progetto non aveva intenti archeo-
logici e dell’antica condizione della base poteva già essersi perduta
la memoria.
5 Commentari, ed. Frey, pag. 56.
Fornimenti di legature nel Museo diocesano
di Trento. — Nel Museo diocesano di Trento vi sono
Fig. 1—Trento, Museo diocesano
Fornimento di legatura di libro corale
pochi oggetti, ma tutti degnissimi di considerazione
e di studio. Non dirò delle rarità medioevali, di un
cofanetto limosino, di una cassetta alla saracena, delle
miniature, e neppure de’ meravigliosi arazzi fiam-
minghi, pèr trattenermi sopra la singolarità della le-
gatura di libri- corali esposti in una vetrina, ancora
ricchi dei fornimenti cinquecenteschi di bronzo dorato.
Il libro corale B, n. 23, è coperto di pergamena
Fig. 2 — Trento, Museo diocesano
Fornimento di legatura di libro corale
impressa a ferri, protetta agli angoli da otto placchette,
una delle quali presenta entro un tondo la testa del
Redentore coronata di spine (fig. 1); altre cinque sono