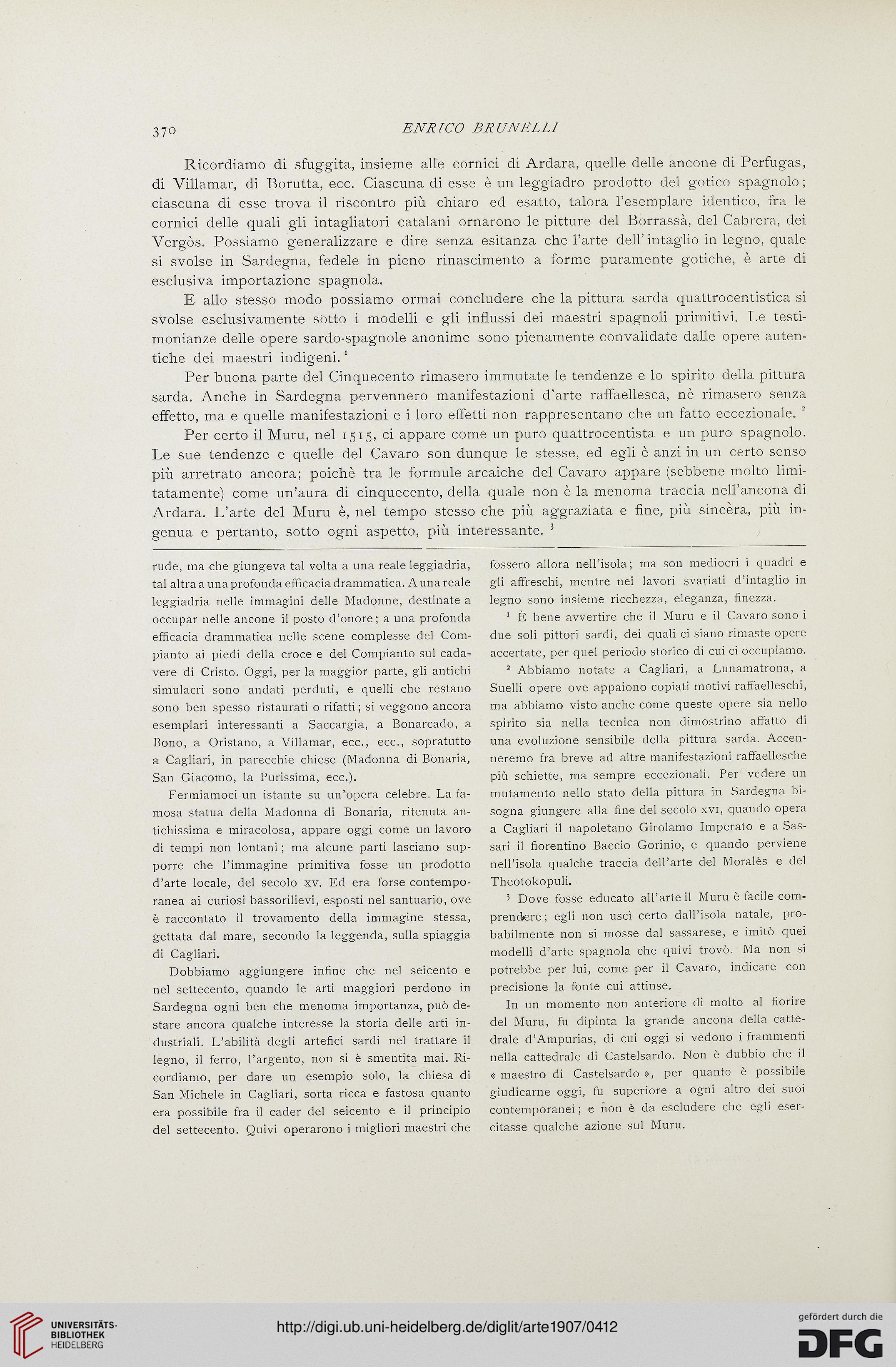370
ENRICO BRUNELLI
Ricordiamo di sfuggita, insieme alle cornici di Ardara, quelle delle ancone di Perfugas,
di Villamar, di Borutta, ecc. Ciascuna di esse è un leggiadro prodotto del gotico spagnolo ;
ciascuna di esse trova il riscontro più chiaro ed esatto, talora l’esemplare identico, fra le
cornici delle quali gli intagliatori catalani ornarono le pitture del Borrassà, del Cabrerà, dei
Vergòs. Possiamo generalizzare e dire senza esitanza che l’arte dell’intaglio in legno, quale
si svolse in Sardegna, fedele in pieno rinascimento a forme puramente g'otiche, è arte di
esclusiva importazione spagnola.
E allo stesso modo possiamo ormai concludere che la pittura sarda quattrocentistica si
svolse esclusivamente sotto i modelli e gli influssi dei maestri spagnoli primitivi. Le testi-
monianze delle opere sardo-spagnole anonime sono pienamente convalidate dalle opere auten-
tiche dei maestri indigeni.1
Per buona parte del Cinquecento rimasero immutate le tendenze e lo spirito della pittura
sarda. Anche in Sardegna pervennero manifestazioni d’arte raffaellesca, nè rimasero senza
effetto, ma e quelle manifestazioni e i loro effetti non rappresentano che un fatto eccezionale.
Per certo il Mura, nel 1515, ci appare come un puro quattrocentista e un puro spagnolo.
Le sue tendenze e quelle del Cavaro son dunque le stesse, ed egli è anzi in un certo senso
più arretrato ancora; poiché tra le formule arcaiche del Cavaro appare (sebbene molto limi-
tatamente) come un’aura di cinquecento, della quale non è la menoma traccia nell’ancona di
Ardara. L’arte del Mura è, nel tempo stesso che più aggraziata e fine, più sincèra, più in-
genua e pertanto, sotto ogni aspetto, più interessante. 3
rude, ma che giungeva tal volta a una reale leggiadria,
tal altra a una profonda efficacia drammatica. A una reale
leggiadria nelle immagini delle Madonne, destinate a
occupar nelle ancone il posto d’onore; a una profonda
efficacia drammatica nelle scene complesse del Com-
pianto ai piedi della croce e del Compianto sul cada-
vere di Cristo. Oggi, per la maggior parte, gli antichi
simulacri sono andati perduti, e quelli che restano
sono ben spesso ristaurati o rifatti ; si veggono ancora
esemplari interessanti a Saccargia, a Bonarcado, a
Bono, a Oristano, a Villamar, ecc., ecc., sopratutto
a Cagliari, in parecchie chiese (Madonna di Bonaria,
San Giacomo, la Purissima, ecc.).
Fermiamoci un istante su un’opera celebre. La fa-
mosa statua della Madonna di Bonaria, ritenuta an-
tichissima e miracolosa, appare oggi come un lavoro
di tempi non lontani ; ma alcune parti lasciano sup-
porre che l’immagine primitiva fosse un prodotto
d’arte locale, del secolo xv. Ed era forse contempo-
ranea ai curiosi bassorilievi, esposti nel santuario, ove
è raccontato il trovamento della immagine stessa,
gettata dal mare, secondo la leggenda, sulla spiaggia
di Cagliari.
Dobbiamo aggiungere infine che nel seicento e
nel settecento, quando le arti maggiori perdono in
Sardegna ogni ben che menoma importanza, può de-
stare ancora qualche interesse la storia delle arti in-
dustriali. L’abilità degli artefici sardi nel trattare il
legno, il ferro, l’argento, non si è smentita mai. Ri-
cordiamo, per dare un esempio solo, la chiesa di
San Michele in Cagliari, sorta ricca e fastosa quanto
era possibile fra il cader del seicento e il principio
del settecento. Quivi operarono i migliori maestri che
fossero allora nell’isola; ma son mediocri i quadri e
gli affreschi, mentre nei lavori svariati d’intaglio in
legno sono insieme ricchezza, eleganza, finezza.
1 È bene avvertire che il Muru e il Cavaro sono i
due soli pittori sardi, dei quali ci siano rimaste opere
accertate, per quel periodo storico di cui ci occupiamo.
2 Abbiamo notate a Cagliari, a Lunamatrona, a
Suelli opere ove appaiono copiati motivi raffaelleschi,
ma abbiamo visto anche come queste opere sia nello
spirito sia nella tecnica non dimostrino affatto di
una evoluzione sensibile della pittura sarda. Accen-
neremo fra breve ad altre manifestazioni raffaellesche
più schiette, ma sempre eccezionali. Per vedere un
mutamento nello stato della pittura in Sardegna bi-
sogna giungere alla fine del secolo xvi, quando opera
a Cagliari il napoletano Girolamo Imperato e a Sas-
sari il fiorentino Baccio Gorinio, e quando perviene
nell’isola qualche traccia dell’arte del Moralès e del
Theotokopuli.
3 Dove fosse educato all’arte il Muru è facile com-
prendere ; egli non uscì certo dall’isola natale, pro-
babilmente non si mosse dal sassarese, e imitò quei
modelli d’arte spagnola che quivi trovò. Ma non si
potrebbe per lui, come per il Cavaro, indicare con
precisione la fonte cui attinse.
In un momento non anteriore di molto al fiorire
del Muru, fu dipinta la grande ancona della catte-
drale d’Anrpurias, di cui oggi si vedono i frammenti
nella cattedrale di Castelsardo. Non è dubbio che il
« maestro di Castelsardo », per quanto è possibile
giudicarne oggi, fu superiore a ogni altro dei suoi
contemporanei; e non è da escludere che egli eser-
citasse qualche azione sul Muru.
ENRICO BRUNELLI
Ricordiamo di sfuggita, insieme alle cornici di Ardara, quelle delle ancone di Perfugas,
di Villamar, di Borutta, ecc. Ciascuna di esse è un leggiadro prodotto del gotico spagnolo ;
ciascuna di esse trova il riscontro più chiaro ed esatto, talora l’esemplare identico, fra le
cornici delle quali gli intagliatori catalani ornarono le pitture del Borrassà, del Cabrerà, dei
Vergòs. Possiamo generalizzare e dire senza esitanza che l’arte dell’intaglio in legno, quale
si svolse in Sardegna, fedele in pieno rinascimento a forme puramente g'otiche, è arte di
esclusiva importazione spagnola.
E allo stesso modo possiamo ormai concludere che la pittura sarda quattrocentistica si
svolse esclusivamente sotto i modelli e gli influssi dei maestri spagnoli primitivi. Le testi-
monianze delle opere sardo-spagnole anonime sono pienamente convalidate dalle opere auten-
tiche dei maestri indigeni.1
Per buona parte del Cinquecento rimasero immutate le tendenze e lo spirito della pittura
sarda. Anche in Sardegna pervennero manifestazioni d’arte raffaellesca, nè rimasero senza
effetto, ma e quelle manifestazioni e i loro effetti non rappresentano che un fatto eccezionale.
Per certo il Mura, nel 1515, ci appare come un puro quattrocentista e un puro spagnolo.
Le sue tendenze e quelle del Cavaro son dunque le stesse, ed egli è anzi in un certo senso
più arretrato ancora; poiché tra le formule arcaiche del Cavaro appare (sebbene molto limi-
tatamente) come un’aura di cinquecento, della quale non è la menoma traccia nell’ancona di
Ardara. L’arte del Mura è, nel tempo stesso che più aggraziata e fine, più sincèra, più in-
genua e pertanto, sotto ogni aspetto, più interessante. 3
rude, ma che giungeva tal volta a una reale leggiadria,
tal altra a una profonda efficacia drammatica. A una reale
leggiadria nelle immagini delle Madonne, destinate a
occupar nelle ancone il posto d’onore; a una profonda
efficacia drammatica nelle scene complesse del Com-
pianto ai piedi della croce e del Compianto sul cada-
vere di Cristo. Oggi, per la maggior parte, gli antichi
simulacri sono andati perduti, e quelli che restano
sono ben spesso ristaurati o rifatti ; si veggono ancora
esemplari interessanti a Saccargia, a Bonarcado, a
Bono, a Oristano, a Villamar, ecc., ecc., sopratutto
a Cagliari, in parecchie chiese (Madonna di Bonaria,
San Giacomo, la Purissima, ecc.).
Fermiamoci un istante su un’opera celebre. La fa-
mosa statua della Madonna di Bonaria, ritenuta an-
tichissima e miracolosa, appare oggi come un lavoro
di tempi non lontani ; ma alcune parti lasciano sup-
porre che l’immagine primitiva fosse un prodotto
d’arte locale, del secolo xv. Ed era forse contempo-
ranea ai curiosi bassorilievi, esposti nel santuario, ove
è raccontato il trovamento della immagine stessa,
gettata dal mare, secondo la leggenda, sulla spiaggia
di Cagliari.
Dobbiamo aggiungere infine che nel seicento e
nel settecento, quando le arti maggiori perdono in
Sardegna ogni ben che menoma importanza, può de-
stare ancora qualche interesse la storia delle arti in-
dustriali. L’abilità degli artefici sardi nel trattare il
legno, il ferro, l’argento, non si è smentita mai. Ri-
cordiamo, per dare un esempio solo, la chiesa di
San Michele in Cagliari, sorta ricca e fastosa quanto
era possibile fra il cader del seicento e il principio
del settecento. Quivi operarono i migliori maestri che
fossero allora nell’isola; ma son mediocri i quadri e
gli affreschi, mentre nei lavori svariati d’intaglio in
legno sono insieme ricchezza, eleganza, finezza.
1 È bene avvertire che il Muru e il Cavaro sono i
due soli pittori sardi, dei quali ci siano rimaste opere
accertate, per quel periodo storico di cui ci occupiamo.
2 Abbiamo notate a Cagliari, a Lunamatrona, a
Suelli opere ove appaiono copiati motivi raffaelleschi,
ma abbiamo visto anche come queste opere sia nello
spirito sia nella tecnica non dimostrino affatto di
una evoluzione sensibile della pittura sarda. Accen-
neremo fra breve ad altre manifestazioni raffaellesche
più schiette, ma sempre eccezionali. Per vedere un
mutamento nello stato della pittura in Sardegna bi-
sogna giungere alla fine del secolo xvi, quando opera
a Cagliari il napoletano Girolamo Imperato e a Sas-
sari il fiorentino Baccio Gorinio, e quando perviene
nell’isola qualche traccia dell’arte del Moralès e del
Theotokopuli.
3 Dove fosse educato all’arte il Muru è facile com-
prendere ; egli non uscì certo dall’isola natale, pro-
babilmente non si mosse dal sassarese, e imitò quei
modelli d’arte spagnola che quivi trovò. Ma non si
potrebbe per lui, come per il Cavaro, indicare con
precisione la fonte cui attinse.
In un momento non anteriore di molto al fiorire
del Muru, fu dipinta la grande ancona della catte-
drale d’Anrpurias, di cui oggi si vedono i frammenti
nella cattedrale di Castelsardo. Non è dubbio che il
« maestro di Castelsardo », per quanto è possibile
giudicarne oggi, fu superiore a ogni altro dei suoi
contemporanei; e non è da escludere che egli eser-
citasse qualche azione sul Muru.