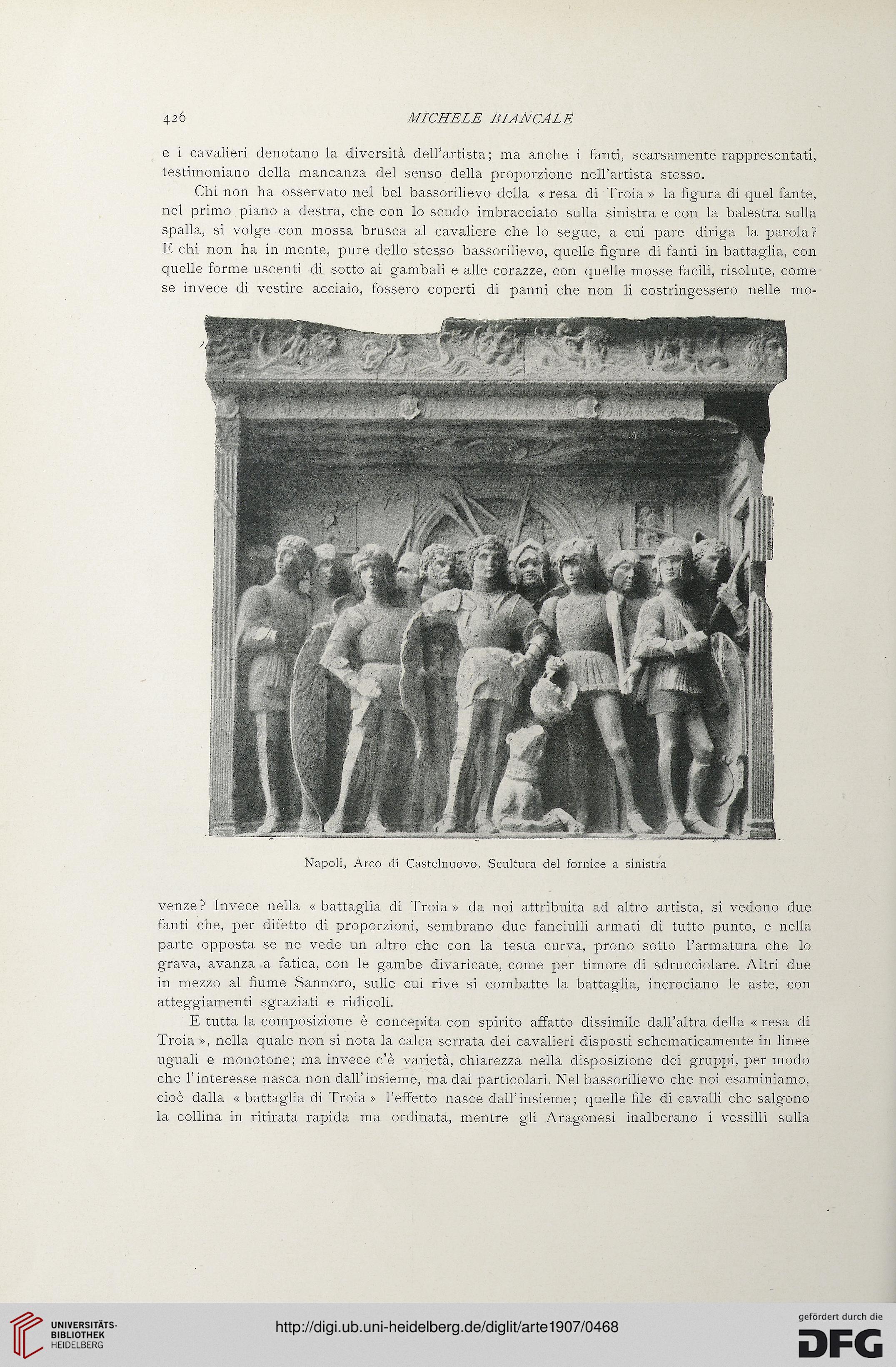4 2Ó
MICHELE BIANCALE
e i cavalieri denotano la diversità dell’artista; ma anche i fanti, scarsamente rappresentati,
testimoniano della mancanza del senso della proporzione nell’artista stesso.
Chi non ha osservato nel bel bassorilievo della « resa di Troia » la figura di quel fante,
nel primo piano a destra, che con lo scudo imbracciato sulla sinistra e con la balestra sulla
spalla, si volge con mossa brusca al cavaliere che lo segue, a cui pare diriga la parola?
E chi non ha in mente, pure dello stesso bassorilievo, quelle figure di fanti in battaglia, con
quelle forme uscenti di sotto ai gambali e alle corazze, con quelle mosse facili, risolute, come
se invece di vestire acciaio, fossero coperti di panni che non li costringessero nelle mo-
Napoli, Arco di Castelnuovo. Scultura del fornice a sinistra
venze? Invece nella «battaglia di Troia» da noi attribuita ad altro artista, si vedono due
fanti che, per difetto di proporzioni, sembrano due fanciulli armati di tutto punto, e nella
parte opposta se ne vede un altro che con la testa curva, prono sotto l’armatura che lo
grava, avanza a fatica, con le gambe divaricate, come per timore di sdrucciolare. Altri due
in mezzo al fiume Sannoro, sulle cui rive si combatte la battaglia, incrociano le aste, con
atteggiamenti sgraziati e ridicoli.
E tutta la composizione è concepita con spirito affatto dissimile dall’altra della « resa di
Troia », nella quale non si nota la calca serrata dei cavalieri disposti schematicamente in linee
uguali e monotone; ma invece c’è varietà, chiarezza nella disposizione dei gruppi, per modo
che l’interesse nasca non dall’insieme, ma dai particolari. Nel bassorilievo che noi esaminiamo,
cioè dalla «battaglia di Troia» l’effetto nasce dall’insieme; quelle file di cavalli che salgono
la collina in ritirata rapida ma ordinata, mentre gli Aragonesi inalberano i vessilli sulla
MICHELE BIANCALE
e i cavalieri denotano la diversità dell’artista; ma anche i fanti, scarsamente rappresentati,
testimoniano della mancanza del senso della proporzione nell’artista stesso.
Chi non ha osservato nel bel bassorilievo della « resa di Troia » la figura di quel fante,
nel primo piano a destra, che con lo scudo imbracciato sulla sinistra e con la balestra sulla
spalla, si volge con mossa brusca al cavaliere che lo segue, a cui pare diriga la parola?
E chi non ha in mente, pure dello stesso bassorilievo, quelle figure di fanti in battaglia, con
quelle forme uscenti di sotto ai gambali e alle corazze, con quelle mosse facili, risolute, come
se invece di vestire acciaio, fossero coperti di panni che non li costringessero nelle mo-
Napoli, Arco di Castelnuovo. Scultura del fornice a sinistra
venze? Invece nella «battaglia di Troia» da noi attribuita ad altro artista, si vedono due
fanti che, per difetto di proporzioni, sembrano due fanciulli armati di tutto punto, e nella
parte opposta se ne vede un altro che con la testa curva, prono sotto l’armatura che lo
grava, avanza a fatica, con le gambe divaricate, come per timore di sdrucciolare. Altri due
in mezzo al fiume Sannoro, sulle cui rive si combatte la battaglia, incrociano le aste, con
atteggiamenti sgraziati e ridicoli.
E tutta la composizione è concepita con spirito affatto dissimile dall’altra della « resa di
Troia », nella quale non si nota la calca serrata dei cavalieri disposti schematicamente in linee
uguali e monotone; ma invece c’è varietà, chiarezza nella disposizione dei gruppi, per modo
che l’interesse nasca non dall’insieme, ma dai particolari. Nel bassorilievo che noi esaminiamo,
cioè dalla «battaglia di Troia» l’effetto nasce dall’insieme; quelle file di cavalli che salgono
la collina in ritirata rapida ma ordinata, mentre gli Aragonesi inalberano i vessilli sulla