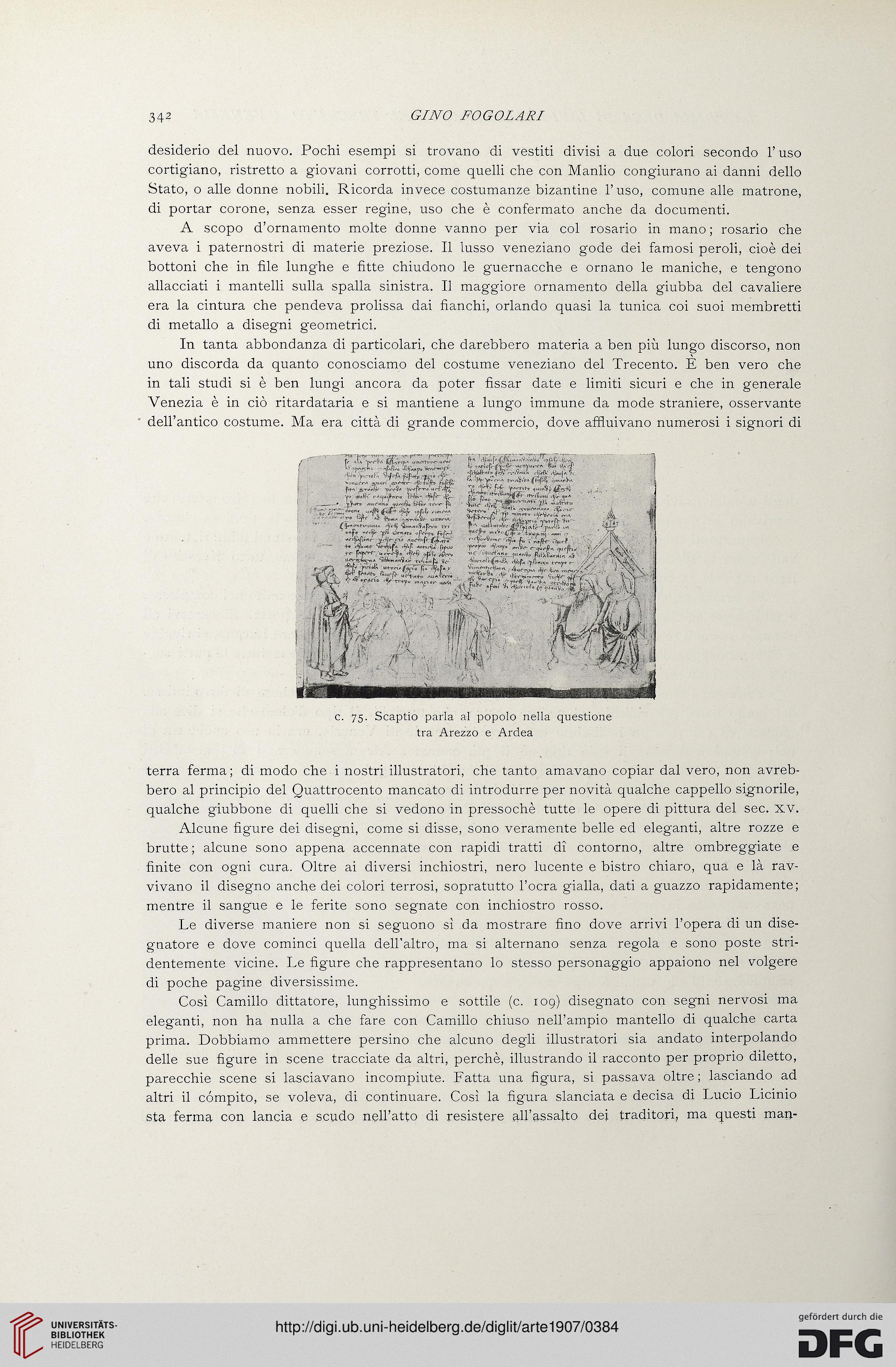342
GINO FO GOL ARI
desiderio del nuovo. Pochi esempi si trovano di vestiti divisi a due colori secondo l’uso
cortigiano, ristretto a giovani corrotti, come quelli che con Manlio congiurano ai danni dello
Stato, o alle donne nobili. Ricorda invece costumanze bizantine l’uso, comune alle matrone,
di portar corone, senza esser regine, uso che è confermato anche da documenti.
A scopo d’ornamento molte donne vanno per via col rosario in mano ; rosario che
aveva i paternostri di materie preziose. Il lusso veneziano gode dei famosi peroli, cioè dei
bottoni che in file lunghe e fitte chiudono le guernacche e ornano le maniche, e tengono
allacciati i mantelli sulla spalla sinistra. Il maggiore ornamento della giubba del cavaliere
era la cintura che pendeva prolissa dai fianchi, orlando quasi la tunica coi suoi membretti
di metallo a disegni geometrici.
In tanta abbondanza di particolari, che darebbero materia a ben più lungo discorso, non
uno discorda da quanto conosciamo del costume veneziano del Trecento. È ben vero che
in tali studi si è ben lungi ancora da poter fissar date e limiti sicuri e che in generale
Venezia è in ciò ritardataria e si mantiene a lungo immune da mode straniere, osservante
dell’antico costume. Ma era città di grande commercio, dove affluivano numerosi i signori di
c. 75. Scaptio parla al popolo nella questione
tra Arezzo e Ardea
terra ferma ; di modo che i nostri illustratori, che tanto amavano copiar dal vero, non avreb-
bero al principio del Quattrocento mancato di introdurre per novità qualche cappello signorile,
qualche giubbone di quelli che si vedono in pressoché tutte le opere di pittura del sec. XV.
Alcune figure dei disegni, come si disse, sono veramente belle ed eleganti, altre rozze e
brutte ; alcune sono appena accennate con rapidi tratti di contorno, altre ombreggiate e
finite con ogni cura. Oltre ai diversi inchiostri, nero lucente e bistro chiaro, qua e là rav-
vivano il disegno anche dei colori terrosi, sopratutto l’ocra gialla, dati a guazzo rapidamente;
mentre il sangue e le ferite sono segnate con inchiostro rosso.
Le diverse maniere non si seguono sì da mostrare fino dove arrivi l’opera di un dise-
gnatore e dove cominci quella dell’altro, ma si alternano senza regola e sono poste stri-
dentemente vicine. Le figure che rappresentano lo stesso personaggio appaiono nel volgere
di poche pagine diversissime.
Così Camillo dittatore, lunghissimo e sottile (c. 109) disegnato con segni nervosi ma
eleganti, non ha nulla a che fare con Camillo chiuso nell’ampio mantello di qualche carta
prima. Dobbiamo ammettere persino che alcuno degli illustratori sia andato interpolando
delle sue figure in scene tracciate da altri, perchè, illustrando il racconto per proprio diletto,
parecchie scene si lasciavano incompiute. Fatta una figura, si passava oltre; lasciando ad
altri il compito, se voleva, di continuare. Così la figura slanciata e decisa di Lucio Licinio
sta ferma con lancia e scudo nell’atto di resistere all’assalto dei traditori, ma questi man-
GINO FO GOL ARI
desiderio del nuovo. Pochi esempi si trovano di vestiti divisi a due colori secondo l’uso
cortigiano, ristretto a giovani corrotti, come quelli che con Manlio congiurano ai danni dello
Stato, o alle donne nobili. Ricorda invece costumanze bizantine l’uso, comune alle matrone,
di portar corone, senza esser regine, uso che è confermato anche da documenti.
A scopo d’ornamento molte donne vanno per via col rosario in mano ; rosario che
aveva i paternostri di materie preziose. Il lusso veneziano gode dei famosi peroli, cioè dei
bottoni che in file lunghe e fitte chiudono le guernacche e ornano le maniche, e tengono
allacciati i mantelli sulla spalla sinistra. Il maggiore ornamento della giubba del cavaliere
era la cintura che pendeva prolissa dai fianchi, orlando quasi la tunica coi suoi membretti
di metallo a disegni geometrici.
In tanta abbondanza di particolari, che darebbero materia a ben più lungo discorso, non
uno discorda da quanto conosciamo del costume veneziano del Trecento. È ben vero che
in tali studi si è ben lungi ancora da poter fissar date e limiti sicuri e che in generale
Venezia è in ciò ritardataria e si mantiene a lungo immune da mode straniere, osservante
dell’antico costume. Ma era città di grande commercio, dove affluivano numerosi i signori di
c. 75. Scaptio parla al popolo nella questione
tra Arezzo e Ardea
terra ferma ; di modo che i nostri illustratori, che tanto amavano copiar dal vero, non avreb-
bero al principio del Quattrocento mancato di introdurre per novità qualche cappello signorile,
qualche giubbone di quelli che si vedono in pressoché tutte le opere di pittura del sec. XV.
Alcune figure dei disegni, come si disse, sono veramente belle ed eleganti, altre rozze e
brutte ; alcune sono appena accennate con rapidi tratti di contorno, altre ombreggiate e
finite con ogni cura. Oltre ai diversi inchiostri, nero lucente e bistro chiaro, qua e là rav-
vivano il disegno anche dei colori terrosi, sopratutto l’ocra gialla, dati a guazzo rapidamente;
mentre il sangue e le ferite sono segnate con inchiostro rosso.
Le diverse maniere non si seguono sì da mostrare fino dove arrivi l’opera di un dise-
gnatore e dove cominci quella dell’altro, ma si alternano senza regola e sono poste stri-
dentemente vicine. Le figure che rappresentano lo stesso personaggio appaiono nel volgere
di poche pagine diversissime.
Così Camillo dittatore, lunghissimo e sottile (c. 109) disegnato con segni nervosi ma
eleganti, non ha nulla a che fare con Camillo chiuso nell’ampio mantello di qualche carta
prima. Dobbiamo ammettere persino che alcuno degli illustratori sia andato interpolando
delle sue figure in scene tracciate da altri, perchè, illustrando il racconto per proprio diletto,
parecchie scene si lasciavano incompiute. Fatta una figura, si passava oltre; lasciando ad
altri il compito, se voleva, di continuare. Così la figura slanciata e decisa di Lucio Licinio
sta ferma con lancia e scudo nell’atto di resistere all’assalto dei traditori, ma questi man-