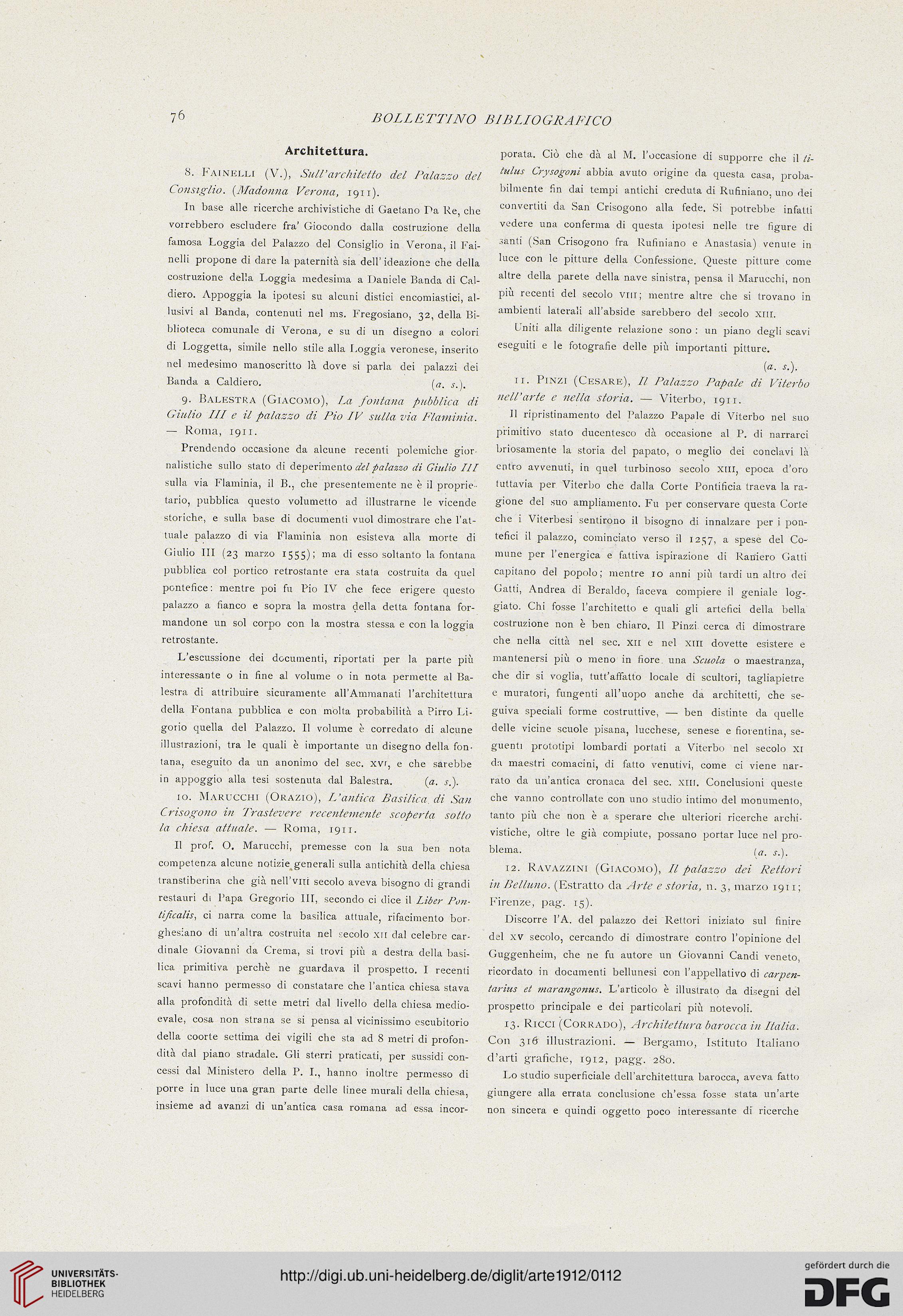76
BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO
Architettura.
8. Fai Nelli (V.), Sull’architetto det Palazzo del
Consiglio. (.Madonna Verona, 1911).
In base alle ricerche archivistiche di Gaetano Da Re, che
vorrebbero escludere fra’ Giocondo dalla costruzione della
famosa Loggia del Palazzo del Consiglio in Verona, il Fai-
nelli propone di dare la paternità sia dell’ ideazione che della
costruzione della Loggia medesima a Daniele Banda di Cal-
diero. Appoggia la ipotesi su alcuni distici encomiastici, al-
lusivi al Banda, contenuti nel ms. Fregosiano, 32, della Bi-
blioteca comunale di Verona, e su di un disegno a colori
di Loggetta, simile nello stile alla Loggia veronese, inserito
nel medesimo manoscritto là dove si parla dei palazzi dei
Banda a Caldiero. (a. s.).
9. Balestra (Giacomo), La fontana pubblica di
Giulio III e il palazzo di Pio IV sulla via Flaminia.
— Roma, 1911.
Prendendo occasione da alcune recenti polemiche gior-
nalistiche sullo stato di deperimento del palazzo di Giulio III
sulla via Flaminia, il B., che presentemente ne è il proprie -
tario, pubblica questo volumetto ad illustrarne le vicende
storiche, e sulla base di documenti vuol dimostrare che l’at-
tuale palazzo di via Flaminia non esisteva alla morte di
Giulio III (23 marzo 1555); ma di esso soltanto la fontana
pubblica col portico retrostante era stata costruita da quel
pontefice: mentre poi fu Pio IV che fece erigere questo
palazzo a fianco e sopra la mostra della detta fontana for-
mandone un sol corpo con la mostra stessa e con la loggia
retrostante.
L’escussione dei documenti, riportati per la parte più
interessante o in fine al volume o in nota permette al Ba-
lestra di attribuire sicuramente all’Ammanati l’architettura
della Fontana pubblica e con molta probabilità a Pirro Li-
gorio quella del Palazzo. Il volume è corredato di alcune
illustrazioni, tra le quali è importante un disegno della fon-
tana, eseguito da un anonimo del sec. xvr, e che sarebbe
in appoggio alla tesi sostenuta dal Balestra. (a. j.).
10. Marucchi (Orazio), L'antica Basilica. di San
Crisagono in Trastevere recentemente scoperta sotto
la chiesa attuale. — Roma, 1911.
Il prof. O. Marucchi, premesse con la sua ben nota
competenza alcune notizie generali sulla antichità della chiesa
transtiberina che già nell’viti secolo aveva bisogno di grandi
restauri di Papa Gregorio III, secondo ci dice il Liber Po?z-
tificalis, ci narra come la basilica attuale, rifacimento bor-
ghesiano di un’altra costruita nel secolo xri dal celebre car-
dinale Giovanni da Crema, si trovi più a destra della basi-
lica primitiva perchè ne guardava il prospetto. I recenti
scavi hanno permesso di constatare che l’antica chiesa stava
alla profondità di sette metri dal livello della chiesa medio-
evale, cosa non strana se si pensa al vicinissimo escubitorio
della coorte settima dei vigili che sta ad 8 metri di profon-
dità dal piano stradale. Gli sterri praticati, per sussidi con-
cessi dal Ministero della P. I., hanno inoltre permesso di
porre in luce una gran parte delle linee murali della chiesa,
insieme ad avanzi di un’antica casa romana ad essa incor-
porata. Ciò che dà al M. l’occasione di supporre che il ti-
tulus Crysogoni abbia avuto origine da questa casa, proba-
bilmente fin dai tempi antichi creduta di Rufiniano, uno dei
convertiti da San Crisogono alla fede. Si potrebbe infatti
vedere una conferma di questa ipotesi nelle tre figure di
santi (San Crisogono fra Rufiniano e Anastasia) venute in
luce con le pitture della Confessione. Queste pitture come
altre della parete della nave sinistra, pensa il Marucchi, non
più recenti del secolo vili; mentre altre che si trovano in
ambienti laterali all’abside sarebbero del secolo XIII.
Uniti alla diligente relazione sono : un piano degli scavi
eseguiti e le fotografie delle più importanti pitture.
(a. s.).
11. Pinzi (Cesare), Il Palazzo Papale di Viterbo
nell'arte e nella storia. — Viterbo, 1911.
Il ripristinamento del Palazzo Papale di Viterbo nel suo
primitivo stato ducentesco dà occasione al P. di narrarci
briosamente la storia del papato, o meglio dei conclavi là
entro avvenuti, in quel turbinoso secolo XIII, epoca d’oro
tuttavia per Viterbo che dalla Corte Pontificia traeva la ra-
gione del suo ampliamento. Fu per conservare questa Corte
che i Viterbesi sentirono il bisogno di innalzare per i pon-
tefici il palazzo, cominciato verso il 1257, a spese del Co-
mune per l’energica e fattiva ispirazione di Raniero Gatti
capitano del popolo; mentre io anni più tardi un altro dei
Gatti, Andrea di Beraldo, faceva compiere il geniale log-
giato. Chi fosse l’architetto e quali gli artefici della bella
costruzione non è ben chiaro. Il Pinzi, cerca di dimostrare
che nella città nel sec. xii e nel xm dovette esistere e
mantenersi più o meno in fiore una Scuola o maestranza,
che dir si voglia, tutt’affatto locale di scultori, tagliapietre
e muratori, fungenti all’uopo anche da architetti, che se-
guiva speciali forme costruttive, — ben distinte da quelle
delle vicine scuole pisana, lucchese, senese e fiorentina, se-
guenti prototipi lombardi portati a Viterbo nel secolo XI
da maestri comacini, di fatto venutivi, come ci viene nar-
rato da un’antica cronaca del sec. xm. Conclusioni queste
che vanno controllate con uno studio intimo del monumento,
tanto più che non è a sperare che ulteriori ricerche archi-
vistiche, oltre le già compiute, possano portar luce nel pro-
blema. (a. s.),
12. Ravazzini (Giacomo), Il palazzo dei Rettori
in Belluno. (Estratto da Arte e storia, n. 3, marzo 1911;
Firenze, pag. 15).
Discorre l’A. del palazzo dei Rettori iniziato sul finire
del xv secolo, cercando di dimostrare contro l’opinione del
Guggenheim, che ne fu autore un Giovanni Candi veneto,
ricordato in documenti bellunesi con l’appellativo di carpen-
tarius et marangonus. L’articolo è illustrato da disegni del
prospetto principale e dei particolari più notevoli.
13. Ricci (Corrado), Architettura barocca in Italia.
Con 316 illustrazioni. — Bergamo, Istituto Italiano
d’arti grafiche, 1912, pagg. 280.
Lo studio superficiale dell’architettura barocca, aveva fatto
giungere alla errata conclusione ch’essa fosse stata un’arte
non sincera e quindi oggetto poco interessante di ricerche
BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO
Architettura.
8. Fai Nelli (V.), Sull’architetto det Palazzo del
Consiglio. (.Madonna Verona, 1911).
In base alle ricerche archivistiche di Gaetano Da Re, che
vorrebbero escludere fra’ Giocondo dalla costruzione della
famosa Loggia del Palazzo del Consiglio in Verona, il Fai-
nelli propone di dare la paternità sia dell’ ideazione che della
costruzione della Loggia medesima a Daniele Banda di Cal-
diero. Appoggia la ipotesi su alcuni distici encomiastici, al-
lusivi al Banda, contenuti nel ms. Fregosiano, 32, della Bi-
blioteca comunale di Verona, e su di un disegno a colori
di Loggetta, simile nello stile alla Loggia veronese, inserito
nel medesimo manoscritto là dove si parla dei palazzi dei
Banda a Caldiero. (a. s.).
9. Balestra (Giacomo), La fontana pubblica di
Giulio III e il palazzo di Pio IV sulla via Flaminia.
— Roma, 1911.
Prendendo occasione da alcune recenti polemiche gior-
nalistiche sullo stato di deperimento del palazzo di Giulio III
sulla via Flaminia, il B., che presentemente ne è il proprie -
tario, pubblica questo volumetto ad illustrarne le vicende
storiche, e sulla base di documenti vuol dimostrare che l’at-
tuale palazzo di via Flaminia non esisteva alla morte di
Giulio III (23 marzo 1555); ma di esso soltanto la fontana
pubblica col portico retrostante era stata costruita da quel
pontefice: mentre poi fu Pio IV che fece erigere questo
palazzo a fianco e sopra la mostra della detta fontana for-
mandone un sol corpo con la mostra stessa e con la loggia
retrostante.
L’escussione dei documenti, riportati per la parte più
interessante o in fine al volume o in nota permette al Ba-
lestra di attribuire sicuramente all’Ammanati l’architettura
della Fontana pubblica e con molta probabilità a Pirro Li-
gorio quella del Palazzo. Il volume è corredato di alcune
illustrazioni, tra le quali è importante un disegno della fon-
tana, eseguito da un anonimo del sec. xvr, e che sarebbe
in appoggio alla tesi sostenuta dal Balestra. (a. j.).
10. Marucchi (Orazio), L'antica Basilica. di San
Crisagono in Trastevere recentemente scoperta sotto
la chiesa attuale. — Roma, 1911.
Il prof. O. Marucchi, premesse con la sua ben nota
competenza alcune notizie generali sulla antichità della chiesa
transtiberina che già nell’viti secolo aveva bisogno di grandi
restauri di Papa Gregorio III, secondo ci dice il Liber Po?z-
tificalis, ci narra come la basilica attuale, rifacimento bor-
ghesiano di un’altra costruita nel secolo xri dal celebre car-
dinale Giovanni da Crema, si trovi più a destra della basi-
lica primitiva perchè ne guardava il prospetto. I recenti
scavi hanno permesso di constatare che l’antica chiesa stava
alla profondità di sette metri dal livello della chiesa medio-
evale, cosa non strana se si pensa al vicinissimo escubitorio
della coorte settima dei vigili che sta ad 8 metri di profon-
dità dal piano stradale. Gli sterri praticati, per sussidi con-
cessi dal Ministero della P. I., hanno inoltre permesso di
porre in luce una gran parte delle linee murali della chiesa,
insieme ad avanzi di un’antica casa romana ad essa incor-
porata. Ciò che dà al M. l’occasione di supporre che il ti-
tulus Crysogoni abbia avuto origine da questa casa, proba-
bilmente fin dai tempi antichi creduta di Rufiniano, uno dei
convertiti da San Crisogono alla fede. Si potrebbe infatti
vedere una conferma di questa ipotesi nelle tre figure di
santi (San Crisogono fra Rufiniano e Anastasia) venute in
luce con le pitture della Confessione. Queste pitture come
altre della parete della nave sinistra, pensa il Marucchi, non
più recenti del secolo vili; mentre altre che si trovano in
ambienti laterali all’abside sarebbero del secolo XIII.
Uniti alla diligente relazione sono : un piano degli scavi
eseguiti e le fotografie delle più importanti pitture.
(a. s.).
11. Pinzi (Cesare), Il Palazzo Papale di Viterbo
nell'arte e nella storia. — Viterbo, 1911.
Il ripristinamento del Palazzo Papale di Viterbo nel suo
primitivo stato ducentesco dà occasione al P. di narrarci
briosamente la storia del papato, o meglio dei conclavi là
entro avvenuti, in quel turbinoso secolo XIII, epoca d’oro
tuttavia per Viterbo che dalla Corte Pontificia traeva la ra-
gione del suo ampliamento. Fu per conservare questa Corte
che i Viterbesi sentirono il bisogno di innalzare per i pon-
tefici il palazzo, cominciato verso il 1257, a spese del Co-
mune per l’energica e fattiva ispirazione di Raniero Gatti
capitano del popolo; mentre io anni più tardi un altro dei
Gatti, Andrea di Beraldo, faceva compiere il geniale log-
giato. Chi fosse l’architetto e quali gli artefici della bella
costruzione non è ben chiaro. Il Pinzi, cerca di dimostrare
che nella città nel sec. xii e nel xm dovette esistere e
mantenersi più o meno in fiore una Scuola o maestranza,
che dir si voglia, tutt’affatto locale di scultori, tagliapietre
e muratori, fungenti all’uopo anche da architetti, che se-
guiva speciali forme costruttive, — ben distinte da quelle
delle vicine scuole pisana, lucchese, senese e fiorentina, se-
guenti prototipi lombardi portati a Viterbo nel secolo XI
da maestri comacini, di fatto venutivi, come ci viene nar-
rato da un’antica cronaca del sec. xm. Conclusioni queste
che vanno controllate con uno studio intimo del monumento,
tanto più che non è a sperare che ulteriori ricerche archi-
vistiche, oltre le già compiute, possano portar luce nel pro-
blema. (a. s.),
12. Ravazzini (Giacomo), Il palazzo dei Rettori
in Belluno. (Estratto da Arte e storia, n. 3, marzo 1911;
Firenze, pag. 15).
Discorre l’A. del palazzo dei Rettori iniziato sul finire
del xv secolo, cercando di dimostrare contro l’opinione del
Guggenheim, che ne fu autore un Giovanni Candi veneto,
ricordato in documenti bellunesi con l’appellativo di carpen-
tarius et marangonus. L’articolo è illustrato da disegni del
prospetto principale e dei particolari più notevoli.
13. Ricci (Corrado), Architettura barocca in Italia.
Con 316 illustrazioni. — Bergamo, Istituto Italiano
d’arti grafiche, 1912, pagg. 280.
Lo studio superficiale dell’architettura barocca, aveva fatto
giungere alla errata conclusione ch’essa fosse stata un’arte
non sincera e quindi oggetto poco interessante di ricerche