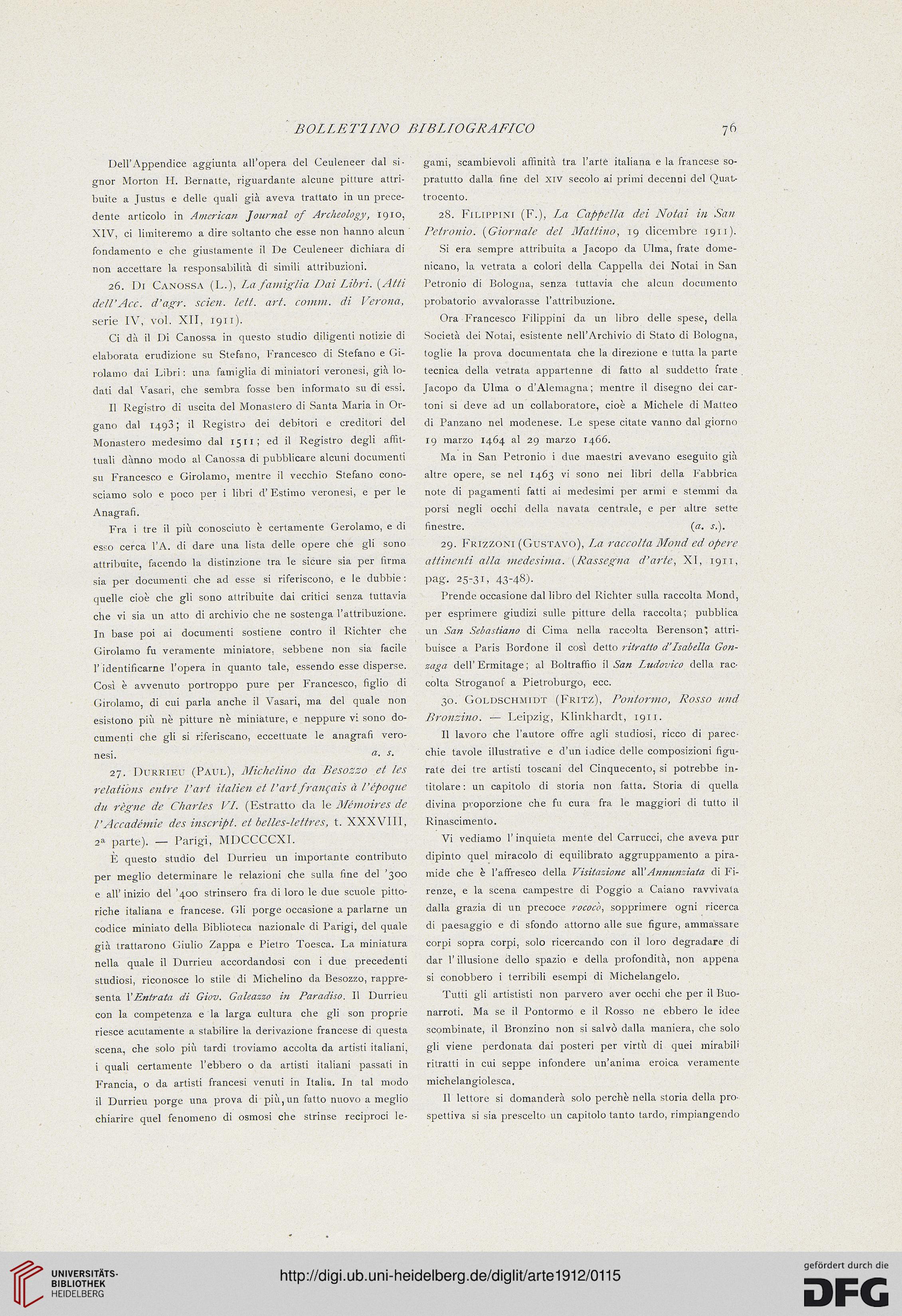BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO
76
Dell’Appendice aggiunta all’opera del Ceuleneer dal si-
gnor Morton H. Bernatte, riguardante alcune pitture attri-
buite a Justus e delle quali già aveva trattato in un prece-
dente articolo in American Journal of Archeology, 1910,
XIV, ci limiteremo a dire soltanto che esse non hanno alcun
fondamento e che giustamente il De Ceuleneer dichiara di
non accettare la responsabilità di simili attribuzioni.
26. Di Canossa (L.), La famiglia Dai Libri. (Atti
dell’Are. d’agr. scien. lett. art. comm. di Verona,
serie IV, voi. XII, 1911).
Ci dà il Di Canossa in questo studio diligenti notizie di
elaborata erudizione su Stefano, Francesco di Stefano e Gi-
rolamo dai Libri : una famiglia di miniatori veronesi, già lo-
dati dal Vasari, che sembra fosse ben informato su di essi.
Il Registro di uscita del Monastero di Santa Maria in Or-
gano dal 1493; il Registro dei debitori e creditori del
Monastero medesimo dal 1511 ; ed il Registro degli affit-
tuali dànno modo al Canossa di pubblicare alcuni documenti
su Francesco e Girolamo, mentre il vecchio Stefano cono-
sciamo solo e poco per i libri d’ Estimo veronesi, e per le
Anagrafi.
Fra i tre il più conosciuto è certamente Gerolamo, e di
esso cerca l’A. di dare una lista delle opere che gli sono
attribuite, facendo la distinzione tra le sicure sia per firma
sia per documenti che ad esse si riferiscono, e le dubbie :
quelle cioè che gli sono attribuite dai critici senza tuttavia
che vi sia un atto di archivio che ne sostenga l’attribuzione.
In base poi ai documenti sostiene contro il Richter che
Girolamo fu veramente miniatore, sebbene non sia facile
l’identificarne l’opera in quanto tale, essendo esse disperse.
Così è avvenuto portroppo pure per Francesco, figlio di
Girolamo, di cui parla anche il Vasari, ma del quale non
esistono più nè pitture nè miniature, e neppure vi sono do-
cumenti che gli si riferiscano, eccettuate le anagrafi vero-
nesi. J.
27. Durrieu (Paul), Michelino da Besozzo et les
relatiòns entre l’art italien et Vart frangais à l’epoque
dii règne de Charles VI. (Estratto da le Mémoires de
VAccadèmie des inscript, et belles-lettres, t. XXXVIII,
2a parte). — Parigi, MDCCCCXl.
È questo studio del Durrieu un importante contributo
per meglio determinare le relazioni che sulla fine del '300
e all’ inizio del '400 strinsero fra di loro le due scuole pitto-
riche italiana e francese. Gli porge occasione a parlarne un
codice miniato della Biblioteca nazionale di Parigi, del quale
già trattarono Giulio Zappa e Pietro Toesca. La miniatura
nella quale il Durrieu accordandosi con i due precedenti
studiosi, riconosce lo stile di Michelino da Besozzo, rappre-
senta l’Entrata di Giov. Galeazzo in Paradiso. Il Durrieu
con la competenza e la larga cultura che gli son proprie
riesce acutamente a stabilire la derivazione francese di questa
scena, che solo più tardi troviamo accolta da artisti italiani,
i quali certamente l’ebbero o da artisti italiani passati in
Francia, o da artisti francesi venuti in Italia. In tal modo
il Durrieu porge una prova di più,un fatto nuovo a meglio
chiarire quel fenomeno di osmosi che strinse reciproci le-
gami, scambievoli affinità tra l’arté italiana e la francese so-
pratutto dalla fine del xiv secolo ai primi decenni del Quat-
trocento.
28. Filippini (F.), La Cappella dei Notai in San
Petronio. (Giornale del Mattino, 19 dicembre t911 ).
Si era sempre attribuita a Jacopo da Ulma, frate dome-
nicano, la vetrata a colori della Cappella dei Notai in San
Petronio di Bologna, senza tuttavia che alcun documento
probatorio avvalorasse l’attribuzione.
Ora Francesco Filippini da un libro delle spese, della
Società dei Notai, esistente nell’Archivio di Stato di Bologna,
toglie la prova documentata che la direzione e tutta la parte
tecnica della vetrata appartenne di fatto al suddetto frate
Jacopo da Ulma o d’Alemagna; mentre il disegno dei car-
toni si deve ad un collaboratore, cioè a Michele di Matteo
di Panzano nel modenese. Le spese citate vanno dal giorno
19 marzo 1464 al 29 marzo 1466.
Ma in San Petronio i due maestri avevano eseguito già
altre opere, se nel 1463 vi sono nei libri della Fabbrica
note di pagamenti fatti ai medesimi per armi e stemmi da
porsi negli occhi della navata centrale, e per altre sette
finestre. (a. s.).
29. Frizzoni (Gustavo), La raccolta Mond ed opere
attinenti alla medesima. (Rassegna d’arte, XI, 1911,
pag. 25-31, 43-48).
Prende occasione dal libro del Richter sulla raccolta Mond,
per esprimere giudizi sulle pitture della raccolta; pubblica
un San Sebastiano di Cima nella raccolta Berenson* attri-
buisce a Paris Bordone il così detto ritratto d’isabella Gon-
zaga dell’ Ermitage ; al Boltraffio il San Ludovico della rac-
colta Stroganof a Pietroburgo, ecc.
30. Goldschmidt (Fritz), Pontormo, Rosso und
Bronzino. — Leipzig, Klinkhardt, 1911.
Il lavoro che l’autore offre agli studiosi, ricco di parec-
chie tavole illustratile e d’un indice delle composizioni figu-
rate dei tre artisti toscani del Cinquecento, si potrebbe in-
titolare : un capitolo di storia non fatta. Storia di quella
divina proporzione che fu cura fra le maggiori di tutto il
Rinascimento.
Vi vediamo l’inquieta mente del Carrucci, che aveva pur
dipinto quel miracolo di equilibrato aggruppamento a pira-
mide che è l’affresco della Visitazione all’Annunziata di Fi-
renze, e la scena campestre di Poggio a Calano ravvivata
dalla grazia di un precoce rococò, sopprimere ogni ricerca
di paesaggio e di sfondo attorno alle sue figure, ammassare
corpi sopra corpi, solo ricercando con il loro degradare di
dar l’illusione dello spazio e della profondità, non appena
si conobbero i terribili esempi di Michelangelo.
Tutti gli artististi non parvero aver occhi che per il Buo-
narroti. Ma se il Pontormo e il Rosso ne ebbero le idee
scombinate, il Bronzino non si salvò dalla maniera, che solo
gli viene perdonata dai posteri per virtù di quei mirabili
ritratti in cui seppe infondere un’anima eroica veramente
michelangiolesca.
Il lettore si domanderà solo perchè nella storia della pro-
spettiva si sia prescelto un capitolo tanto tardo, rimpiangendo
76
Dell’Appendice aggiunta all’opera del Ceuleneer dal si-
gnor Morton H. Bernatte, riguardante alcune pitture attri-
buite a Justus e delle quali già aveva trattato in un prece-
dente articolo in American Journal of Archeology, 1910,
XIV, ci limiteremo a dire soltanto che esse non hanno alcun
fondamento e che giustamente il De Ceuleneer dichiara di
non accettare la responsabilità di simili attribuzioni.
26. Di Canossa (L.), La famiglia Dai Libri. (Atti
dell’Are. d’agr. scien. lett. art. comm. di Verona,
serie IV, voi. XII, 1911).
Ci dà il Di Canossa in questo studio diligenti notizie di
elaborata erudizione su Stefano, Francesco di Stefano e Gi-
rolamo dai Libri : una famiglia di miniatori veronesi, già lo-
dati dal Vasari, che sembra fosse ben informato su di essi.
Il Registro di uscita del Monastero di Santa Maria in Or-
gano dal 1493; il Registro dei debitori e creditori del
Monastero medesimo dal 1511 ; ed il Registro degli affit-
tuali dànno modo al Canossa di pubblicare alcuni documenti
su Francesco e Girolamo, mentre il vecchio Stefano cono-
sciamo solo e poco per i libri d’ Estimo veronesi, e per le
Anagrafi.
Fra i tre il più conosciuto è certamente Gerolamo, e di
esso cerca l’A. di dare una lista delle opere che gli sono
attribuite, facendo la distinzione tra le sicure sia per firma
sia per documenti che ad esse si riferiscono, e le dubbie :
quelle cioè che gli sono attribuite dai critici senza tuttavia
che vi sia un atto di archivio che ne sostenga l’attribuzione.
In base poi ai documenti sostiene contro il Richter che
Girolamo fu veramente miniatore, sebbene non sia facile
l’identificarne l’opera in quanto tale, essendo esse disperse.
Così è avvenuto portroppo pure per Francesco, figlio di
Girolamo, di cui parla anche il Vasari, ma del quale non
esistono più nè pitture nè miniature, e neppure vi sono do-
cumenti che gli si riferiscano, eccettuate le anagrafi vero-
nesi. J.
27. Durrieu (Paul), Michelino da Besozzo et les
relatiòns entre l’art italien et Vart frangais à l’epoque
dii règne de Charles VI. (Estratto da le Mémoires de
VAccadèmie des inscript, et belles-lettres, t. XXXVIII,
2a parte). — Parigi, MDCCCCXl.
È questo studio del Durrieu un importante contributo
per meglio determinare le relazioni che sulla fine del '300
e all’ inizio del '400 strinsero fra di loro le due scuole pitto-
riche italiana e francese. Gli porge occasione a parlarne un
codice miniato della Biblioteca nazionale di Parigi, del quale
già trattarono Giulio Zappa e Pietro Toesca. La miniatura
nella quale il Durrieu accordandosi con i due precedenti
studiosi, riconosce lo stile di Michelino da Besozzo, rappre-
senta l’Entrata di Giov. Galeazzo in Paradiso. Il Durrieu
con la competenza e la larga cultura che gli son proprie
riesce acutamente a stabilire la derivazione francese di questa
scena, che solo più tardi troviamo accolta da artisti italiani,
i quali certamente l’ebbero o da artisti italiani passati in
Francia, o da artisti francesi venuti in Italia. In tal modo
il Durrieu porge una prova di più,un fatto nuovo a meglio
chiarire quel fenomeno di osmosi che strinse reciproci le-
gami, scambievoli affinità tra l’arté italiana e la francese so-
pratutto dalla fine del xiv secolo ai primi decenni del Quat-
trocento.
28. Filippini (F.), La Cappella dei Notai in San
Petronio. (Giornale del Mattino, 19 dicembre t911 ).
Si era sempre attribuita a Jacopo da Ulma, frate dome-
nicano, la vetrata a colori della Cappella dei Notai in San
Petronio di Bologna, senza tuttavia che alcun documento
probatorio avvalorasse l’attribuzione.
Ora Francesco Filippini da un libro delle spese, della
Società dei Notai, esistente nell’Archivio di Stato di Bologna,
toglie la prova documentata che la direzione e tutta la parte
tecnica della vetrata appartenne di fatto al suddetto frate
Jacopo da Ulma o d’Alemagna; mentre il disegno dei car-
toni si deve ad un collaboratore, cioè a Michele di Matteo
di Panzano nel modenese. Le spese citate vanno dal giorno
19 marzo 1464 al 29 marzo 1466.
Ma in San Petronio i due maestri avevano eseguito già
altre opere, se nel 1463 vi sono nei libri della Fabbrica
note di pagamenti fatti ai medesimi per armi e stemmi da
porsi negli occhi della navata centrale, e per altre sette
finestre. (a. s.).
29. Frizzoni (Gustavo), La raccolta Mond ed opere
attinenti alla medesima. (Rassegna d’arte, XI, 1911,
pag. 25-31, 43-48).
Prende occasione dal libro del Richter sulla raccolta Mond,
per esprimere giudizi sulle pitture della raccolta; pubblica
un San Sebastiano di Cima nella raccolta Berenson* attri-
buisce a Paris Bordone il così detto ritratto d’isabella Gon-
zaga dell’ Ermitage ; al Boltraffio il San Ludovico della rac-
colta Stroganof a Pietroburgo, ecc.
30. Goldschmidt (Fritz), Pontormo, Rosso und
Bronzino. — Leipzig, Klinkhardt, 1911.
Il lavoro che l’autore offre agli studiosi, ricco di parec-
chie tavole illustratile e d’un indice delle composizioni figu-
rate dei tre artisti toscani del Cinquecento, si potrebbe in-
titolare : un capitolo di storia non fatta. Storia di quella
divina proporzione che fu cura fra le maggiori di tutto il
Rinascimento.
Vi vediamo l’inquieta mente del Carrucci, che aveva pur
dipinto quel miracolo di equilibrato aggruppamento a pira-
mide che è l’affresco della Visitazione all’Annunziata di Fi-
renze, e la scena campestre di Poggio a Calano ravvivata
dalla grazia di un precoce rococò, sopprimere ogni ricerca
di paesaggio e di sfondo attorno alle sue figure, ammassare
corpi sopra corpi, solo ricercando con il loro degradare di
dar l’illusione dello spazio e della profondità, non appena
si conobbero i terribili esempi di Michelangelo.
Tutti gli artististi non parvero aver occhi che per il Buo-
narroti. Ma se il Pontormo e il Rosso ne ebbero le idee
scombinate, il Bronzino non si salvò dalla maniera, che solo
gli viene perdonata dai posteri per virtù di quei mirabili
ritratti in cui seppe infondere un’anima eroica veramente
michelangiolesca.
Il lettore si domanderà solo perchè nella storia della pro-
spettiva si sia prescelto un capitolo tanto tardo, rimpiangendo