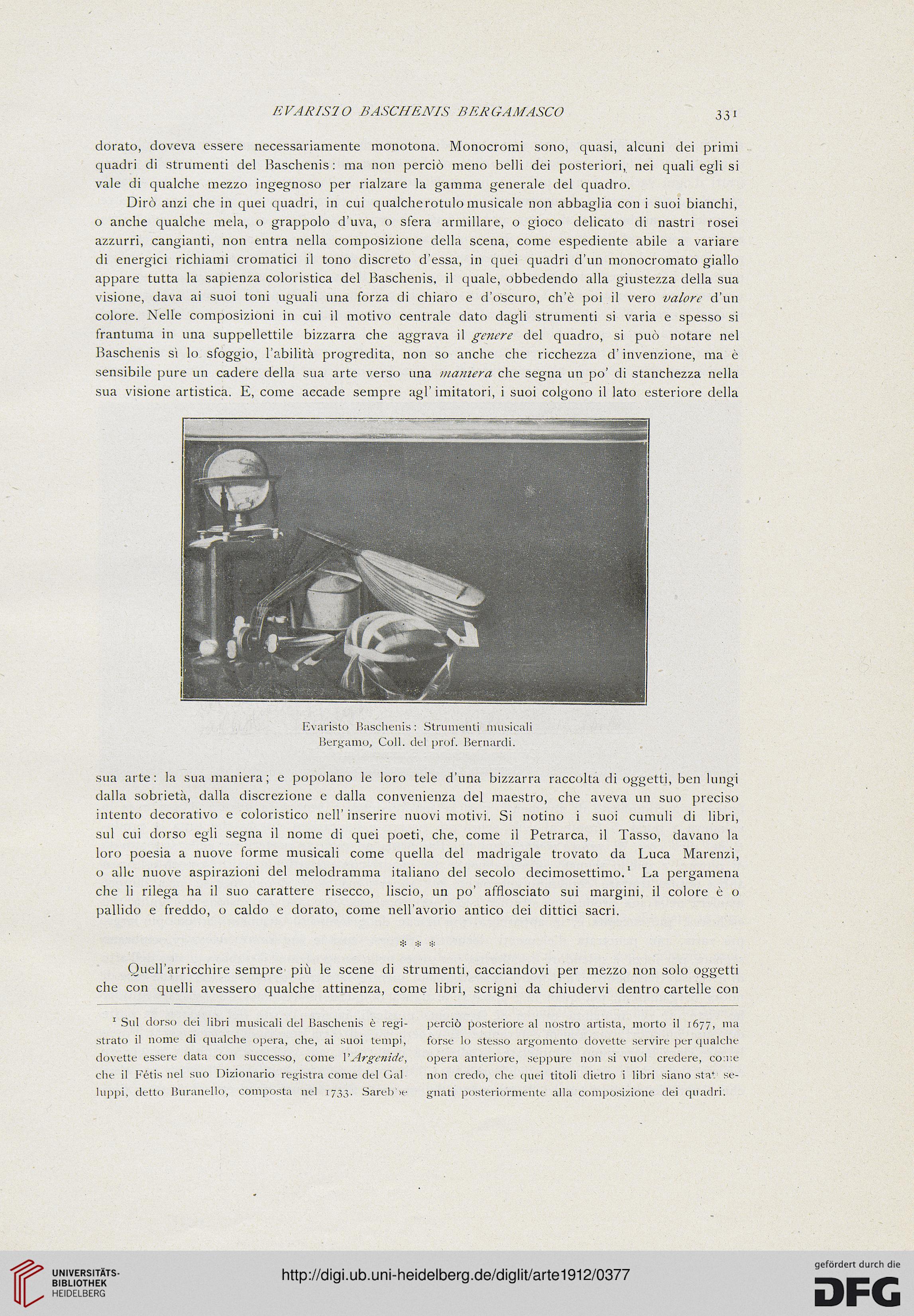EVARI STO BASCHENIS BERGAMASCO
33i
dorato, doveva essere necessariamente monotona. Monocromi sono, quasi, alcuni dei primi
quadri di strumenti del Baschenis : ma non perciò meno belli dei posteriori, nei quali egli si
vale di qualche mezzo ingegnoso per rialzare la gamma generale del quadro.
Dirò anzi che in quei quadri, in cui qualcherotulomusicale non abbaglia con i suoi bianchi,
o anche qualche mela, o grappolo d’uva, o sfera armiilare, o gioco delicato di nastri rosei
azzurri, cangianti, non entra nella composizione della scena, come espediente abile a variare
di energici richiami cromatici il tono discreto d’essa, in quei quadri d’un monocromato giallo
appare tutta la sapienza coloristica del Baschenis, il quale, obbedendo alla giustezza della sua
visione, dava ai suoi toni uguali una forza di chiaro e d’oscuro, ch’è poi il vero valore d’un
colore. Nelle composizioni in cui il motivo centrale dato dagli strumenti si varia e spesso si
frantuma in una suppellettile bizzarra che aggrava il genere del quadro, si può notare nel
Baschenis sì lo sfoggio, l’abilità progredita, non so anche che ricchezza d’invenzione, ma è
sensibile pure un cadere della sua arte verso una marnerà che segna un po’ di stanchezza nella
sua visione artistica. E, come accade sempre agl’ imitatori, i suoi colgono il lato esteriore della
Evaristo Baschenis: Strumenti musicali
Bergamo, Coll, del prof. Bernardi.
sua arte: la sua maniera; e popolano le loro tele d’una bizzarra raccolta di oggetti, ben lungi
dalla sobrietà, dalla discrezione e dalla convenienza del maestro, che aveva un suo preciso
intento decorativo e coloristico nell’ inserire nuovi motivi. Si notino i suoi cumuli di libri,
sul cui dorso egli segna il nome di quei poeti, che, come il Petrarca, il Tasso, davano la
loro poesia a nuove forme musicali come quella del madrigale trovato da Luca Marenzi,
o alle nuove aspirazioni del melodramma italiano del secolo decimosettimo.1 La pergamena
che li rilega ha il suo carattere risecco, liscio, un po’ afflosciato sui margini, il colore è o
pallido e freddo, o caldo e dorato, come nell’avorio antico dei dittici sacri.
* * *
Quell’arricchire sempre più le scene di strumenti, cacciandovi per mezzo non solo oggetti
che con quelli avessero qualche attinenza, come libri, scrigni da chiudervi dentro cartelle con
1 Sul dorso dei libri musicali del Baschenis è regi-
strato il nome di qualche opera, che, ai suoi tempi,
dovette essere data con successo, come VArgenide,
che il Fétis nel suo Dizionario registra come del Gal
luppi, detto Buranello, composta nel 1733. Sarebbe
perciò posteriore al nostro artista, morto il 1677, ma
forse lo stesso argomento dovette servire per qualche
opera anteriore, seppure non si vuol credere, come
non credo, che quei titoli dietro i libri siano stari se-
gnati posteriormente alla composizione dei quadri.
33i
dorato, doveva essere necessariamente monotona. Monocromi sono, quasi, alcuni dei primi
quadri di strumenti del Baschenis : ma non perciò meno belli dei posteriori, nei quali egli si
vale di qualche mezzo ingegnoso per rialzare la gamma generale del quadro.
Dirò anzi che in quei quadri, in cui qualcherotulomusicale non abbaglia con i suoi bianchi,
o anche qualche mela, o grappolo d’uva, o sfera armiilare, o gioco delicato di nastri rosei
azzurri, cangianti, non entra nella composizione della scena, come espediente abile a variare
di energici richiami cromatici il tono discreto d’essa, in quei quadri d’un monocromato giallo
appare tutta la sapienza coloristica del Baschenis, il quale, obbedendo alla giustezza della sua
visione, dava ai suoi toni uguali una forza di chiaro e d’oscuro, ch’è poi il vero valore d’un
colore. Nelle composizioni in cui il motivo centrale dato dagli strumenti si varia e spesso si
frantuma in una suppellettile bizzarra che aggrava il genere del quadro, si può notare nel
Baschenis sì lo sfoggio, l’abilità progredita, non so anche che ricchezza d’invenzione, ma è
sensibile pure un cadere della sua arte verso una marnerà che segna un po’ di stanchezza nella
sua visione artistica. E, come accade sempre agl’ imitatori, i suoi colgono il lato esteriore della
Evaristo Baschenis: Strumenti musicali
Bergamo, Coll, del prof. Bernardi.
sua arte: la sua maniera; e popolano le loro tele d’una bizzarra raccolta di oggetti, ben lungi
dalla sobrietà, dalla discrezione e dalla convenienza del maestro, che aveva un suo preciso
intento decorativo e coloristico nell’ inserire nuovi motivi. Si notino i suoi cumuli di libri,
sul cui dorso egli segna il nome di quei poeti, che, come il Petrarca, il Tasso, davano la
loro poesia a nuove forme musicali come quella del madrigale trovato da Luca Marenzi,
o alle nuove aspirazioni del melodramma italiano del secolo decimosettimo.1 La pergamena
che li rilega ha il suo carattere risecco, liscio, un po’ afflosciato sui margini, il colore è o
pallido e freddo, o caldo e dorato, come nell’avorio antico dei dittici sacri.
* * *
Quell’arricchire sempre più le scene di strumenti, cacciandovi per mezzo non solo oggetti
che con quelli avessero qualche attinenza, come libri, scrigni da chiudervi dentro cartelle con
1 Sul dorso dei libri musicali del Baschenis è regi-
strato il nome di qualche opera, che, ai suoi tempi,
dovette essere data con successo, come VArgenide,
che il Fétis nel suo Dizionario registra come del Gal
luppi, detto Buranello, composta nel 1733. Sarebbe
perciò posteriore al nostro artista, morto il 1677, ma
forse lo stesso argomento dovette servire per qualche
opera anteriore, seppure non si vuol credere, come
non credo, che quei titoli dietro i libri siano stari se-
gnati posteriormente alla composizione dei quadri.