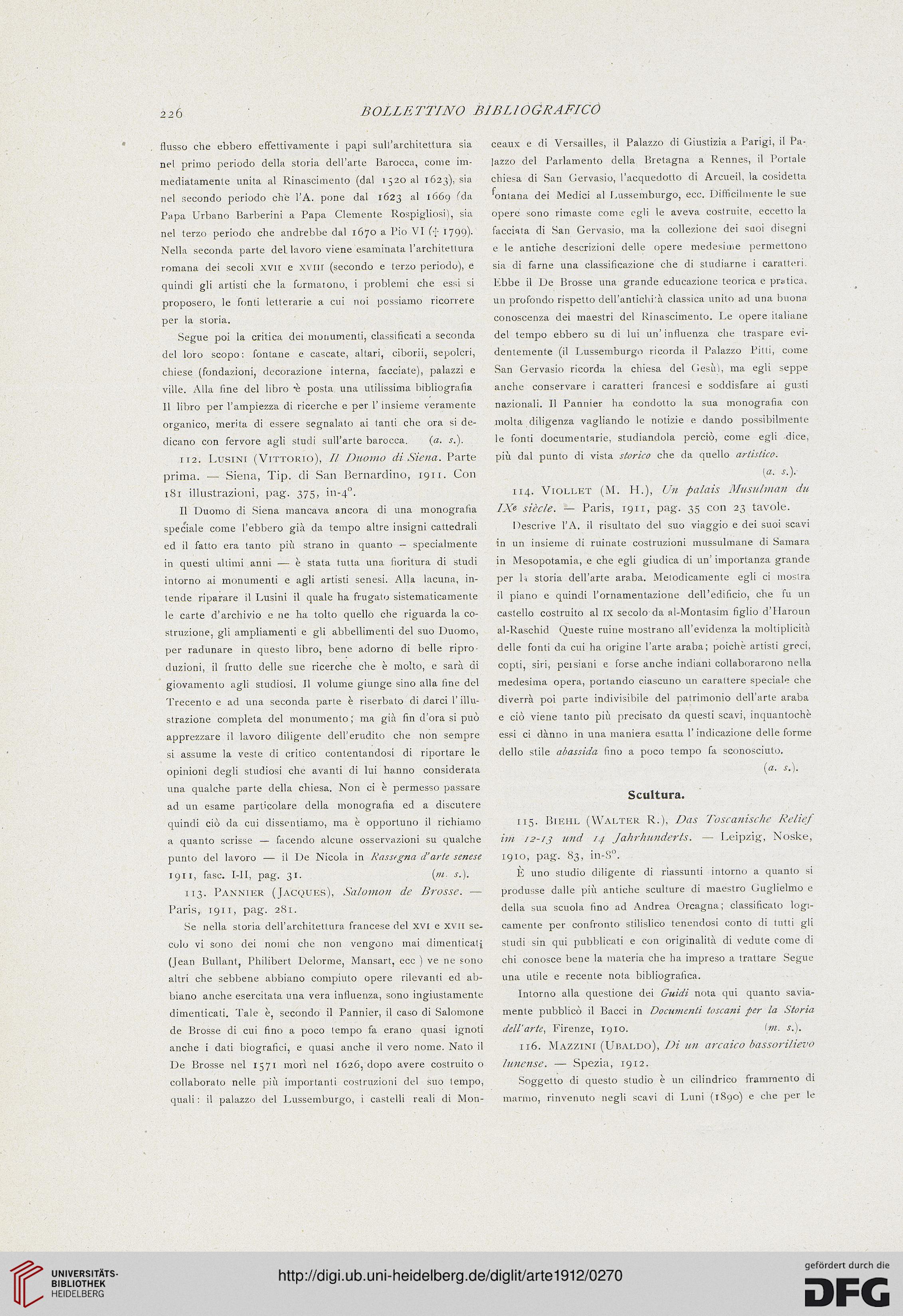22Ó
BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO
flusso che ebbero effettivamente i papi sull’architettura sia
nel primo periodo della storia dell’arte Barocca, come im-
mediatamente unita al Rinascimento (dal 1520 al 1623), sia
nel secondo periodo che l’A. pone dal 1623 al 1669 (da
Papa Urbano Barberini a Papa Clemente Rospigliosi), sia
nel terzo periodo che andrebbe dal 1670 a Pio VI ('•]• 1 799).
Nella seconda parte del lavoro viene esaminata l’architettura
romana dei secoli XV1T e XVIII (secondo e terzo periodo), e
quindi gli artisti che la formarono, i problemi che essi si
proposero, le fonti letterarie a cui noi possiamo ricorrere
per la storia.
Segue poi la critica dei monumenti, classificati a seconda
del loro scopo: fontane e cascate, altari, ciborii, sepolcri,
chiese (fondazioni, decorazione interna, facciate), palazzi e
ville. Alla fine del libro *è posta una utilissima bibliografia
11 libro per l’ampiezza di ricerche e per l’insieme veramente
organico, merita di essere segnalato ai tanti che ora si de-
dicano con fervore agli studi sull’arte barocca. (a. s.).
r r2. Lusini (Vittorio), II Duomo diSiena. Parte
prima. — Siena, Tip. di San Bernardino, 1911. Con
181 illustrazioni, pag. 375, in-40.
Il Duomo di .Siena mancava ancora di una monografia
speciale come l’ebbero già da tempo altre insigni cattedrali
ed il fatto era tanto più strano in quanto — specialmente
in questi ultimi anni — è stata tutta una fioritura di studi
intorno ai monumenti e agli artisti senesi. Alla lacuna, in-
tende riparare il Lusini il quale ha frugato sistematicamente
le carte d’archivio e ne ha tolto quèllo che riguarda la co-
struzione, gli ampliamenti e gli abbellimenti del suo Duomo,
per radunare in questo libro, bene adorno di belle ripro-
duzioni, il frutto delle sue ricerche che è molto, e sarà di
giovamento agli studiosi. Il volume giunge sino alla fine del
Trecento e ad una seconda parte è riserbato di darci l’illu-
strazione completa del monumento ; ma già fin d’ora si può
apprezzare il lavoro diligente dell’erudito che non sèmpre
si assume la veste di critico contentandosi di riportare le
opinioni degli studiosi che avanti di lui hanno considerata
una qualche parte della chiesa. Non ci è permesso passare
ad un esame particolare della monografia ed a discutere
quindi ciò da cui dissentiamo, ma è opportuno il richiamo
a quanto scrisse — facendo alcune osservazioni su qualche
punto del lavoro — il De Nicola in Rassegna d’arte senese
1911, fase. I-1I, pag. 31. (;;/. s.).
113. Pannier (Jacques), Salomon de Brosse. —
Paris, 1911, pag. 281..
Se nella storia dell’architettura francese del xvi e xvil se-
colo vi sono dei nomi che non vengono mai dimenticati
(Jean Bullant, Philibert Delorme, Mansart, ecc ) ve ne sono
altri che sebbene abbiano compiuto opere rilevanti ed ab-
biano anche esercitata una vera influenza, sono ingiustamente
dimenticati. Tale è, secondo il Pannier, il caso di Salomone
de Brosse di cui fino a poco tempo fa erano quasi ignoti
anche i dati biografici, e quasi anche il vero nome. Nato il
De Brosse nel 1571 morì nel 1626, dopo avere costruito o
collaborato nelle più importanti costruzioni del suo tempo,
quali : il palazzo del Lussemburgo, i castelli reali di Mon-
ceaux e di Versailles, il Palazzo di Giustizia a Parigi, il Pa-
lazzo del Parlamento della Bretagna a Rennes, il Portale
chiesa di San Gervasio, l’acquedotto di Arcueil, la cosidetta
fontana dei Medici al Lussemburgo, ecc. Difficilmente le sue
opere sono rimaste come egli le aveva costruite, eccetto la
facciata di San Gervasio, ma la collezione dei suoi disegni
e le antiche descrizioni delle opere medesime permettono
sia di farne una classificazione che di studiarne i caratteri.
Ebbe il De Brosse una grande educazione teorica e pratica,
un profondo rispetto dell’antichità classica unito ad una buona
conoscenza dei maestri del Rinascimento. Le opere italiane
del tempo ebbero su di lui un’ influenza che traspare evi-
dentemente (il Lussemburgo ricorda il Palazzo Pitti, come
San Gervasio ricorda la chiesa del Gesuì, ma egli seppe
anche conservare i caratteri francesi e soddisfare ai gusti
nazionali. Il Pannier ha condotto la sua monografia con
molta diligenza vagliando le notizie e dando possibilmente
le fonti documentarie, studiandola perciò, come egli dice,
più dal punto di vista storico che da quello artistico.
(«• s.).
114. Viollet (M. H.), Un palais Musulman du
IXe siècle. — Paris, 1911, pag. 35 con 23 tavole.
Descrive l’A. il risultato del suo viaggio e dei suoi scavi
in un insieme di minate costruzioni mussulmane di Samara
in Mesopotamia, e che egli giudica di un’ importanza grande
per l-i storia dell’arte araba. Metodicamente egli ci mostra
il piano e quindi l’ornamentazione dell’edificio, che fu un
castello costruito al IX secolo da al-Montasim figlio d’Haroun
al-Raschid Queste mine mostrano all’evidenza la moltiplicità
delle fonti da cui ha origine l’arte araba; poiché artisti greci,
copti, siri, peisiani e forse anche indiani collaborarono nella
medesima opera, portando ciascuno un carattere speciale che
diverrà poi parte indivisibile del patrimonio dell’arte araba
e ciò viene tanto più precisato da questi scavi, inquantochè
essi ci dànno in una maniera esatta l’indicazione delle forme
dello stile abassida fino a poco tempo fa sconosciuto.
(a. s.).
Scultura.
115. Biehl (Walter R.), Das Toscanische Relief
im 12-13 und 24 Jahrhunderts. — Leipzig, Noske,
1910, pag. 83, in-S°.
È uno studio diligente di riassunti intorno a quanto si
produsse dalle più antiche sculture di maestro Guglielmo e
della sua scuola fino ad Andrea Orcagna; classificato logi-
camente per confronto stilislico tenendosi conto di tutti gli
studi sin qui pubblicati e con originalità di vedute come di
chi conosce bene la materia che ha impreso a trattare Segue
una utile e recente nota bibliografica.
Intorno alla questione dei Guidi nota qui quanto savia-
mente pubblicò il Bacci in Documenti toscani per la Storia
dell'arte, Firenze, 1910. (m. s.).
116. MAZZiNr (Uhaldo), Di un arcaico bassorilievo
Iintense. — Spezia, 1912.
Soggetto di questo studio è un cilindrico frammento di
marmo, rinvenuto negli scavi di Luni (1890) e che per le
BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO
flusso che ebbero effettivamente i papi sull’architettura sia
nel primo periodo della storia dell’arte Barocca, come im-
mediatamente unita al Rinascimento (dal 1520 al 1623), sia
nel secondo periodo che l’A. pone dal 1623 al 1669 (da
Papa Urbano Barberini a Papa Clemente Rospigliosi), sia
nel terzo periodo che andrebbe dal 1670 a Pio VI ('•]• 1 799).
Nella seconda parte del lavoro viene esaminata l’architettura
romana dei secoli XV1T e XVIII (secondo e terzo periodo), e
quindi gli artisti che la formarono, i problemi che essi si
proposero, le fonti letterarie a cui noi possiamo ricorrere
per la storia.
Segue poi la critica dei monumenti, classificati a seconda
del loro scopo: fontane e cascate, altari, ciborii, sepolcri,
chiese (fondazioni, decorazione interna, facciate), palazzi e
ville. Alla fine del libro *è posta una utilissima bibliografia
11 libro per l’ampiezza di ricerche e per l’insieme veramente
organico, merita di essere segnalato ai tanti che ora si de-
dicano con fervore agli studi sull’arte barocca. (a. s.).
r r2. Lusini (Vittorio), II Duomo diSiena. Parte
prima. — Siena, Tip. di San Bernardino, 1911. Con
181 illustrazioni, pag. 375, in-40.
Il Duomo di .Siena mancava ancora di una monografia
speciale come l’ebbero già da tempo altre insigni cattedrali
ed il fatto era tanto più strano in quanto — specialmente
in questi ultimi anni — è stata tutta una fioritura di studi
intorno ai monumenti e agli artisti senesi. Alla lacuna, in-
tende riparare il Lusini il quale ha frugato sistematicamente
le carte d’archivio e ne ha tolto quèllo che riguarda la co-
struzione, gli ampliamenti e gli abbellimenti del suo Duomo,
per radunare in questo libro, bene adorno di belle ripro-
duzioni, il frutto delle sue ricerche che è molto, e sarà di
giovamento agli studiosi. Il volume giunge sino alla fine del
Trecento e ad una seconda parte è riserbato di darci l’illu-
strazione completa del monumento ; ma già fin d’ora si può
apprezzare il lavoro diligente dell’erudito che non sèmpre
si assume la veste di critico contentandosi di riportare le
opinioni degli studiosi che avanti di lui hanno considerata
una qualche parte della chiesa. Non ci è permesso passare
ad un esame particolare della monografia ed a discutere
quindi ciò da cui dissentiamo, ma è opportuno il richiamo
a quanto scrisse — facendo alcune osservazioni su qualche
punto del lavoro — il De Nicola in Rassegna d’arte senese
1911, fase. I-1I, pag. 31. (;;/. s.).
113. Pannier (Jacques), Salomon de Brosse. —
Paris, 1911, pag. 281..
Se nella storia dell’architettura francese del xvi e xvil se-
colo vi sono dei nomi che non vengono mai dimenticati
(Jean Bullant, Philibert Delorme, Mansart, ecc ) ve ne sono
altri che sebbene abbiano compiuto opere rilevanti ed ab-
biano anche esercitata una vera influenza, sono ingiustamente
dimenticati. Tale è, secondo il Pannier, il caso di Salomone
de Brosse di cui fino a poco tempo fa erano quasi ignoti
anche i dati biografici, e quasi anche il vero nome. Nato il
De Brosse nel 1571 morì nel 1626, dopo avere costruito o
collaborato nelle più importanti costruzioni del suo tempo,
quali : il palazzo del Lussemburgo, i castelli reali di Mon-
ceaux e di Versailles, il Palazzo di Giustizia a Parigi, il Pa-
lazzo del Parlamento della Bretagna a Rennes, il Portale
chiesa di San Gervasio, l’acquedotto di Arcueil, la cosidetta
fontana dei Medici al Lussemburgo, ecc. Difficilmente le sue
opere sono rimaste come egli le aveva costruite, eccetto la
facciata di San Gervasio, ma la collezione dei suoi disegni
e le antiche descrizioni delle opere medesime permettono
sia di farne una classificazione che di studiarne i caratteri.
Ebbe il De Brosse una grande educazione teorica e pratica,
un profondo rispetto dell’antichità classica unito ad una buona
conoscenza dei maestri del Rinascimento. Le opere italiane
del tempo ebbero su di lui un’ influenza che traspare evi-
dentemente (il Lussemburgo ricorda il Palazzo Pitti, come
San Gervasio ricorda la chiesa del Gesuì, ma egli seppe
anche conservare i caratteri francesi e soddisfare ai gusti
nazionali. Il Pannier ha condotto la sua monografia con
molta diligenza vagliando le notizie e dando possibilmente
le fonti documentarie, studiandola perciò, come egli dice,
più dal punto di vista storico che da quello artistico.
(«• s.).
114. Viollet (M. H.), Un palais Musulman du
IXe siècle. — Paris, 1911, pag. 35 con 23 tavole.
Descrive l’A. il risultato del suo viaggio e dei suoi scavi
in un insieme di minate costruzioni mussulmane di Samara
in Mesopotamia, e che egli giudica di un’ importanza grande
per l-i storia dell’arte araba. Metodicamente egli ci mostra
il piano e quindi l’ornamentazione dell’edificio, che fu un
castello costruito al IX secolo da al-Montasim figlio d’Haroun
al-Raschid Queste mine mostrano all’evidenza la moltiplicità
delle fonti da cui ha origine l’arte araba; poiché artisti greci,
copti, siri, peisiani e forse anche indiani collaborarono nella
medesima opera, portando ciascuno un carattere speciale che
diverrà poi parte indivisibile del patrimonio dell’arte araba
e ciò viene tanto più precisato da questi scavi, inquantochè
essi ci dànno in una maniera esatta l’indicazione delle forme
dello stile abassida fino a poco tempo fa sconosciuto.
(a. s.).
Scultura.
115. Biehl (Walter R.), Das Toscanische Relief
im 12-13 und 24 Jahrhunderts. — Leipzig, Noske,
1910, pag. 83, in-S°.
È uno studio diligente di riassunti intorno a quanto si
produsse dalle più antiche sculture di maestro Guglielmo e
della sua scuola fino ad Andrea Orcagna; classificato logi-
camente per confronto stilislico tenendosi conto di tutti gli
studi sin qui pubblicati e con originalità di vedute come di
chi conosce bene la materia che ha impreso a trattare Segue
una utile e recente nota bibliografica.
Intorno alla questione dei Guidi nota qui quanto savia-
mente pubblicò il Bacci in Documenti toscani per la Storia
dell'arte, Firenze, 1910. (m. s.).
116. MAZZiNr (Uhaldo), Di un arcaico bassorilievo
Iintense. — Spezia, 1912.
Soggetto di questo studio è un cilindrico frammento di
marmo, rinvenuto negli scavi di Luni (1890) e che per le