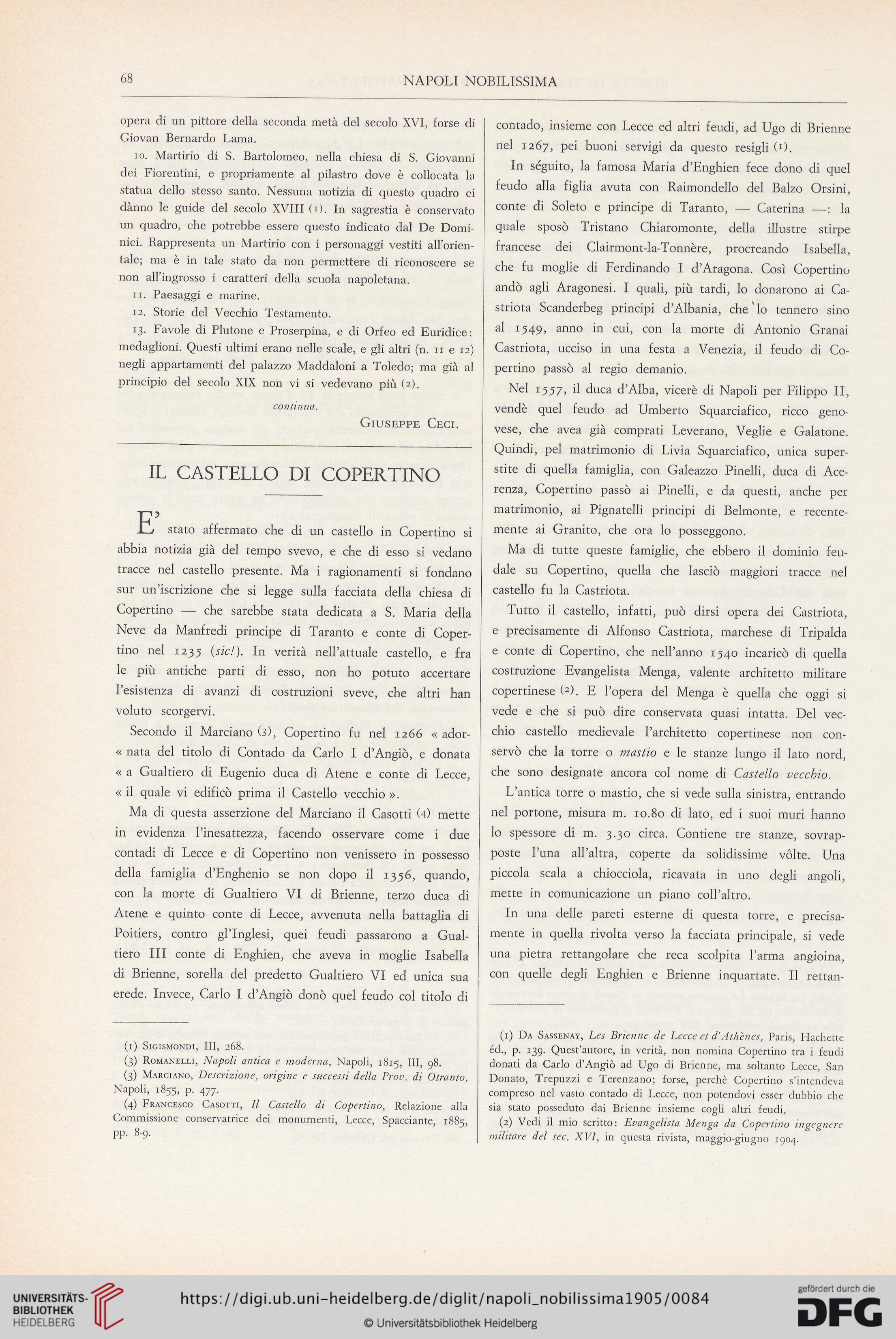68
NAPOLI NOBILISSIMA
opera di un pittore della seconda metà del secolo XVI, forse di
Giovan Bernardo Lama.
io. Martirio di S. Bartolomeo, nella chiesa di S. Giovanni
dei Fiorentini, e propriamente al pilastro dove è collocata la
statua dello stesso santo. Nessuna notizia di questo quadro ci
dànno le guide del secolo XVIII (i). In sagrestia è conservato
un quadro, che potrebbe essere questo indicato dal De Domi-
nici. Rappresenta un Martirio con i personaggi vestiti all'orien-
tale; ma è in tale stato da non permettere di riconoscere se
non all'ingrosso i caratteri della scuola napoletana.
II. Paesaggi e marine.
12. Storie del Vecchio Testamento.
13. Favole di Plutone e Proserpina, e di Orfeo ed Euridice:
medaglioni. Questi ultimi erano nelle scale, e gli altri (n. 11 e 12)
negli appartamenti del palazzo Maddaloni a Toledo; ma già al
principio del secolo XIX non vi si vedevano più (2).
continua.
Giuseppe Ceci.
IL CASTELLO DI COPERTINO
E stato affermato che di un castello in Copertino si
abbia notizia già del tempo svevo, e che di esso si vedano
tracce nel castello presente. Ma i ragionamenti si fondano
sur un'iscrizione che si legge sulla facciata della chiesa di
Copertino — che sarebbe stata dedicata a S. Maria della
Neve da Manfredi principe di Taranto e conte di Coper-
tino nel 1235 (sic!). In verità nell'attuale castello, e fra
le più antiche parti di esso, non ho potuto accertare
l'esistenza di avanzi di costruzioni sveve, che altri han
voluto scorgervi.
Secondo il Marciano (3), Copertino fu nel 1266 « ador-
« nata del titolo di Contado da Carlo I d'Angiò, e donata
«a Gualtiero di Eugenio duca di Atene e conte di Lecce,
« il quale vi edificò prima il Castello vecchio ».
Ma di questa asserzione del Marciano il Casotti (4) mette
in evidenza l'inesattezza, facendo osservare come i due
contadi di Lecce e di Copertino non venissero in possesso
della famiglia d'Enghenio se non dopo il 1356, quando,
con la morte di Gualtiero VI di Brienne, terzo duca di
Atene e quinto conte di Lecce, avvenuta nella battaglia di
Poitiers, contro gl'Inglesi, quei feudi passarono a Gual-
tiero III conte di Enghien, che aveva in moglie Isabella
di Brienne, sorella del predetto Gualtiero VI ed unica sua
erede. Invece, Carlo I d'Angiò donò quel feudo col titolo di
contado, insieme con Lecce ed altri feudi, ad Ugo di Brienne
nel 1267, pei buoni servigi da questo resigli 0).
In séguito, la famosa Maria d'Enghien fece dono di quel
feudo alla figlia avuta con Raimondello del Balzo Orsini,
conte di Soleto e principe di Taranto, — Caterina —: la
quale sposò Tristano Chiaromonte, della illustre stirpe
francese dei Clairmont-la-Tonnère, procreando Isabella,
che fu moglie di Ferdinando I d'Aragona. Così Copertino
andò agli Aragonesi. I quali, più tardi, lo donarono ai Ca-
striota Scanderbeg principi d'Albania, che lo tennero sino
al 1549, anno in cui, con la morte di Antonio Granai
Castriota, ucciso in una festa a Venezia, il feudo di Co-
pertino passò al regio demanio.
Nel 1557, il duca d'Alba, vicerè di Napoli per Filippo II,
vendè quel feudo ad Umberto Squarciafico, ricco geno-
vese, che avea già comprati Leverano, Veglie e Galatone.
Quindi, pel matrimonio di Livia Squarciafico, unica super-
stite di quella famiglia, con Galeazzo Pinelli, duca di Ace-
renza, Copertino passò ai Pinelli, e da questi, anche per
matrimonio, ai Pignatelli principi di Belmonte, e recente-
mente ai Granito, che ora lo posseggono.
Ma di tutte queste famiglie, che ebbero il dominio feu-
dale su Copertino, quella che lasciò maggiori tracce nel
castello fu la Castriota.
Tutto il castello, infatti, può dirsi opera dei Castriota,
e precisamente di Alfonso Castriota, marchese di Tripalda
e conte di Copertino, che nell'anno 1,40 incaricò di quella
costruzione Evangelista Menga, valente architetto militare
copertinese (2). E l'opera del Menga è quella che oggi si
vede e che si può dire conservata quasi intatta. Del vec-
chio castello medievale l'architetto copertinese non con-
servò che la torre o mastio e le stanze lungo il lato nord,
che sono designate ancora col nome di Castello vecchio.
L'antica torre o mastio, che si vede sulla sinistra, entrando
nel portone, misura m. 10.80 di lato, ed i suoi muri hanno
lo spessore di m. 3.30 circa. Contiene tre stanze, sovrap-
poste l'una all'altra, coperte da solidissime volte. Una
piccola scala a chiocciola, ricavata in uno degli angoli,
mette in comunicazione un piano coll'altro.
In una delle pareti esterne di questa torre, e precisa-
mente in quella rivolta verso la facciata principale, si vede
una pietra rettangolare che reca scolpita l'arma angioina,
con quelle degli Enghien e Brienne inquartate. Il rettan-
(l) SIGISMONDI, III, 268.
(3) Romanelli, Napoli antica e moderna, Napoli, 1815, III, 98.
(3) Marciano, Descrizione, origine e successi della Prov. di Otranto,
Napoli, 1855, p. 477.
(4) Francesco Casotti, Il Castello di Copertino, Relazione alla
Commissione conservatrice dei monumenti, Lecce, Spacciante, 1885,
pp. 8-9.
(1) Da Sassenay, Les Brienne de Lecce et d'Athènes, Paris, Hachette
éd., p. 139. Quest'autore, in verità, non nomina Copertino tra i feudi
donati da Carlo d'Angiò ad Ugo di Brienne, ma soltanto Lecce, San
Donato, Trepuzzi e Terenzano; forse, perchè Copertino s'intendeva
compreso nel vasto contado di Lecce, non potendovi esser dubbio che
sia stato posseduto dai Brienne insieme cogli altri feudi.
(2) Vedi il mio scritto: Evangelista Menga da Copertino ingegnere
militare del sec. XVI, in questa rivista, maggio-giugno 1904.
NAPOLI NOBILISSIMA
opera di un pittore della seconda metà del secolo XVI, forse di
Giovan Bernardo Lama.
io. Martirio di S. Bartolomeo, nella chiesa di S. Giovanni
dei Fiorentini, e propriamente al pilastro dove è collocata la
statua dello stesso santo. Nessuna notizia di questo quadro ci
dànno le guide del secolo XVIII (i). In sagrestia è conservato
un quadro, che potrebbe essere questo indicato dal De Domi-
nici. Rappresenta un Martirio con i personaggi vestiti all'orien-
tale; ma è in tale stato da non permettere di riconoscere se
non all'ingrosso i caratteri della scuola napoletana.
II. Paesaggi e marine.
12. Storie del Vecchio Testamento.
13. Favole di Plutone e Proserpina, e di Orfeo ed Euridice:
medaglioni. Questi ultimi erano nelle scale, e gli altri (n. 11 e 12)
negli appartamenti del palazzo Maddaloni a Toledo; ma già al
principio del secolo XIX non vi si vedevano più (2).
continua.
Giuseppe Ceci.
IL CASTELLO DI COPERTINO
E stato affermato che di un castello in Copertino si
abbia notizia già del tempo svevo, e che di esso si vedano
tracce nel castello presente. Ma i ragionamenti si fondano
sur un'iscrizione che si legge sulla facciata della chiesa di
Copertino — che sarebbe stata dedicata a S. Maria della
Neve da Manfredi principe di Taranto e conte di Coper-
tino nel 1235 (sic!). In verità nell'attuale castello, e fra
le più antiche parti di esso, non ho potuto accertare
l'esistenza di avanzi di costruzioni sveve, che altri han
voluto scorgervi.
Secondo il Marciano (3), Copertino fu nel 1266 « ador-
« nata del titolo di Contado da Carlo I d'Angiò, e donata
«a Gualtiero di Eugenio duca di Atene e conte di Lecce,
« il quale vi edificò prima il Castello vecchio ».
Ma di questa asserzione del Marciano il Casotti (4) mette
in evidenza l'inesattezza, facendo osservare come i due
contadi di Lecce e di Copertino non venissero in possesso
della famiglia d'Enghenio se non dopo il 1356, quando,
con la morte di Gualtiero VI di Brienne, terzo duca di
Atene e quinto conte di Lecce, avvenuta nella battaglia di
Poitiers, contro gl'Inglesi, quei feudi passarono a Gual-
tiero III conte di Enghien, che aveva in moglie Isabella
di Brienne, sorella del predetto Gualtiero VI ed unica sua
erede. Invece, Carlo I d'Angiò donò quel feudo col titolo di
contado, insieme con Lecce ed altri feudi, ad Ugo di Brienne
nel 1267, pei buoni servigi da questo resigli 0).
In séguito, la famosa Maria d'Enghien fece dono di quel
feudo alla figlia avuta con Raimondello del Balzo Orsini,
conte di Soleto e principe di Taranto, — Caterina —: la
quale sposò Tristano Chiaromonte, della illustre stirpe
francese dei Clairmont-la-Tonnère, procreando Isabella,
che fu moglie di Ferdinando I d'Aragona. Così Copertino
andò agli Aragonesi. I quali, più tardi, lo donarono ai Ca-
striota Scanderbeg principi d'Albania, che lo tennero sino
al 1549, anno in cui, con la morte di Antonio Granai
Castriota, ucciso in una festa a Venezia, il feudo di Co-
pertino passò al regio demanio.
Nel 1557, il duca d'Alba, vicerè di Napoli per Filippo II,
vendè quel feudo ad Umberto Squarciafico, ricco geno-
vese, che avea già comprati Leverano, Veglie e Galatone.
Quindi, pel matrimonio di Livia Squarciafico, unica super-
stite di quella famiglia, con Galeazzo Pinelli, duca di Ace-
renza, Copertino passò ai Pinelli, e da questi, anche per
matrimonio, ai Pignatelli principi di Belmonte, e recente-
mente ai Granito, che ora lo posseggono.
Ma di tutte queste famiglie, che ebbero il dominio feu-
dale su Copertino, quella che lasciò maggiori tracce nel
castello fu la Castriota.
Tutto il castello, infatti, può dirsi opera dei Castriota,
e precisamente di Alfonso Castriota, marchese di Tripalda
e conte di Copertino, che nell'anno 1,40 incaricò di quella
costruzione Evangelista Menga, valente architetto militare
copertinese (2). E l'opera del Menga è quella che oggi si
vede e che si può dire conservata quasi intatta. Del vec-
chio castello medievale l'architetto copertinese non con-
servò che la torre o mastio e le stanze lungo il lato nord,
che sono designate ancora col nome di Castello vecchio.
L'antica torre o mastio, che si vede sulla sinistra, entrando
nel portone, misura m. 10.80 di lato, ed i suoi muri hanno
lo spessore di m. 3.30 circa. Contiene tre stanze, sovrap-
poste l'una all'altra, coperte da solidissime volte. Una
piccola scala a chiocciola, ricavata in uno degli angoli,
mette in comunicazione un piano coll'altro.
In una delle pareti esterne di questa torre, e precisa-
mente in quella rivolta verso la facciata principale, si vede
una pietra rettangolare che reca scolpita l'arma angioina,
con quelle degli Enghien e Brienne inquartate. Il rettan-
(l) SIGISMONDI, III, 268.
(3) Romanelli, Napoli antica e moderna, Napoli, 1815, III, 98.
(3) Marciano, Descrizione, origine e successi della Prov. di Otranto,
Napoli, 1855, p. 477.
(4) Francesco Casotti, Il Castello di Copertino, Relazione alla
Commissione conservatrice dei monumenti, Lecce, Spacciante, 1885,
pp. 8-9.
(1) Da Sassenay, Les Brienne de Lecce et d'Athènes, Paris, Hachette
éd., p. 139. Quest'autore, in verità, non nomina Copertino tra i feudi
donati da Carlo d'Angiò ad Ugo di Brienne, ma soltanto Lecce, San
Donato, Trepuzzi e Terenzano; forse, perchè Copertino s'intendeva
compreso nel vasto contado di Lecce, non potendovi esser dubbio che
sia stato posseduto dai Brienne insieme cogli altri feudi.
(2) Vedi il mio scritto: Evangelista Menga da Copertino ingegnere
militare del sec. XVI, in questa rivista, maggio-giugno 1904.